O DELLA TRADUZIONE DI PAROLE PER LO SPETTACOLO
di Luca Scarlini
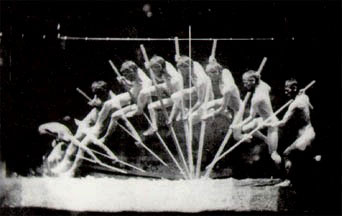 Sto ascoltando la brava Monica Bacelli, che interpreta, ben accompagnata da Aldo Orvieto, la trascrizione del meraviglioso Lamento di Arianna di Monteverdi, adattato a inizio Novecento da Ottorino Respighi (cd Stradivarius). Il gusto Art Nouveau di quell’autore era indigesto ai paladini della riscoperta della filologia degli strumenti antichi negli anni sessanta, ma ora torna all’attenzione e si rivela interessante per quelle stesse caratteristiche prima poco amate. Quella bellissima aria, la cui materia musicale nel tempo ha assunto diversa veste e sostanza, mi serve come paradigma della parola dinamica della scena, che continuamente cambia e muta, con rapidità assai maggiore di quanto non accada nei territori letterari.
Sto ascoltando la brava Monica Bacelli, che interpreta, ben accompagnata da Aldo Orvieto, la trascrizione del meraviglioso Lamento di Arianna di Monteverdi, adattato a inizio Novecento da Ottorino Respighi (cd Stradivarius). Il gusto Art Nouveau di quell’autore era indigesto ai paladini della riscoperta della filologia degli strumenti antichi negli anni sessanta, ma ora torna all’attenzione e si rivela interessante per quelle stesse caratteristiche prima poco amate. Quella bellissima aria, la cui materia musicale nel tempo ha assunto diversa veste e sostanza, mi serve come paradigma della parola dinamica della scena, che continuamente cambia e muta, con rapidità assai maggiore di quanto non accada nei territori letterari.
Infatti la polvere di palcoscenico usura più rapidamente il verbo di quanto non accada ai romanzi, che sono protetti dal costo assai più alto di realizzazione e da una certa monumentalità di ricezione, che si infrange meno, malgrado siamo trionfalmente entrati nell’era del kindler. Spesso le pièces contemporanee, per quanto difficili, sono brevi; quindi, sia pure in una crisi grave, dove le compagnie e i teatri davvero in Italia hanno vita grama, si pone sovente il problema di una diversa resa. Naturalmente se non ci sono problemi di copyright (come avviene in modo notorio nel caso di Samuel Beckett o Tennessee Williams) che inibiscono nuove imprese. L’impatto in palcoscenico è più diretto: se i dialoghi “non rendono” o sono “letterari”, gli attori si impacciano, la lingua si torce e stride: bisogna trovare altri lemmi e diversi giri di frase. Non che chi recita abbia necessariamente ragione; spesso gli stereotipi hanno un peso rilevante, ma la sua voce ha rilievo forte come cartina di tornasole della trama di parole prescelta.
La nuova drammaturgia si confronta in genere con idiomi gergali di ogni tipo e categoria. Il repertorio anglosassone usa virtuosisticamente lo slang, come quello francofono gioca con l’argot, che è ormai pieno di parole americane (per cui ad esempio boulot è diventato job). In Italia, al di fuori di alcuni progetti meritori e circuiti di interesse, limitati per risorse e quantità, l’attenzione è assai limitata. I grandi teatri dedicano poca attenzione al nuovo, preferendo il classico rivisitato (possibilmente in chiave pop) o le suggestioni dell’adattamento dal cinema, particolarmente gettonate nelle ultime stagioni.
In ogni caso ogni lemma scelto viene sottoposto all’esercizio: nei tempi lunghi delle tournées, quando capitano ormai non troppo spesso, gli attori capitalizzano la propria esperienza. Quando il pubblico ride, allora un certo termine, o anche un modo di dire, una cadenza dialettale o un gag gestuale si connettono alla traduzione e la mutano. Lo stesso vale per momenti di tensione drammatica, o per pause efficaci. Il verbo diviene quindi opera collettiva, multipla, aperta, stratificata: coloro che credono alla consegna di poter apporre i sigilli di ceralacca della compiutezza restano delusi, scornati e spesso si disamorano.
Shakespeare comunque nel repertorio nazionale è il maggior campo di battaglia. Altrimenti si registra come sola presenza continua di classico il solo Goldoni, geniale e crudele in tutte le sue tre lingue (francese, italiano e veneziano), restando Alfieri, Aretino, Machiavelli confinati a eventi di risonanza locale o al cash and carry degli anniversari. Il Bardo rimane il maggior campo di battaglia, anche perché per la natura stessa del corpus, non si potrà trattare facilmente di versioni “corrette”. Non c’è pièce che non sia manipolata, adattata: non è solo una questione oggettiva di lunghezze ormai non più gestibili e di strepitose tirate, ma anche della concrezione di attese che udito e cervello rendono ineludibili. Basti dire della crux costituita da «essere o non essere». Anni fa, per un’edizione sperimentale firmata da Federico Tiezzi, Mario Luzi propose un più sintetico «essere o no». Il pubblico, sia pure in un contesto di invenzione, restava sorpreso, sembrava che mancasse un pezzo. Un segmento dell’immaginazione shakespeariana nazionale, peraltro, ha trovato a lungo la propria radice, fortissima, negli adattamenti melodrammatici di Francesco Maria Piave per Verdi. Gli attori, poi, hanno cominciato a firmare loro versioni, che spesso sono adattamenti di altre preesistenti, così da poter godere di una SIAE cospicua e di una autorialità a tutto tondo.
Si apre una finestra sulla mail nell’android: è la presentazione di un Riccardo II (titolo abbastanza raro da noi, e quindi curioso), di una giovane compagnia romana. Vanno in scena in un centro sociale, all’interno di una stagione dedicata alla politica e alla sua rappresentazione. C’è un pop-up e spunta fuori, come il jolly da una scatola a molla, Sid Vicious intento a fare a pezzi genialmente My way, nel celebre video in cui spara al culmine dell’esecuzione alle signore impellicciate e ai loro compagni nel pubblico. Mentre le urla invadono il teatro, risale lentamente le scale luminose. Anche quello è un geniale adattamento e traduzione di parole da una lingua (l’americano dei crooner anni quaranta) all’altra (lo slang violento dei punk inglesi). Una traduzione scenica geniale e senza cambiare nemmeno una parola, ma solo in virtù dell’interpretazione. La parola dinamica è insomma il cuore stesso della versione per il teatro: non ama le regole, ma favorisce le eccezioni, e si sintonizza infine sul respiro, sulle pause, sul fiato degli interpreti che a quelle parole dovranno dare corpo.