di Gianfranco Petrillo
A proposito di: La circolazione del sapere nei processi traduttivi della lingua letteraria tedesca, a cura di Raul Calzoni, Sesto San Giovanni, Mimesis, 2018, pp. 201, € 18,00
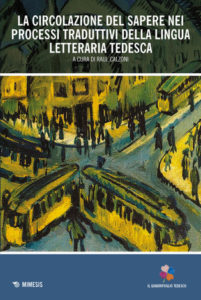 Non inganni il titolo pesante e forse evitabile. I saggi qui raccolti coprono un ampio ventaglio di questioni attinenti la traduzione letteraria in ambito germanofono. Basti dire che ad aprire il volume, dopo la ricognizione dei temi svolta nell’introduzione dal curatore, stanno le Riflessioni di una traduttrice letteraria (pp. 23-38), di Ada Vigliani, che indica l’indispensabilità della traduzione nel colloquio nel tempo e nello spazio fra gli autori, citando l’omaggio del “suo” autore più amato, Sebald, all’operazione compiuta da Edward FitzGerald nel far conoscere agli occidentali la poesia di Omar Khayyām (pp. 34-35). Vigliani è riuscita negli anni, «con pazienza davvero certosina», a stabilire una rete di collegamenti – e, con gli anni, di amicizie – fra tutti i traduttori di Sebald sparsi per il mondo (p. 37). Si va al di là dello scambio di informazioni linguistiche e anche del “sapere”: si va al cuore della “personalità” delle lingue letterarie e dei popoli. È quello che avviene anche nei seminari «Vice-versa» che si tengono in Svizzera, a Looren, e nei regolari incontri periodici fra traduttori tedeschi dall’italiano e italiani dal tedesco con sede all’ Europäisches Übersetzen-Kollegium di Straelen (pp. 36-37).
Non inganni il titolo pesante e forse evitabile. I saggi qui raccolti coprono un ampio ventaglio di questioni attinenti la traduzione letteraria in ambito germanofono. Basti dire che ad aprire il volume, dopo la ricognizione dei temi svolta nell’introduzione dal curatore, stanno le Riflessioni di una traduttrice letteraria (pp. 23-38), di Ada Vigliani, che indica l’indispensabilità della traduzione nel colloquio nel tempo e nello spazio fra gli autori, citando l’omaggio del “suo” autore più amato, Sebald, all’operazione compiuta da Edward FitzGerald nel far conoscere agli occidentali la poesia di Omar Khayyām (pp. 34-35). Vigliani è riuscita negli anni, «con pazienza davvero certosina», a stabilire una rete di collegamenti – e, con gli anni, di amicizie – fra tutti i traduttori di Sebald sparsi per il mondo (p. 37). Si va al di là dello scambio di informazioni linguistiche e anche del “sapere”: si va al cuore della “personalità” delle lingue letterarie e dei popoli. È quello che avviene anche nei seminari «Vice-versa» che si tengono in Svizzera, a Looren, e nei regolari incontri periodici fra traduttori tedeschi dall’italiano e italiani dal tedesco con sede all’ Europäisches Übersetzen-Kollegium di Straelen (pp. 36-37).
Voglio sottolineare qui l’eccezionale importanza dell’esperienza editoriale su cui – dopo la consueta, e ormai stucchevole, genuflessioncella d’uso ai classici della traduttologia – si sofferma approfonditamente Laura Balbiani (pp. 39-60): la collana «Il pensiero occidentale» ideata nel 2000, e diretta fino alla morte, nel 2014, da Giovanni Reale presso Bompiani. L’importanza consiste nel testo a fronte – già raro per i testi letterari, ma addirittura unico nella saggistica – e nella nota o avvertenza con cui il traduttore può chiarire al lettore il suo obiettivo e le difficoltà incontrate, superate e non. Sul modello di quella collana Bompiani lanciò poi anche – osservo io – i «Classici della letteratura europea», diretti da Nuccio Ordine (e vien da chiedersi se non siano state anche iniziative così coraggiose a mettere in definitiva difficoltà la casa editrice). Nella collana il numero di titoli tradotti dal tedesco, 55, analizzati da Balbiani, è inferiore, di poco, solo a quelli dal greco. Ma Balbiani esamina tutto il massiccio corpus della collana (224 titoli fino al 2016) per un’analisi quantitativa delle singole lingue di partenza (pp. 43-44) e quindi soffermarsi sul «nuovo genere di testo» costituito dalla Nota o Avvertenza riservata al traduttore e infine constatare la ritrosia con cui i traduttori approfittano dell’occasione per entrare davvero nel merito del proprio lavoro invece che del testo o, più spesso, dell’autore tradotto (pp. 44-56). Conclude l’articolo la descrizione analitica del corpus.
Il contributo di Lucia Salvato (pp. 61-78) è analitico: si concentra sull’opera di Wolfgang Hildesheimer quale traduttore (tedesco-inglese e viceversa) sia di testi altrui che di testi propri; analisi molto istruttiva, che – nel rilevare l’estrema libertà delle scelte – conduce alla conferma del motivo di fondo dell’intraducibilità.
Più inerente all’idea di «circolazione del sapere» il saggio di Guglielmo Gabbiadini (pp. 79-96), che ricostruisce l’iter in territorio germanofono del nesso morale-politica, fondamento della Bürgertugend, cioè la «virtù civica», instaurato dai giacobini. Protagonista di queste pagine è, di fatto, Friedrich Gentz (1764-1832), che, dopo aver tradotto Robespierre, andò sempre più spostandosi – diremmo oggi – a destra, prima traducendo anche Edmund Burke e poi entrando a lavorare nella cancelleria di Metternich, divenendone «la penna più affilata» (p. 89). Con grande tempestività Gentz pubblicò sulla rivista «Minerva», nel 1794, un’accurata scelta di passi di discorsi del capo giacobino e di Saint-Just, profondendo una finissima capacità ermeneutica, ma anche un’astuta libertà di selezione linguistica, per demolire i fondamenti teorici di quei discorsi. Ma il problema delle caratteristiche della «virtù civica» restava, e per trovarne il fondamento non rimaneva che ricorrere ai classici, come fecero sul finire del secolo, tra altri, soprattutto Johann Georg Schlosser e Christian Garve affrontando in tedesco, separatamente ma contemporaneamente, la Politica di Aristotele (pp. 94-96).
La sua singolare competenza linguistica consente a Bruno Berni (pp. 97-126) di indagare sulla fortuna contemporanea, all’estero, delle opere del grande commediografo settecentesco danese Ludvig Holberg. L’affascinante percorso compiuto in Francia, Germania e Italia da una delle sue commedie, Den politiske Kandstøber ( Lo stagnaio politico, 1722), iniziato con l’autotraduzione in francese, è utile a dimostrare che la competenza linguistica è condizione indispensabile ma non sufficiente se al traduttore manca un’ampia cognizione dell’insieme non solo culturale ma anche professionale (s’intenda qui soprattutto editoriale e teatrale) di entrambi i contesti, sia quello di partenza che quello d’arrivo. Ma Berni ne approfitta anche per offrire, en passant, un ricco panorama dell’attività traduttoria settecentesca in Italia e in Francia, terminando con la divertente osservazione di Paul Hazard sulla prassi francese di ridurre al proprio gusto – con modifiche, tagli e perfino capricciose aggiunte – i testi stranieri (musica, sarebbe stata, alle orecchie di Vittorini!).
Una conferma parziale ma significativa della necessità per il traduttore di conoscere tutta la letteratura coeva del testo tradotto viene dal saggio successivo, di Elena Agazzi (pp. 127-142). Si tratta della utilissima riflessione sulla propria traduzione del Versuch einer Allegorie besonders für die Kunst di Winckelmann, ossia il Saggio sull’allegoria specialmente per l’arte (Argelato, Minerva, 2004), nella quale ricorrono le traduzioni coeve da Winckelmann (importante l’opera di mediazione culturale di Carlo Fea, p. 104), ma soprattutto la ricostruzione dell’intero percorso di ricerca del grande iniziatore della storiografia dell’arte, errori compresi.
Anche Gloria Colombo prende occasione da una propria fatica di traduttrice (per Barbera, di Siena, 2008), alle prese con Das Schloß di Franz Kafka per esaminare le 10 (dieci!) versioni italiane subite finora dall’ultimo romanzo del grande scrittore praghese, a cominciare dal Castello (1948) di Anita Rho con la collaborazione di Ervino Pocar per finire con quello di Barbara Di Noi per la milanese Mimesis (2014). Mette così in luce da un lato la tormentata storia del testo, passato attraverso mille disavventure, a cominciare dalle gravi manomissioni di Max Brod, che fece così pagar caro il suo grande merito di salvatore del lascito letterario kafkiano, per giungere finalmente alla sospirata prima edizione critica di Malcolm Pasley nel 1983, ora soppiantata da quella di Roland Reuss e Peter Staengle del 2018 (ma Colombo puntualizza doverosamente che già Rho e Pocar si erano preoccupati di svolgere una collazione fra edizione allora esistente e autografo – p. 145). La tormentata vicenda del testo originale è ovviamente fondamentale per intendere anche le scelte via via compiute dai traduttori a seconda della data del loro impegno su di esso, ma che non sempre si giustificano. Estrema attenzione Colombo pone a due questioni che rimandano allo sfondo culturale in cui operava Kafka e che rappresentano problemi di traduzione di non poco conto: i praghismi sopravvissuti alla sua ansia di aspirare alla classicità goethiana (pp. 146-147); e la sua esperienza di biblista cresciuto con la versione ebraica della Scrittura e alle prese con la lingua inventata da Lutero per tradurla (pp. 147-150). Lettura filologicamente godibilissima (molto pertinente l’attenzione alla punteggiatura – pp. 151-152), il saggio di Colombo non può non concludersi, nel cuore più che nella mente del lettore, con la ennesima constatazione che la traduzione è irraggiungibile quanto il castello per l’agrimensore K.
Tra francese e tedesco, Rainer Maria Rilke è sempre alle prese con il tormento di arrivare a dire l’indicibile, alla ricerca «di una lingua astratta ed essenziale» (p. 160): chissà, forse la benjaminiana Ursprache. Il saggio di Raul Calzoni (pp. 159-184), dedicato ai Poèmes français, ne ripercorre la genesi e va alla scoperta del significato di questa impresa “in un’altra lingua” del grande lirico germanofono: o si dovrebbe dire eurofono, portato com’è da un doux vent polyglotte, da un «dolce vento poliglotta»? (p. 183). Questa impresa è rivolta essenzialmente, appunto, a dire l’accettazione della realtà umana, della vita e della morte: trasfigurazione del «paesaggio», interiore ed esteriore, che salva il poeta dalla sudditanza al reale. Il confronto con le Duineser Elegien serve a completare questa circolarità della parola poetica che «rende visibile l’invisibile». Sì, questo è “sapere”, ma non certo nel senso pragmatico suggerito dal titolo del volume.
Subito un appunto a Silvia Vezzoli (pp. 185-201): non mi sembra appropriato definire Herta Müller «scrittrice tedesca di origine romena» (p. 185). Mi sembrerebbe più corretto dire: «romena di lingua tedesca». L’appunto non vuole essere pura pignoleria anagrafica: si tratta di riconoscere la diffusione della lingua tedesca come lingua propria di tanti cittadini europei che la storia (sotto specie di espansioni imperiali d’antan) ha distribuito nei più diversi cantoni del continente e, quindi, la pura strumentalità dei confini nazionali che la duplice tragedia delle due guerre mondiali, e le “pulizie etniche” che ne sono derivate, hanno imposto a una comunità che è a casa sua dove è. Ma dal saggio di Vezzoli apprendiamo, con il sostegno di un’abbondante letteratura linguistica, l’importanza della ripetizione nei testi di Müller, che contrasta la prassi italiana della variatio.