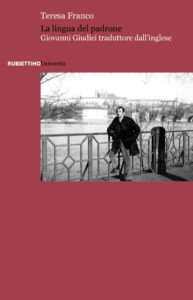 di Jacob Blakesley
di Jacob Blakesley
A proposito di: Teresa Franco, La lingua del padrone: Giovanni Giudici traduttore dall’inglese, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino Editore, pp. 266, € 16,00
Si sbaglia chi scrive la storia della letteratura italiana senza analizzare la massiccia influenza delle traduzioni nell’arco dei secoli. Eppure, in Italia, ancora vige l’idea che la traduzione sia una prassi culturale marginale, nonostante la crescita e la fioritura dei Translation Studies. Ma cosa sarebbe stata, per esempio, la poesia italiana del Novecento senza le traduzioni che l’hanno in gran parte modellata?
Fra i numerosi poeti-traduttori italiani del Novecento, Giovanni Giudici (1924-2011) è uno dei più innovativi, per tre motivi: la commistione (e la sinergia) fra la poesia propria e le traduzioni; la scelta di tradurre da lingue spesso inconsuete, e la sua profonda teorizzazione della traduzione. Però, nonostante la vasta gamma di opere tradotte da Giudici (almeno due dozzine), non esiste una monografia che le analizzi tutte. Questa lacuna critica si fa sentire, soprattutto quando le traduzioni di diversi altri poeti-traduttori contemporanei – da Montale e Ungaretti a Luzi e Sereni – hanno ricevuto moltissima attenzione.
In questa terra di nessuno appare il nuovo libro di Teresa Franco, La lingua del padrone: Giovanni Giudici traduttore dall’inglese. Franco si era già affermata come specialista autorevole di Giudici attraverso la sua curatela dei quaderni e taccuini appartenenti alla prima fase della carriera del poeta (in «Istmi», n. 35-36, 2015). Facendo leva su questa expertise, lei ripercorre, in questo libro, le traduzioni letterarie anglofone di Giudici, inserendole nel contesto letterario del tempo.
Il libro viene strutturato in sei capitoli. La studiosa fa una scelta forte ma sensata quando decide di scomporre i tre quaderni di traduzioni di Giudici e parlare separatamente degli autori e dei testi lì antologizzati. Questo le permette di seguire lo sviluppo variantistico dei testi anglofoni dagli anni Cinquanta fino alla fine della carriera del poeta.
Il primo capitolo, La forza degli errori, ripercorre l’inizio e lo sviluppo della carriera traduttiva di Giudici, mostrando quanto sia stata importante per lui l’idea della lontananza del testo straniero, della traduzione come “illegalità”, della teorizzazione della poesia come “errore”. Sarebbe stato interessante se l’autrice avesse trattato anche le traduzioni di servizio in prosa che Giudici fece durante gli anni Cinquanta e Sessanta, soprattutto quei libri su temi e/o figure politici (Algeria, Cuba, Giappone, Kennedy), per Le Edizioni di Comunità.
Il secondo capitolo, Due poesie nell’officina del traduttore, analizza due sue traduzioni di Eliot, facendo ampi riferimenti alle traduzioni eliotane di Montale. Si scopre che Giudici, come Montale peraltro, crea un «mito fondativo» (p. 56) attraverso la datazione retrospettiva delle proprie traduzioni di Eliot.
Il terzo capitolo, Tradurre per le riviste, viene suddiviso fra le traduzioni di tre poeti americani contemporanei (Karl Shapiro, Peter Viereck, e Richard Wilbur) e le traduzioni di John Donne. Mentre le analisi qui sono a volte originali, soprattutto riguardo ai tre poeti americani menzionati, non c’è un filo conduttore che tenga insieme le traduzioni americane e quelle di Donne. Questo perché il contesto delle riviste non è sufficiente a giustificare di mettere insieme autori di epoche talmente diverse.
Il quarto capitolo, L’incontro con un editore “inutile” esamina il rapporto fra Giudici e Vanni Scheiwiller. L’editore aveva sollecitato diverse traduzioni e costituito una sorta di sounding board per il poeta. Questo capitolo è una fonte di ricerche nuove, e l’autrice mette a buon frutto la sua perizia archivistica, e l’indagine sulle revisioni delle traduzioni negli anni. Qui si tratta di Milton, Dryden, Dickinson, Hopkins, Crane, Lowell e Graves. Si vede dappertutto il modo in cui Giudici non vuole «addomesticare il verso originale» (p. 105), dimostrato esemplarmente, per esempio, nella trattazione delle traduzioni di Emily Dickinson, in confronto ad altri traduttori italiani.
Il quinto capitolo, Un ritratto del traduttore da giovane, indaga le traduzioni di Giudici del poemetto Hugh Selwyn Mauberley di Pound. La studiosa mostra come per Giudici «la traduzione è un mezzo d’imitazione e identificazione con l’altro» (p. 175). Qui particolarmente lo studio delle varianti illumina il processo traduttivo negli anni, e come cambi la poetica del traduttore.
Nel sesto capitolo, Tradurre per l’Einaudi e Mondadori, Giudici viene analizzato nel periodo delle sue traduzioni durante «il suo ingresso nell’industria editoriale» (p. 179). Franco indaga in profondità le traduzioni di Frost, e il modo in cui queste traduzioni hanno liberato Giudici dalla necessità di scrivere e tradurre in «pentametro giambico/endecasillabo» (p. 192). L’autrice esamina anche le traduzioni di John Crowe Ransom e Sylvia Plath: qui, le osservazioni che fa riguardo al modo in cui Giudici traduceva Plath, in particolare, sono affascinanti.
Il libro si chiude con una conclusione che riassume alcuni dei nodi centrali del lavoro troppo sinteticamente.
La studiosa ha condotto una vasta ricerca negli archivi italiani e americani, attraverso i quali guida il lettore in modo esperto. L’altro approccio che Franco adopera è la variantistica: infatti, il modo in cui esamina diverse edizioni della stessa traduzione è generalmente esemplare, e rivela i cambiamenti di prospettiva e le mutazioni nell’estetica di Giudici. Un’altra caratteristica forte del libro è la contestualizzazione delle traduzioni nella loro ricezione italiana, che evidenzia quando Giudici traduce un autore ben conosciuto o ignoto, e mette a confronto le sue traduzioni con quelle di altri traduttori italiani.
Per concludere, La lingua del padrone è un libro assai solido e ben fatto. Chi lo prenderà in mano ne trarrà molto e imparerà non solo su Giudici, ma anche sulla traduzione di poesia anglofona in Italia nel secondo Novecento. Certo, quello che manca, agli occhi di uno specialista di sociologia della traduzione, è un’impalcatura teorica sociologica e/o traduttiva. La metodologia utilizzata nel libro – un’indagine condotta attraverso una fitta selva di testi originali e in traduzione, relativi archivi e corrispondenza, e una mole di critica letteraria – è certamente efficace, ma la ricerca, già interessante in sé, sarebbe stata approfondita ancora di più se proiettata su dimensioni più ampie. Comunque, il libro qui recensito ha davvero molti pregi, e lo consiglio vivamente a tutti gli appassionati di Giudici e della poesia italiana del Novecento, e a chiunque si interessi di ricezione della poesia angloamericana nell’Italia contemporanea.