L’ISPANOAMERICA IN LINGUA ITALIANA
di Stefano Tedeschi
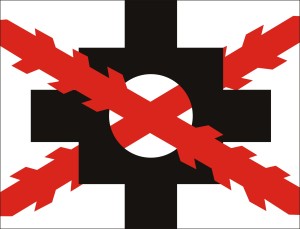
La bandiera del continente latino-americano (InstitutoSolarHA)
Risulta difficile indicare con chiarezza quale è stato il momento in cui si comincia a formare in Italia un vero interesse per la cultura ispanoamericana. Di certo già dagli anni venti del Novecento si possono rintracciare pionieristiche traduzioni, antologie, articoli su riviste specializzate, libri di viaggiatori e mediatori che si muovono tra le due rive dell’Atlantico, ma tutto sembra interrompersi con la guerra civile spagnola: le nazioni latinoamericane si schierano quasi tutte con la Repubblica, e la rottura con l’Italia fascista sarà totale.
Uno sguardo alla serie delle traduzioni rivela però che nel secondo dopoguerra questo rapporto si riannoda. Il 1955 si presenta allora come un punto di convergenza per nuovi itinerari culturali, e l’imprevedibile coincidenza dei tempi di pubblicazione ci permette di situare in quell’anno, in maniera convenzionale ma non arbitraria, un possibile inizio per un percorso attraverso le traduzioni italiane della letteratura ispanoamericana. Vi si concentrano, infatti, sei nuovi libri che arrivano dall’America di lingua spagnola. Tra essi spiccano Ficciones di Jorge Luis Borges (1944) e una prima parte del Canto general di Pablo Neruda (1950), libri che segnano l’inizio di una prima essenziale oscillazione dell’interesse italiano verso quell’universo letterario. Tra il 1955 e il 1968 ci si muoverà di fatto su questa doppia linea di ricezione, tra Neruda e Borges, passando per narratori e poeti allora tutti da scoprire.
Di fatto questi primi libri non conoscono un particolare successo di pubblico, ma la loro presenza è il segnale di una volontà, comune agli studiosi e a qualche coraggioso editore, di iniziare a creare un campo letterario, una griglia di riferimenti che permetta al lettore italiano di riconoscere una serie di testi come contigui e di collegarli a un’area geografica, a una storia, a delle coordinate specifiche. L’America Latina si presenta fin da quei primi anni come un continente ricco di storie, ed è proprio la narrativa a occupare in forma consistente l’ancora esiguo spazio concesso dall’editoria italiana agli autori di quelle regioni, anche se la voce di Neruda sembra fare da apripista a un interesse non banale nei confronti di una tradizione poetica di formidabile qualità. Il poeta cileno è infatti il primo dei grandi autori a trovare una sua precisa collocazione in Italia, e le traduzioni svolgono qui un ruolo cruciale: il paragone tra le diverse versioni nerudiane rivela infatti una tendenza chiara. Nelle prime antologie (Quasimodo 1952) si assiste quasi a una riscrittura che sembra trascinare il testo in una dimensione assai più vicina a quella del traduttore, mentre quelle successive (Puccini 1955, Tentori Montalto 1957, Bellini 1960) rimangono tutte più vicine all’originale e presentano scelte lessicali progressivamente più intelligibili che conducono verso una maggiore musicalità del testo in italiano. La direzione di questi anni resta allora quella di una generale maggiore comprensibilità del testo, della proposta di un Neruda comunque fruibile dal pubblico italiano.
Una strategia che senza ombra di dubbio si dimostra efficace, come testimoniano le numerose edizioni e ristampe e soprattutto la conoscenza diffusa dell’opera di Neruda, al di là dei limiti della collocazione politica e del ristretto circolo degli studiosi. Strategia ancora più efficace se pensiamo che il punto di partenza era quello di una griglia di prelettura assai povera, con scarsi punti di riferimento nell’immaginario collettivo, con pochi metatesti, peraltro con una forte connotazione politica, e apparati paratestuali che per la poesia in quegli anni non consideravano necessarie particolari presentazioni, tanto che i primi volumi del Neruda italiano appaiono davvero ridotti all’essenziale. A poco a poco, si assiste alla trasformazione di Neruda in poeta-simbolo di tutta una storia e di tutto un universo, e il raggiungimento di un tale obiettivo sarà possibile grazie a una strategia che si ritroverà anche in futuro: produzione di importanti metatesti di tipo critico-biografico; presenza assidua del poeta cileno sulla scena culturale; selezione accurata di antologie che riunissero temi assai concreti (la natura) con referenti immaginari di forte impatto emotivo (la poesia amorosa) e con richiami extratestuali legati all’attualità politica di quegli anni. In tale maniera il lettore italiano riesce a far convergere sulla poesia nerudiana tre proiezioni del desiderio fondamentali per gli anni sessanta: la volontà di un generoso (ma generico) impegno politico, l’apertura verso uno spazio altro e il recupero di una dimensione del sentimento amoroso che coinvolga anche la corporeità.
Se i due poli della prima ricezione della letteratura ispanoamericana in Italia sono quelli di Neruda e Borges, i gruppi che si muovono intorno a questi due autori si rivelano sostanzialmente diversi. L’interesse per l’autore argentino è infatti sostenuto da scrittori e critici generalmente lontani dal mondo ispanico, con l’eccezione di Francesco Tentori Montalto, unico a occuparsi negli stessi anni del Neruda poeta e del Borges narratore. La prima traduzione di Borges vede allora in campo alcuni tra i più bei nomi della cultura italiana. La pubblicazione di La biblioteca di Babele (Lucentini 1955) viene suggerita da Sergio Solmi a Vittorini e a Calvino dopo l’edizione francese del 1951, curata da Roger Caillois. Vittorini accetta di pubblicare il libro, e sceglie di inserirlo nella collana che in quel momento ha più a cuore, «I Gettoni», della quale cura personalmente ogni aspetto, dalla scelta degli autori e dei traduttori alla presentazione editoriale fino ai famosi risvolti di copertina. Si affida la traduzione a Franco Lucentini, ma quel piccolo volume di uno sconosciuto scrittore argentino sembra cadere nel vuoto, come ricorderà molti anni dopo Umberto Eco:
Nel 1955 esce Ficciones con il titolo La biblioteca di Babele nei «Gettoni» Einaudi. Era stato consigliato a Einaudi da Sergio Solmi, un grande poeta che io amavo molto […]. Io credo che sia nel ’56 o ’57 che Solmi, passeggiando in Piazza del Duomo, una sera mi ha detto: “Io ho consigliato Einaudi di pubblicare questo libro, non siamo riusciti a vendere neanche cinquecento copie, lo legga perché è molto bello.” […] Però non avrei potuto permettermi, all’epoca, un riferimento a Borges, perché in Italia era ancora noto a pochissimi (Eco 2001, 137).
In realtà l’iniziale insuccesso porta con sé i germi della futura fortuna di Borges e anche le coordinate di base su cui si centrerà l’interpretazione italiana della sua opera. Se si analizza quella prima apparizione, in quell’impresa editoriale tutto sembra importante: scelta della collana, parole del risvolto, qualità della traduzione.
La traduzione di Franco Lucentini è stata a lungo considerata come esemplare, tanto che anni dopo il libro verrà accolto nella prestigiosa collana «Scrittori tradotti da scrittori», ma in realtà appare strettamente funzionale a una certa interpretazione di Borges, in cui gli “errori” di traduzione appaiono come spie evidenti di una precisa volontà di lettura. Ci si trova dunque spesso di fronte a un traduttore che legge, interpreta e traduce parole secondo una sua idea precostituita, cercando significati già definiti. Gli esempi che si potrebbero estrarre da quella edizione sono numerosissimi e tutti vanno nella direzione di rendere il testo meno concreto, più vago, quasi sospeso tra il generico e l’arcaico, a volte grazie a una traduzione quasi letterale, altre volte sciogliendo nomi e cose in categorie più generiche. Il racconto in cui tale strategia si mostra in tutta la sua evidenza è La morte e la bussola (La muerte y la brújula), vero concentrato di ardite (e a volte incomprensibili) interpretazioni. L’idea generale del racconto che emerge dalla traduzione è quella di una impressionante costruzione basata su un’erudizione infinita e un’invincibile passione per la geometria e la teologia rabbinica. Di certo tali elementi sono ben presenti nel testo borgesiano; in italiano però diventano quasi esclusivi, grazie a una inutile patina di antiquariato (dalla «vendicazione» all’acqua «crapulosa» al fiume «lordato») e a una serie di errori troppo numerosi per essere casuali. Così Lönnrot ha l’animo del «giocatore di carte» invece che del baro (come in Argentina significa tahúr), il nome di Dio diventa «infallibile» piuttosto che inefable, l’acqua della darsena si trasforma in «morta», aggiunta a «rettangolare», e l’intuizione dell’investigatore-teologo si volge incomprensibile quando l’affermazione El día hebreo empieza al anochecer y dura hasta al siguiente anochecer diventa «Il giorno successivo comincia al tramonto e dura fino al tramonto successivo». Il mistero si fa davvero «impenetrabile» (invece che triple) e l’ineffabile Lönnrot scenderà in una stazione isolata in cui vedrà «un furgone in una strada morta» (e non, più verosimilmente per chi conosce il paesaggio ferroviario, un vagone su un binario morto). Quando scatterà la trappola, il terribile Scharlach non potrà che «allargare» la mano (invece di allungare) per «ricevere» la sua rivoltella e prenderà la mira «accuratissimamente» (e non con estrema attenzione) per concludere il racconto. Tante stranezze non possono essere attribuite solo a possibili errori di traduzione, peraltro mai corretti nelle numerosissime successive ristampe, quanto piuttosto a un’idea più globale che sottintende all’intero lavoro. I primi lettori italiani di Borges sembrano davvero ossessionati dall’impresa di scoprire significati nascosti nei racconti di Finzioni e perdono di vista così il senso del gioco letterario, l’ironia acuta e profonda che sottende a tutta la sua opera.
Molti anni più tardi, lo stesso Lucentini tornerà a riflettere su quella traduzione (in particolare sul racconto La biblioteca di Babele) e la giudicherà guidata da una serie di «sviste compulsive» che si muovono però in direzioni assai chiare. Allora el furgón en una vía muerta diventa un furgone in un vicolo cieco grazie a una «svista compulsiva» che costringe il traduttore a vedere un molto più metafisico vicolo cieco piuttosto che un realistico binario morto in una stazione (Lucentini 2001, 125).
Prima del boom
Se questi sono i primi due autori di riferimento, ne emergono poi altri che disegnano percorsi ulteriori, destinati a preparare svolte future. La questione da porsi riguarda evidentemente i criteri di scelta adottati e le modalità di presentazione, giacché appare chiaro da subito che ci si deve muovere su un archivio di autori ampio e assai diversificato: le prime storie letterarie e le suggestioni che vengono dalla Francia mostrano infatti un ventaglio di proposte estremamente variegate, sia in termini di ambientazione che di modalità di scrittura.
Un primo inventario di autori e titoli mostra innanzitutto una certa dispersione editoriale: non appaiono ancora case editrici dominanti in questo campo e il successo appare ancora assai limitato. Quasi nessuno di questi libri raggiunge la seconda edizione e si pone qui per la prima volta un problema che ritornerà a scadenze pressoché regolari: in Italia si traduce molto, ma si legge poco, e in questo modo numerosi autori, anche di notevole valore, vengono fagocitati dal mercato editoriale senza lasciare alcuna traccia. Nessuno di questi testi preso isolatamente incide dunque in maniera significativa sui lettori italiani, ma si potrà osservare che l’insieme di essi contribuisce a creare quello spazio dell’immaginario in cui troverà cittadinanza piena il successivo boom di García Márquez.
Nello stesso rapido inventario si possono notare altri due indizi, che coinvolgono traduzione e presentazione editoriale: la tendenza a modificare i titoli nelle traduzioni e una sommaria suddivisione tra due orientamenti nella selezione, una che segue la strada del realismo sociale e un’altra che cerca invece di proporre autori più giovani e con una traiettoria più cosmopolita.
La questione dei titoli si collega direttamente alla presentazione di quei primi romanzi: molti di essi vengono accompagnati da introduzioni, prefazioni, postfazioni, ma evidentemente ciò non è sufficiente. Appare necessario rendere riconoscibili quei testi fin dal primo impatto con il potenziale lettore: in anni in cui la copertina (o la sovracopertina) è ancora legata a modelli regolati sul ruolo preminente dell’immagine editoriale, bisogna trovare altri elementi che proiettino il visitatore delle librerie in un universo fisico e letterario così profondamente diverso e di tipo nuovo. A tale scopo svolgono un ruolo cruciale i titoli e i risvolti di copertina, quando presenti. Il nome dell’autore, quasi sempre del tutto sconosciuto, non provoca infatti alcun richiamo, e non sarà allora un caso che i cambiamenti nei titoli puntino decisamente sulla dimensione “geografica” dei romanzi. I racconti di Juan Rulfo si chiameranno allora La morte al Messico (Cintioli 1963), il romanzo di Ciro Alegría diventerà I peruviani (Cintioli 1962) o un Sarduy essenziale (Gestos) si trasformerà in un decisamente improbabile La bomba dell’Avana (González-Palacios 1964). Si cerca anche di collegare la dimensione storica di quelle narrazioni con reminiscenze più vicine all’esperienza italiana, ma trasformare El Señor Presidente di Asturias in L’uomo della provvidenza (Mancuso 1958), con vaga allusione al ventennio fascista, risulta alla fine fuorviante e la seconda edizione del romanzo (1967) torna infatti al titolo originale. La scelta del titolo rivela dunque in quale maniera incide sulla confezione del libro la necessità di entrare in contatto con un pubblico ancora ampiamente disinformato sulla produzione letteraria ispanoamericana. Passare attraverso la geografia sembra essere una possibilità abbastanza neutra, e di effetto immediato, ma nasconde un pericolo di cristallizzazione di un certo tipo di immagine quando a quelle scelte di titoli si collegano introduzioni, traduzioni e commenti tutti indirizzati verso una connotazione abbastanza stereotipata di quegli spazi, come quando Giuseppe Cintioli afferma a proposito di Rulfo «Morte e Messico: Morte è Messico», o come il commento che annuncia sulla copertina della traduzione del romanzo di Sarduy «un indimenticabile personaggio femminile: la cubanita che di giorno fa la lavandaia e di notte la cantante di feeling nei cabaret ma non disdegna di piazzar bombe per amore».
Nel campo della narrativa si ritrova, infatti, la stessa esigenza didascalica già osservata a proposito di Neruda: non è sufficiente proporre al lettore l’opera, bisogna spiegare, dare informazioni, realizzare in qualche modo il ruolo di divulgatore che il traduttore-curatore sente di dover compiere. Gli apparati paratestuali non si limitano però solo a considerazioni di tipo letterario o anche più genericamente culturali, ma si allargano sempre a discorsi più ampi, che coinvolgono la politica, la storia e l’attualità. L’esempio veniva d’altronde dagli stessi autori, come appare nella postfazione che lo stesso Alegría aggiunge all’edizione del 1941 di El mundo es ancho y ajeno, ripresa senza cambiamenti nell’edizione italiana del 1962: un tale atteggiamento sembra autorizzare allora un ampliamento a dismisura del campo di interesse, indirizzato alla costruzione di competenze specifiche che il lettore italiano ancora non aveva. Il ragionamento sembra essere rigoroso e consequenziale: se il pubblico italiano conosce poco o niente del continente americano, non basta tradurre e pubblicare, ma è indispensabile situare quegli autori in spazi geografici e tempi storici finalmente riconoscibili. La scelta degli autori si collega così direttamente a una visione precisa della realtà americana, e la letteratura viene strettamente collegata alla necessità storica di una rappresentazione realistica e di una inevitabile denuncia di tipo sociale: il legame tra realtà e letteratura diventa a questo punto un vincolo obbligato, una sorta di chiave di lettura inscindibile per ogni possibile avvicinamento agli autori ispanoamericani.
Tra le opere di narrativa pubblicate in quegli anni si trovano infatti all’inizio autori come Ciro Alegría, Jorge Icaza, Manuel Rojas, Rómulo Gallegos, Miguel Otero Silva, cui solo più tardi si aggiungeranno Alejo Carpentier, Juan Rulfo e Miguel Ángel Asturias, e infine i nomi di Carlos Fuentes, Julio Cortázar, José Donoso, Mario Vargas Llosa, anticipazioni di un’esplosione ormai alle porte.
Come era accaduto già per Neruda e per Borges, i presupposti che regolano le scelte editoriali finiscono per avere effetti di alterazione anche sulle traduzioni, con risultati a volte davvero significativi. In generale i traduttori si muovono sulla strada di una semplificazione costante della materia: in questo modo non si notano grandi differenze tra i testi di Alegría, di Icaza o di Rulfo, tutti ambientati in un mondo rurale appiattito su uno spartito comune. Un tale effetto viene raggiunto in diversi modi: si va dalle pesanti trasformazioni de I peruviani alle scelte di non traduzione di La morte al Messico. Nel caso di Alegría, gli interventi di Giuseppe Cintioli – ma forse, come in tanti casi del genere, dettati dalla casa editrice − arrivano fino alla cancellazione di intere parti del libro: scompaiono quasi tutti gli interventi del narratore, molte descrizioni, le originali divisioni tipografiche. Il testo appare più “oggettivo”, ancor più segnato da una opzione verista peraltro già presente nella poetica dello scrittore peruviano. In alcuni passaggi si affacciano correzioni “politicamente corrette”, che attualizzano un testo degli anni trenta, adeguandolo alla diversa sensibilità degli anni sessanta. La caratteristica della traduzione di Rulfo – sempre di Cintioli – è invece quella del mantenimento di molte espressioni colloquiali direttamente in spagnolo, anche quando sarebbe possibile una traduzione soddisfacente. Il risultato è quello di dare una coloritura popolareggiante dal tono vagamente esotico, senza preoccuparsi di trasporre la lingua di Rulfo, risultato di un’acutissima opera di sintesi, in un italiano corrispondente. Il fallimento di questa primissima generazione di traduttori di romanzi ispanoamericani risiede proprio in questa incapacità nell’aprire al lettore italiano, attraverso lo strumento della lingua, il mondo di appartenenza di testi così diversi. Il possibile incontro con un’alterità che si intuisce affascinante non può avvenire perché tutto si livella sul piano di un «realismo fatale», come afferma Francesco Tentori Montalto nell’introduzione alla sua antologia di narratori ispanoamericani (Tentori Montalto 1960), come se bastasse evocare la materialità delle cose, senza peraltro precisarle nella loro peculiarità, per convocare un universo in cui la qualità dell’espressione linguistica sembra avere un’importanza solo secondaria.
La cultura italiana dei primi anni sessanta non è però forse più così interessata a una narrativa realistica di questo tipo: attraversata dalle prime agitazioni della Neoavanguardia, dalle inquietudini di Calvino e di Vittorini, mostra una attenzione diversa nei confronti delle sperimentazioni narrative che iniziano a diffondersi un po’ ovunque, sull’onda di una idea diffusa di “morte del romanzo”. Il pubblico del boom economico mostra di volersi lasciare alle spalle il neorealismo dell’immediato dopoguerra e volge il suo sguardo su una narrativa internazionale e nazionale aperta a soluzioni nuove. Saranno allora i giovani a fare la differenza, e l’editoria italiana sembra rendersene conto a poco a poco: le proposte del passato non sono più sufficienti e bisogna trovare una via che sappia coniugare l’impegno politico con le più avanzate innovazioni narrative, un punto di sintesi che sembra materializzarsi miracolosamente proprio nei più giovani autori latinoamericani.
La casa editrice protagonista di tale cambiamento di prospettiva fu senza alcun dubbio Feltrinelli: di certo non la sola, ma in qualche modo fu quella che lasciò una traccia più duratura, specialmente nel campo di cui ci interessiamo. Nella selezione degli autori e dei testi, riveste una grande importanza l’agile struttura della casa editrice e il ruolo carismatico e cosmopolita del fondatore, con i suoi numerosi contatti all’estero e le relazioni personali costruite con molti dei personaggi chiave della cultura mondiale dell’epoca: per l’America Latina si guarda soprattutto a Cuba e ai rapporti che uno dei primi collaboratori di Feltrinelli, Valerio Riva, sta intessendo con una giovane e agguerrita generazione di scrittori, direttamente nei loro paesi d’origine. Uno dei cambiamenti più rilevanti dell’approccio ai paesi del neonato Terzo Mondo da parte della casa editrice di via Andegari è infatti quello della relazione diretta: non si passa più dalla mediazione francese, ma si va in prima persona a L’Avana, a Città del Messico, a Buenos Aires, per scoprire sul posto le nuove voci. Feltrinelli era stato inoltre il primo a intuire la centralità del nuovo pubblico giovanile, e a muoversi in quella direzione, sia dal punto di vista delle scelte editoriali che da quello dei sistemi di vendita. Succederà poi una cosa assai simile negli anni ottanta, quando la proposta feltrinelliana di Isabel Allende andrà a colmare uno spazio, quello del pubblico femminile colto, fino ad allora abbastanza negletto nell’editoria italiana. La casa editrice milanese ha poi anticipato molte tecniche di marketing e di editing che avranno in seguito grande importanza. La copertina di La bomba dell’Avana è ad esempio una delle prime che utilizza una tecnica da romanzo popolare per un’opera sperimentale e d’avanguardia: la foto del volto sorridente di una bella ragazza “latina” e il commento di copertina prima ricordato rappresentano delle novità assolute per l’epoca. Alla fine di questo primo periodo, la situazione è dunque radicalmente cambiata. Il lettore del 1955 troverebbe nel 1967 un numero notevolmente superiore di libri latinoamericani, forse ancora poco significativo, ma che segna un mutamento di tendenza ormai senza ritorno, cui manca solo il caso letterario per trasformarlo in fenomeno di massa. La strada è ormai aperta e vi si costruirà, di lì a pochi mesi, lo straordinario caso di Cent’anni di solitudine.
Arriva il boom: Cent’anni di solitudine
È ormai il 1968, l’anno in cui si accumulano eventi straordinari con cadenza pressoché quotidiana e uno di essi, certamente di portata minore ma per noi assolutamente centrale, fu il travolgente successo di un libro sospinto dall’onda dei giudizi entusiasti di tutto il continente americano, e che a partire dall’Italia inizierà una ininterrotta catena di straordinari risultati di pubblico e di critica. Nel maggio del 1968 vede la luce in Italia la prima traduzione mondiale (Cicogna 1968) di Cien años de soledad del colombiano Gabriel García Márquez, scrittore fino ad allora «felice e sconosciuto», come detta il titolo di una raccolta italiana di suoi scritti giornalistici (Feltrinelli 1974). Nei sei mesi successivi quel libro venderà l’insperata – e a quei tempi astronomica − cifra di centocinquantamila copie, cambiando totalmente la visione della letteratura ispanoamericana, e influenzando in maniera non secondaria alcuni processi editoriali già in corso in quegli anni.
La questione che molti si sono posti gira intorno alla ragione di un tale inatteso successo. La risposta che ci si trova di fronte sottolinea con forza come quello fosse «un libro necessario», il «libro che stavamo aspettando» (Varanini 1998, 18), un libro che entrava nell’orizzonte di attesa dei lettori italiani e nello stesso tempo lo sconvolgeva, ponendosi come testo fondatore di una nuova epoca, in un orizzonte peraltro ancora libero da griglie di prelettura troppo rigide, paradossalmente grazie alla scarsa diffusione dei libri tradotti fino a quel momento. Per comprendere le ragioni di un tale ruolo centrale bisogna però sovrapporre più elementi: la situazione politica e culturale di quegli anni, le attese specificamente letterarie e in che maniera la saga dei Buendía riesca a rispondere a quasi tutte le domande che circolavano in quei mesi. Si è osservato come la strategia editoriale della Feltrinelli fosse diretta ad allargare la platea dei lettori in direzione del pubblico più giovane, e il 1968 è segnato in maniera inequivocabile dal protagonismo delle nuove generazioni. In quella strategia Cent’anni di solitudine rappresenta un caso particolare: non è un romanzo generazionale, ma contiene in sé numerosi elementi che gli permettono di essere accolto favorevolmente proprio da quel nuovo gruppo di lettori che stava cercando i suoi testi di riferimento. La questione iniziale è quella della “novità”, dello spirito di fondazione che si avverte dentro e fuori il romanzo.
Nel famoso incipit si può già apprezzare infatti come l’idea di novità, di un inizio senza antenati con cui fare i conti domini tutta la prima parte del libro. Quel «mondo così recente» in cui «molte cose erano prive di nome» era quello che si desiderava, un tempo in cui tutto poteva diventare possibile. Non bastava però che il romanzo cominciasse da una tabula rasa, da una primavera in cui gli zingari arrivano a mostrare le loro invenzioni. Macondo era anche la comunità ideale, in cui un fondatore distribuisce la terra e il lavoro: lo spazio della narrazione si configura dunque fin dall’inizio come un’utopia possibile, in cui però, grazie alla tecnica narrativa delle prolessi ripetute e insistenti, si insinua un tempo di morte, un richiamo costante a un’innocenza perduta che ha portato i protagonisti davanti a minacciosi plotoni di esecuzione. La capacità di ricominciare non viene però negata, e anzi la famosa struttura temporale a spirale ripropone a ogni generazione il sogno dell’inizio, addirittura fino all’ultima rappresentante della famiglia, quella Amaranta Úrsula che si illude di poter rimettere a nuovo la vetusta dimora dei Buendía. Il lettore di quegli anni non poteva che rimanere affascinato da quella macchina in cui personaggi con nomi spesso ripetuti lottavano contro l’usura della ruota del tempo, e si davano sempre nuove sfide cui rispondere.
La storia di Macondo è poi attraversata da una ininterrotta tensione di rivolta verso l’autorità, di qualsiasi segno essa si manifesti. L’antiautoritarismo è incarnato dal colonnello Aureliano, con le sue «trentadue sollevazioni armate»; ma tutta la famiglia non è da meno, fino gli ultimi due protagonisti, epigoni tragici di una stirpe che non si era voluta piegare alle norme stabilite. Non si tratta allora solo di una lettura semplicemente politica, intesa nel senso di una rappresentazione del reale, ma di una storia che riesce a mostrare un comportamento, una maniera di essere in cui rispecchiarsi.
Non è certamente secondario poi che tutta la storia si svolga in un luogo immaginario, compendio di una natura caraibica che per la prima volta si impone al pubblico europeo. Macondo si presenta come uno spazio esotico in cui poter vivere qualsiasi utopia, in cui i giovani (e meno giovani) lettori possano trovare il loro luogo possibile, proprio perché immaginario, situabile ovunque, anche se spazzato via dal vento poderoso del capitolo finale. Non si racconta infatti di un’utopia realizzata, ma di uno spazio-tempo cui aderire con tutte le qualità umane, razionali ed emozionali. Dunque quello spazio può incarnare il Terzo Mondo non perché terzo in una scala di importanza, ma in quanto terzo elemento di una contrapposizione tra blocchi che non si riesce più a sopportare, via di fuga e di nuovo inizio, al seguito di José Arcadio e di Úrsula, e potrà essere allora veramente lo spazio di un nuovo esotismo, in cui l’alterità dello spazio serve a costruire un’alternativa al proprio sentimento di inadeguatezza e di spaesamento.
Cent’anni di solitudine smentisce inoltre con un colpo di bacchetta magica tutte le più fosche previsioni sulla morte del romanzo e ripropone, dal fondo dell’America Latina, una narrazione coinvolgente e affollata di personaggi forti: una forma data ormai per spacciata ma che il pubblico italiano, ed europeo in generale, mostra di apprezzare molto, ancora avido di storie, di una scrittura affascinante, capace di funzionare su più livelli di lettura. La platea dei destinatari possibili si rivela allora potenzialmente immensa, ben più ampia di quella solo giovanile, giacché quei personaggi sono capaci di provocare tanti e tali processi di identificazione da accontentare qualsiasi lettore. La scommessa del romanzo di García Márquez si gioca proprio sull’incontro possibile con un pubblico senza confini: parte dalla volontà universalistica per uscire dagli angusti confini del localismo e parlare a un uditorio continentale, ma il suo percorso si allarga per incrociare lettori in grado di creare il caso letterario, di interpretare quei “racconti della nonna” in chiave universale. Rispetto ai libri degli altri protagonisti di quella stagione straordinaria della narrativa ispanoamericana, Cent’anni di solitudine è in fondo un romanzo abbastanza tradizionale, assai meno segnato dalle sperimentazioni – ad esempio, rispetto a Fuentes o a Cortázar – ma proprio questa sua struttura riconoscibile gli permette di essere facilmente accettato da un pubblico medio, una classe sempre più numerosa di lettori che si pone a metà tra le letture popolari e l’élite dei professionisti della cultura. Il Sessantotto segna anche l’imporsi di questa nuova categoria di lettori, che già avevano sanzionato il successo di quello che viene definito il «best-seller all’italiana», e che sono i primi e più numerosi acquirenti dei romanzi latinoamericani. Il suo successo influenzerà anche le scelte editoriali degli anni a venire, e non solo nel favorire l’esplosione del boom latinoamericano: non bisogna dimenticare che pochi anni più tardi un nuovo best-seller di qualità sarà La storia di Elsa Morante, altra narrazione familiare fortemente intrisa di eventi reali e di personaggi forti.
La traduzione ha poi a mio avviso un ruolo non secondario nel moltiplicare quell’immagine esotica. Il traduttore scelto dalla Feltrinelli per Cent’anni di solitudine fu Enrico Cicogna. Dopo aver iniziato con il giallo hard-boiled statunitense, Cicogna diventa negli anni sessanta il traduttore ufficiale dei narratori del boom ispanoamericano e sotto le sue mani passeranno non solo García Márquez, ma anche Vargas Llosa, Onetti, Puig, Bryce Echenique, Scorza. Insieme a Gianni Guadalupi, Marcelo Ravoni, Francesco Tentori Montalto e pochi altri, può essere annoverato come il principale artefice della trasposizione in italiano della lingua letteraria ispanoamericana, tanto da essere considerato il mediatore privilegiato tra un universo immaginario di straordinario spessore iconico e un pubblico come quello italiano che, salvo gli specialisti, fino ad allora considerava il continente latinoamericano poco più che uno spazio vuoto, del tutto privo di una cultura letteraria di valore apprezzabile.
Nella narrativa di García Márquez le immagini svolgono un ruolo primario. Macondo si costituisce come luogo dell’immaginario dai contorni ben definiti, in cui la presenza tangibile delle cose è assicurata dalla pregnanza dell’icona, dalla sua perfetta compiutezza nei minimi dettagli, tanto che i lettori potrebbero affermare di vederne le case e la gente anche senza alcun supporto illustrativo. La traduzione assume dunque una funzione centrale, in quanto permette di visualizzare quel luogo e non un altro, e di poterlo osservare con la precisione voluta dall’autore, e non in maniera sfocata e indistinta. A una lettura più attenta, tuttavia, ci si può porre legittimamente una domanda: la Macondo che si ritrova nelle traduzioni italiane è la stessa dell’originale? Un primo sguardo sembrerebbe permettere una risposta affermativa. Tranne qualche eccezione, non si apprezzano errori clamorosi e il testo sembra funzionare in maniera abbastanza scorrevole, come peraltro testimonia il notevole successo. In realtà non tutto funziona come dovrebbe. I diversi livelli di traducibilità di un testo permettono di misurare la capacità di una traduzione di restituirci l’universo d’origine: i realia esclusivamente locali, quasi non traducibili; il lessico specialistico legato al mondo del lavoro o alle specifiche caratteristiche storiche del luogo; il livello del linguaggio colloquiale, i dialoghi e le espressioni idiomatiche, i gesti e le descrizioni dei personaggi; l’iconicità grammaticale-retorica. Si può partire da dettagli apparentemente minimi, come il vocabolario di piante e animali. Gli abitanti di Macondo che seguono José Arcadio nella ricerca del mare si ritrovano nella foresta, costretti a comer guacamayas, cuya carne azul tenía un áspero sabor de almizcle. I loro omologhi in italiano si nutrono invece di «pappagalli, la cui carne bluastra aveva un aspro odore di muschio». Peraltro i turpiales erano diventati «itteri» (confondendo famiglia per specie), gli aranci silvestres diventano «silvestri», gli alcaravanes semplicemente «galline» (e non occhioni), ma soprattutto il castaño dei Buendía si trasforma in un «castagno» italiano (e non in un più specifico castaño de Indias, dunque un ippocastano). Tutto diventa più banale, meno preciso, e di fronte a questa natura si rimane solo «stupefatti», e non pasmados de fascinación come nel testo originale.
La perdita del senso procede però anche in un’altra direzione, quando si assiste a una artificiale complicazione del linguaggio. I segni di García Márquez, spesso polisemici, ricchi, ma quasi mai oscuri, diventano infatti nella traduzione curiosità antiquarie, oggetti desueti, segni di uno spazio e di un tempo in cui il meraviglioso diventa una necessità inevitabile. Se torniamo allora alla memorabile pagina iniziale, scopriamo che gli zingari «cenciosi» (ma il desharrapados dell’originale non contiene una così forte connotazione dispregiativa) suonano «zufoli» (pitos, pifferi, o ancor meglio fischietti), e gli abitanti di Macondo «sbigottirono» (se espantó) di fronte alle novità, e i chiodi iniziano a «schiavarsi» grazie alla potenza della calamita di Melquíades (desenclavarse, cioè schiodarsi) e «si trascinavano in turbolenta sbrancata» (y se arrastraban en desbandada turbulenta). Non va meglio ai segni della storia, dato che la regina Isabel, cui Francis Drake invia i caimani impagliati, diventa la ispanica «Isabella» con un ardito salto di tempo e di luogo (e non l’inglese Elisabetta), che la ranchería fondata dagli antenati si trasforma in pueblo, mentre in italiano il «villaggio» si trasforma in «borgo» (perché non in paese?), che il corregidor diventa un improbabile «corregitore», parola arcaica che non chiarisce il ruolo politico di Don Apolinar Moscote, che era quello di ispettore, e che Úrsula sorvola su trecento anni di «accidenti», inutile accentuazione delle assai più innocue casualidades. L’effetto generale di questo lento accumularsi di parole oscure è quello di immergere il lettore in una sorta di «aggallato della dimenticanza», luogo misterioso che cerca di tradurre lo splendido tremedal del olvido, in cui cadono i macondini durante la peste dell’insonnia.
Tornando allora alla domanda iniziale si dovrà osservare che la Macondo italiana si trasforma in un luogo abbastanza diverso, più indefinito, confuso, lontano, anche un po’ arcaico, certamente più esotico, nel senso profondo del termine, con una elevazione a potenza del meraviglioso, mentre il reale sfuma nell’indistinto. Non sarà allora solo per un errore (questo sì clamoroso) che nel travolgente finale di Cent’anni di solitudine quella che è la ciudad de los espejos (o los espejismos) diventa una più banale «città degli specchi (o degli specchietti)». La trasformazione dell’espejismo – il miraggio dell’originale – in «specchietto» segna la perdita di uno spessore della scrittura di García Márquez, nell’oscillare continuo tra inutili complicazioni lessicali e improvvide banalizzazioni della differenza.
Gli autori del boom: fu vera gloria?
Intorno a Cent’anni di solitudine si costruisce anche in Italia quello che la pubblicistica prima e poi la critica hanno chiamato il boomdella letteratura latinoamericana. La definizione nasce evidentemente in ambito non letterario e attiene più al successo commerciale dei libri che a una loro puntuale valutazione critica, ma dal nostro punto di vista proprio il suo carattere approssimativo ci permette di misurare quali furono virtù e difetti della comprensione in Italia di quella nuova ondata di narratori. Il fenomeno non è peraltro solo italiano, e anche la stessa definizione veniva d’oltreoceano, dove era stata usata fin da metà degli anni sessanta per segnalare il notevole incremento nelle vendite di alcuni autori che iniziavano a comporre un gruppo eterogeneo di scrittori di riferimento: in Messico e in Argentina i successi editoriali di Fuentes, Cortázar, Vargas Llosa precedono quello di García Márquez e in qualche modo già segnano il cammino da percorrere.
La strategia degli editori italiani maggiormente coinvolti ricalcava quella delle case editrici argentine e messicane che avevano dato il via al fenomeno, poi sostenute da un editore spagnolo, quel Carlos Barral che aveva portato in Europa gli autori più importanti della nuova generazione, e da una formidabile agente letteraria, Carmen Balcells, vera madre putativa di tutta quella generazione. L’obiettivo era quello di creare un solido gruppo di narratori che potesse fornire il materiale necessario a una operazione di catalogo: non si trattava di scoprire il singolo autore, o l’opera di genio, ma di fornire al pubblico europeo l’immagine di un intero continente che sembrava svegliarsi allora alla creatività letteraria, e di costruire attorno a essa una durevole proposta culturale.
La questione centrale era di nuovo quella della selezione, e in effetti una delle domande che gli stessi scrittori si ponevano era: chi appartiene al boom? Le risposte furono variegate, a volte anche molto polemiche, e non chiarirono bene i confini di un fenomeno troppo legato a motivazioni commerciali per poter sopportare analisi severe. Si stabilisce comunque una graduatoria, o perlomeno un gruppo di autori che agli occhi dei lettori europei costituiscono un insieme riconoscibile: Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, e poi in ordine sparso autori della taglia dei cubani Carpentier e Lezama Lima, del cileno Donoso, degli argentini Sabato e Puig, tutti sempre però in secondo piano. A partire dalle loro opere si forma un vero e proprio canone della letteratura ispanoamericana, sostenuto anche dalle riflessioni che loro stessi si preoccupano di portare avanti, in numerosi libri e articoli di giornali e riviste. Il boom non ebbe dunque solo un effetto quantitativo, ma anche notevoli conseguenze sul piano qualitativo, funzionando come primario momento di selezione, al quale ci si riferirà poi ogni qualvolta la letteratura ispanoamericana tornerà in auge. Non per niente, nella seconda metà degli anni novanta saranno recuperati proprio quei romanzi pubblicati negli anni sessanta, ricollocati e ripresi in una visione non poi così cambiata. Se il panorama europeo risulta abbastanza omogeneo, in Italia comunque la lista prima ricordata funziona fino a un certo punto: una immaginaria classifica di traduzioni e ristampe vede emergere nomi che non sempre vengono inclusi nel catalogo del boom.
Dopo García Márquez troviamo infatti, per numero di traduzioni e ristampe, Mario Vargas Llosa, e fin qui niente di strano, ma accanto a lui si pone Juan Carlos Onetti, di cui si traducono i romanzi degli anni cinquanta, e poi Manuel Puig, José Donoso, Adolfo Bioy Casares e Julio Cortázar. Alcuni editori minori puntano ancora sul realismo degli anni trenta e quaranta (Asturias, Caballero Calderón, Otero Silva), mentre altri si rivolgono alla narrativa della giovanile «Onda» messicana (Sainz, José Agustín, Elizondo) o alla letteratura cubana (Miguel Barnet, Norberto Fuentes, Arenas). Sulla scia di Borges e di Bioy Casares la Einaudi pubblica anche Silvina Ocampo e Felisberto Hernández, mentre su un versante opposto si scopre l’indigenismo di Arguedas e si inizia a pubblicare la saga andina di Manuel Scorza. Come si può osservare quello che colpisce è l’estrema dispersione delle scelte, come se la fretta di inseguire il successo letterario del momento impedisse di elaborare un progetto coerente, o di presentare in maniera corretta autori anche molto distanti tra loro. Nella valanga alcuni vengono travolti, e tra essi risalta l’assenza del nome di Carlos Fuentes: di fatto, dopo Cambio di pelle (Di Michele e Calidon 1967), un pesante insuccesso dal punto di vista delle vendite, non viene più tradotto niente dello scrittore messicano; solo La morte di Artemio Cruz (Di Michele 1966) conoscerà qualche ristampa nel periodo di cui ci occupiamo. Oltre a Fuentes, spiccano le assenze di autori come Roa Bastos e Ribeyro, che arriveranno in Italia più tardi e saranno assorbiti dal buco nero del post-boom, o come Bryce Echenique, che si vedrà pubblicato il suo romanzo pesantemente tagliato in traduzione (Cicogna 1974), o ancora Arreola, Viñas, Revueltas, Yáñez, per citare in ordine sparso solo qualche nome, mentre scompaiono Sarduy e Carpentier. Manca poi in maniera clamorosa tutto l’universo femminile, tanto da giustificare le riserve di Rosario Ferré (1990) sul boom come fenomeno pesantemente misogino.
Il sistema di testi che alla fine viene fuori presenta allora alcune linee guida forti, legate ai romanzi di García Márquez, ma con significative aggiunte e diversificazioni, dalle quali nasce un’immagine complessiva di un certo spessore. Come nei libri dello scrittore colombiano, anche nella divulgazione degli altri autori ispanoamericani hanno un ruolo cruciale le immagini, e non solo per la natura fortemente iconica dei romanzi tradotti in questi anni. La funzione dell’immagine deve essere qui quella di mettere in moto il pubblico, di farlo reagire positivamente, di permettergli un’identificazione altrimenti difficile, data la distanza spaziale, la sostanziale ignoranza geografica e storica e la diversità della situazione sociale del lettore medio italiano.
Quelle immagini che si vengono a sovrapporre fino a costruire un paesaggio spaziale, storico e sociale verosimile emergono però essenzialmente da testi di finzione e solo la collaborazione attiva del lettore così sollecitato può farli nascere alla realtà. Da tale processo nasce l’immagine dell’America Latina in Italia, destinata per la sua stessa natura a trasformarsi ben presto in stereotipo, legato peraltro in modo inestricabile alla rappresentazione di una diversità e di una lontananza che rimangono irriducibili, nonostante tutti i tentativi di addomesticamento e di banalizzazione. I lettori italiani utilizzeranno allora una serie di immagini per potersi raffigurare un’alterità altrimenti incomprensibile, per diminuire la distanza e cercare un avvicinamento a un mondo “possibile”.
I romanzi ispanoamericani diventano allora a pieno titolo degli oggetti culturali, attivati da un insieme di lettori segnati da un orizzonte d’attesa che Italo Calvino sintetizza con queste parole:
Nella letteratura c’è la diffusa sensazione d’un fallimento, d’un bisogno di ricominciare da zero; non parlo della microletteratura italiana dell’ultimo ventennio la cui caduta è proporzionata al suo basso volo, ma parlo delle proposte più ambiziose del Novecento europeo che diventano ogni giorno di più insoddisfacenti. E questo si verifica al livello della gioventù più intellettualmente esigente: non perché non si interessa più di letteratura (come pare avvenga oggi in Italia) ma perché se la letteratura è vissuta come ragione rivoluzionaria (come pare lo sia nella gioventù francese, a livello di massa, non di leaders) lo è come richiesta ancora da assolvere, esigenza in larga parte in bianco, pagina ancora da scrivere (Calvino 1980, 234-235).
Quella gioventù andava allora a cercare le nuove proposte, le «ragioni rivoluzionarie» in libri e autori che sembravano arrivati apposta per soddisfare quelle necessità, ma nello stesso momento in cui si apriva al mondo iniziava anche a costruire un sistema di stereotipi, di immagini astratte e schematiche considerate immanenti a quel sistema di testi.
Se sono questi i protagonisti del boom della narrativa ispanoamericana in Italia a cavallo degli anni settanta – una manciata di autori, e un numero abbastanza limitato di romanzi – sarà dunque il caso di domandarci: fu vera gloria? Se l’analisi quantitativa permette una risposta decisamente affermativa, quella qualitativa ci obbliga a essere meno categorici. Di certo non fu un fuoco di paglia dettato solo da una moda passeggera, o una costruzione tutta giocata su presupposti ideologici extra-letterari, guidati dalla longa manus cubana; ma, a parte i pochi nomi ricordati, nessuno degli autori presentati al pubblico italiano si inserisce stabilmente nei gusti e nella memoria dei lettori per il suo valore intrinseco. Il fenomeno del boomimpone un continente letterario, apparentemente venuto dal nulla, nel suo insieme, senza tante sottigliezze, e ognuno dei libri rimanda all’altro, in un sistema autoreferente che di certo è legato anche a fenomeni extra-letterari, ma le ragioni del successo sono da ricercare essenzialmente proprio in quella capacità evocativa che porta con sé messaggi e progetti estremamente coinvolgenti per tutta una generazione.
L’operazione editoriale del boom latinoamericano in Italia rivelerà allora nello stesso tempo le sue fragili fondamenta, legate da una parte a una volontà solo commerciale di sfruttare una denominazione di origine geografica diventata improvvisamente di moda, e dall’altra a motivazioni che traggono le loro radici più in Italia che nel continente americano (come la scelta rivoluzionaria pro-cubana della Feltrinelli o la ricerca nel campo del fantastico che Italo Calvino persegue in Einaudi), ma quel canone messo insieme così alla rinfusa condizionerà a lungo la conoscenza della letteratura ispanoamericana, e verrà poi soppiantato solo da una visione ancora meno completa, e complessa, di quella realtà. Dunque una storia di pochi autori e di pochi editori, con alcuni buoni successi e molti fallimenti, causati dalla fretta di rincorrere la moda, dallo scarso lavoro di cura dei testi, da una diffusa sottovalutazione di tipo culturale rispetto a quel mondo. Nonostante tutto, il pubblico italiano riesce a costruirsi un’immagine di quel continente, un’idea che sembra venire offuscata dalla crisi della seconda metà degli anni settanta, ma che in realtà ha messo radici ben solide. Il boomallora non fu probabilmente dal punto di vista della critica letteraria una gran fortuna, ma per l’immaginario collettivo funzionò benissimo, e non è possibile negarlo.
Fine del boom e autori che spariscono
A metà degli anni settanta il boomsi sgonfia tanto in fretta come era iniziato e le ragioni di un tale repentino calo di interesse da parte del pubblico sono come sempre molteplici e non chiamano in causa solo l’oggetto specifico della letteratura ispanoamericana, ma tutta una serie di cause concomitanti. Il primo dato da evidenziare è quello della coincidenza temporale tra la disaffezione del pubblico italiano e l’ultima fase della riorganizzazione dell’editoria italiana in senso industriale, un processo iniziato fin dalla metà degli anni sessanta e che, attraverso varie fasi, porta a una situazione di concentrazione editoriale ben conosciuta. In tale quadro, la situazione della letteratura latinoamericana in questi anni riproduce alcuni aspetti di quella concentrazione: una rapida saturazione del mercato, generata da proposte editoriali disomogenee e caotiche, che causa un senso di disorientamento nel pubblico. Non bisogna dimenticare che l’America Latina era stata considerata fino a pochi anni prima come uno spazio totalmente naturale, praticamente senza cultura. Dunque quel primo contingente di narratori e poeti veniva erroneamente considerato come una prima avanguardia, e come tale segnata dai limiti propri delle esplosioni troppo violente; infatti, come spesso accade nel mondo dei libri, le loro seconde prove non avevano trovato la stessa accoglienza degli esordi, ma il lettore italiano non poteva sapere che spesso quelle seconde proposte erano state invece le prove giovanili nei paesi di provenienza, recuperate dal mercato editoriale per rispondere a una domanda che si era fatta improvvisamente avida di novità latinoamericane.
Il collegamento di quei progetti editoriali con l’attualità politica, nel momento in cui il continente latinoamericano sembrava essere al centro del mondo, aveva provocato altresì un fenomeno per il quale leggere García Márquez o Scorza significava essere alla moda, testimoniare con il proprio atteggiamento una solidarietà, perlomeno intellettuale, con una parte del globo che stava soffrendo e lottando. Molti di quei sentimenti erano di certo motivati da un sincero impegno politico, ma rimanevano appunto al livello dei sentimenti, mancando totalmente di quell’approfondimento che sarebbe stato necessario per capire davvero la politica come l’economia, la storia come la letteratura. Il colpo forse mortale per quell’incipiente mercato librario non viene infatti dalle situazioni editoriali, peraltro importanti, ma dal mondo della politica, come era d’altronde accaduto anche nel Sessantotto. A partire dai primi anni settanta, infatti, in tutta l’America Latina la prospettiva rivoluzionaria viene rapidamente travolta dall’instaurazione di durissime dittature militari. Quelle che si scatenano in Argentina e in Cile hanno un impatto molto forte in Italia, con una sequela di esiliati che trovano rifugio nel nostro paese. Quella violenta rottura del quadro di riferimento avrà delle conseguenze profonde anche sul piano dell’immaginario, giacché viene a essere cancellata quella visione del continente latinoamericano come spazio della rivoluzione possibile, dell’utopia finalmente realizzata. I racconti delle torture, delle scomparse di massa di un’intera generazione, degli esili e della impossibilità di modificare la situazione rivelano un aspetto dell’America Latina che per molti significò un tragico risveglio da un suadente sogno tropicale. La metanarrazione rivoluzionaria che era servita per interpretare anche i romanzi, i racconti o le poesie svanisce dal panorama, e rimarrà solo come una vaga nostalgia, che riemergerà, come vedremo, solo molti anni dopo.
Quando poi in Italia a un tale quadro si sommerà l’esperienza degli anni di piombo, anche Che Guevara scomparirà dagli scaffali delle librerie, l’iniziale solidarietà verso gli esuli diminuirà progressivamente e il continente letterario recentemente scoperto sembrerà di nuovo inabissarsi nelle lontananze.
L’editoria di sinistra, che tanto aveva puntato sulla narrativa e sulla saggistica di quei paesi, in quello stesso momento entra in una grave crisi, causata anche da una errata politica di diffusione sperimentata negli anni precedenti. Le proposte letterarie e culturali riguardanti l’America Latina erano state selezionate e giustificate in base ad affinità ideologiche, senza andare troppo per il sottile per quanto riguardava la qualità dei testi e la validità dei ragionamenti. La dimensione dell’autore era stata ad esempio sacrificata in favore di quella del messaggio, dei contenuti del testo, e ora che quelle motivazioni erano così rumorosamente crollate, non rimanevano ragioni valide per interessarsi ad autori che sembravano ripetere sempre le stesse cose: nel 1979 Lucio Dalla canta, in Il cucciolo Alfredo, «la musica andina, che noia mortale…», liquidando così un decennio di Inti Illimani alle Feste dell’Unità.
Come era avvenuto nel periodo precedente, anche qui è un romanzo di García Márquez a segnare il momento di passaggio. Nel 1975 viene stampato il suo attesissimo nuovo libro, L’autunno del patriarca (Cicogna 1975), che appare in contemporanea in diversi paesi del mondo. L’edizione italiana, pubblicata di nuovo da Feltrinelli, è preceduta da una notevole campagna pubblicitaria. Il pubblico lo accoglie all’inizio con notevole interesse, ma il successo non risponde alle aspettative e le vendite rimarranno molto inferiori a quelle di Cent’anni di solitudine. Si diffonde ben presto la voce che la nuova prova dello scrittore colombiano non mantiene le promesse e si dovranno aspettare ben tre anni prima di vederne una ristampa. Anche la critica si divide ben presto in due: le recensioni di coloro che sono maggiormente legati all’ispanoamericanismo ne lodano le qualità letterarie e di costruzione dell’intreccio, mentre le altre rimangono abbastanza fredde, e non cadono nella stroncatura dichiarata solo per il timore dell’impopolarità. Il pubblico italiano si trova per varie ragioni abbastanza spiazzato rispetto alle aspettative del nuovo romanzo. La prima riguarda la tematica scelta dallo scrittore colombiano: la questione della dittatura personale era stata al centro di numerose riflessioni narrative, che si erano andate moltiplicando nella prima metà degli anni settanta, tanto che L’autunno del patriarca potrebbe essere considerata la conclusione della serie. Nel 1975 la questione politica che García Márquez affronta sembra però superata dagli eventi: le dittature militari superano in peggio qualsiasi capacità immaginativa, e non sono più legate a figure stravaganti di caudillos ma a freddi esecutori di piani ideologicamente e rigidamente preparati altrove.
La seconda ragione di difficoltà nasce dalla stessa costruzione narrativa, in cui il continuo spostamento del punto di vista produce una situazione di tensione e di incertezza, in cui niente appare verosimile e credibile, in una realtà falsata da un personaggio principale che crea trappole fatali per oppositori, nemici e lettori, e in cui anche il tono di denuncia si stempera in un’analisi della figura del dittatore capace di seminare più dubbi che certezze. Infine, anche la tecnica di scrittura non agevola la lettura: quei lunghi capitoli senza punteggiatura, quelle frasi in cui il soggetto scompare e cambia di posizione proiettano il lettore in un’atmosfera di sperimentalismo estranea all’immagine dello scrittore colombiano: Cent’anni di solitudine aveva restituito il piacere del romanzo tradizionale, e L’autunno del patriarca invece se ne distacca, avventurandosi in una prosa affascinante e complessa.
In una tale situazione, la traduzione svolge anche qui un ruolo fondamentale e la moltiplicazione dell’effetto straniante della parola tradotta – già osservato prima – raggiunge il suo culmine. Nella traduzione di Enrico Cicogna, tutto quello che avevamo visto in precedenza affacciarsi qua e là diventa invadente, terribilmente pesante, a partire dalla prima pagina, in cui ci si trova di fronte, in rapida successione, a un tempo «stagnato» (estancado, dunque meglio fermo, immobile, o stagnante), a uno «sbandellare» (desquiciar) i portoni che peraltro si reggono su dei «gangheri» (goznes), a una «malerba» (maleza) che invade il giardino, a «memoriali inevasi» (memoriales sin revolver), per procedere lungo tutto il libro nella stessa linea. Quando poi nel testo appare un dialogo indiretto, con forme colloquiali inserite all’improvviso nel corso della narrazione, l’effetto della traduzione rasenta il comico involontario. Basti ricordare il momento in cui il Patriarca offre al suo sosia le sue numerose concubine per consolarlo di una imprevista delusione d’amore: quella che nell’originale è una tappa dell’identificazione tra il Patriarca e Patricio Aragonés, giocata su un’evocazione giocosa che non cede mai alla satira aperta, nella traduzione diventa una sorta di macchietta da avanspettacolo. Si noti poi che il forte carajo, usato spesso dal Patriarca nel suo parlare, si trasforma in un più pudico «diamine», che qui ancora risulta comprensibile: poco più avanti, però, diventerà un incredibile «diancine». Non sorprenderà che lo stesso Patriarca si trasformi più tardi da «motteggiatore (bromista) e linguacciuto» a «meditabondo (meditativo) e ombroso», e da «scioperato e vitaiolo» (holgazán y vividor) diventi «taccagno e rapace». In L’autunno del patriarca il gioco della traduzione diventa allora davvero eccessivo, e il passaggio da una lingua all’altra segna una trasformazione radicale, tanto che ci si può chiedere se quell’enfatizzazione non sia una delle cause (anche se certo non l’unica) del minore favore con cui il romanzo venne accolto in Italia.
Quel riflusso provocherà comunque un devastante effetto negativo, per almeno tre ragioni: gli autori tradotti e già presenti sul mercato non vengono più ristampati, le nuove traduzioni passano sotto silenzio e gli autori che si affermano nei loro paesi proprio negli anni settanta non verranno presi in considerazione.
Nel primo gruppo si possono ricordare i casi di Carlos Fuentes, Onetti, Donoso, Bioy Casares, Lezama Lima, Arenas, Sarduy, tutti più o meno scomparsi dai cataloghi, ma anche autori come Vargas Llosa e Puig faticheranno a rimanere presenti tra le proposte editoriali. Il gruppo degli scrittori tradotti e presto dimenticati è ancora più folto, e annovera nomi che non riusciranno più a imporsi all’attenzione del pubblico italiano, se non quando miracolati da eventi extra-letterari, peraltro assai rari, come avviene per Antonio Skármeta, che deve tutta la sua futura popolarità al fortunato film con Massimo Troisi Il postino. Non succederà nulla di simile per Augusto Roa Bastos, Mario Benedetti, Julio Ramón Ribeyro, Antonio Di Benedetto, Guillermo Cabrera Infante, Alfredo Bryce Echenique, tutti apparsi come meteore intorno alla metà degli anni settanta, e poi solo parzialmente recuperati, ma per alcuni di essi bisognerà aspettare addirittura il nuovo millennio.
La situazione di tutti quegli autori che emergono in questi anni e che non raggiungeranno mai i lettori italiani, o che lo faranno solo dopo molto tempo, è invece davvero un lungo catalogo delle assenze, di fronte al quale ci si potrebbe davvero domandare se sia possibile a questo punto parlare di una reale percezione della letteratura ispanoamericana, o se non si dovrebbe affermare che ci troviamo di fronte a una visione molto parziale e limitata di essa e in parte fuorviante. Sta di fatto che tutti i paesi dell’America di lingua spagnola vengono ugualmente penalizzati da questo periodo di oblio, e gli argentini Juan José Saer, Daniel Moyano, i cileni Jorge Edwards e Poli Delano, o i cubani come Virgilio Piñera e Antonio Benítez Rojo rimangono tagliati fuori per molti anni dai circuiti dell’editoria internazionale. Nello stesso tempo la crisi economica che colpisce un po’ tutto il continente provoca il disinteresse delle multinazionali dell’editoria verso un mercato considerato debole e inaffidabile, e di conseguenza anche il Messico, il Venezuela, la Colombia o l’emergente letteratura portoricana verranno trascurati per un considerevole numero di anni. D’altro canto, anche un genere come la letteratura di impegno sociale o quello della cosiddetta letteratura testimoniale saranno ugualmente lasciati da parte, con autori come David Viñas, Rodolfo Walsh, Carlos Monsivais o Elena Poniatowska, per non parlare del silenzio che ancora avvolge la voce delle donne, tra le quali converrà ricordare, tra le altre, Martha Lynch, Elena Garro, Marta Traba, Rosario Ferré e Angélica Gorodischer. Di fronte a una tale quantità di nomi, scelti solo tra quelli che a giudizio della critica e del pubblico dei rispettivi paesi di appartenenza sono risultati più significativi, non si potrà ricorrere ad alcun possibile criterio di selezione e bisognerà semplicemente riconoscere l’inabissamento di tutto un continente letterario, di cui rimangono a galla solo quei pochi nomi riconosciuti come indispensabili.
Registrare la crisi potrebbe avere un semplice valore memorialistico o testimoniale, come la segnalazione di qualche anno di buio, peraltro nemmeno troppo lungo se osservato nel lungo periodo, e si potrebbe essere tentati di metterla tra parentesi, ma in realtà proprio in questi anni si prepara la svolta successiva e i cambiamenti che ne seguiranno. Il fatto che sopravvivano alla crisi solo alcuni autori, e che scompaiano nello stesso tempo la prospettiva globale e le motivazioni politiche, prepara il terreno a una proposta editoriale che sarà imperniata sui best-seller, sui grandi nomi in grado di assicurare copiose vendite sui mercati europei e statunitensi. La crisi opera una selezione darwiniana per la quale rimangono in vita solo quei libri funzionali a un discorso di marketing in cui l’America Latina avrà una sua precisa dimensione nell’immaginario. L’altra metanarrazione conosciuta, quella del realismo magico – sulla cui esatta definizione le idee sono peraltro ancora poche e confuse – si imporrà allora come dominante, e verranno dunque salvati quei caratteri del magico, dell’esotico, della passione, della generosità degli uomini, delle donne e della natura, mentre le questioni problematiche, i parallelismi con il Vecchio Continente, le contraddizioni saranno messe da parte, inservibili in una dimensione globale dell’industria culturale, in cui ognuno deve avere un suo ruolo preciso.
Ancora Márquez: Cronaca di una morte annunciata e L’amore ai tempi del colera
Il superamento della fase critica coincide ancora una volta – e forse non potrebbe essere altrimenti – con un libro di García Márquez: nel 1981, infatti, si pubblica Cronaca di una morte annunciata (Puccini 1981), non più con Feltrinelli, ma con Mondadori, e il cambiamento non è casuale.Alla fine del 1982 lo scrittore colombiano riceve il Premio Nobel e a partire dal 1983 il grafico delle novità e dei libri disponibili sul mercato librario riprende a crescere, prima timidamente, poi in maniera sempre più impetuosa. L’incremento non conoscerà più sosta, anche perché legato a un processo di mutamento della struttura editoriale che esige un sempre maggior numero di novità da pubblicare, e il serbatoio ispanoamericano si dimostrerà ancora molto ricco.
Tutto il processo avanza di pari passo con una profonda trasformazione dell’industria editoriale italiana. All’inizio degli anni ottanta il processo di concentrazione e di acquisizione di marchi si è ormai delineato con sicurezza. Da una parte ci sono quattro-cinque grandi gruppi editoriali che controllano una sempre crescente quota del mercato, dall’altra un gruppo di editori medio-piccoli, attivi soprattutto nell’editoria specializzata, che difendono una loro caratteristica nicchia di pubblico, per concludere con una miriade di piccoli e micro-editori dalla vita estremamente incerta. Il libro è ormai diventato una merce a tutti i livelli e su di esso agiranno le onnipresenti e onnivore leggi del marketing e non più quel mix di intuizione culturale, di capacità di comprendere la domanda del pubblico e di saper trovare le migliori proposte tra gli autori del tempo presente che era stata la caratteristica dell’editore carismatico del passato. Qualsiasi riflessione sulla reale diffusione dei libri e sulla loro capacità di influenzare l’immaginario non può a questo punto prescindere da una tale condizione: la macchina produttiva dell’editoria contemporanea non può aspettare che si manifestino i bisogni culturali nel pubblico, ma deve continuamente crearne di nuovi, o mantenere in vita quelli esistenti, con processi legati essenzialmente a logiche di profitto industriale.
Anche la letteratura ispanoamericana tradotta in italiano viene condizionata da questo processo di trasformazione, per quanto apparentemente in maniera meno traumatica. Una delle questioni da porsi sarà allora capire quale ruolo essa ricopra nelle progettualità del marketing editoriale e in quale misura tali pianificazioni incidano sulle scelte dei libri e sulle immagini del continente che vengono veicolate nel nostro paese, senza dimenticare che nello stesso arco temporale aumentano in maniera esponenziale gli apporti di altri ambiti culturali, come la televisione, il cinema, la musica, gli eventi sportivi, la gastronomia, il turismo, tutti elementi che prima o poi si coniugano con l’America Latina, sia come soggetto produttore che come oggetto di interesse.
Il romanzo che celebra definitivamente un tale cruciale passaggio è L’amore ai tempi del colera (Valentinetti 1986), naturalmente sempre a firma di Gabriel García Márquez, pubblicato in contemporanea in molti paesi del mondo alla fine del 1985 (in Italia all’inizio del 1986). Una copertina oltremodo seducente preparava già il terreno al testo: un Cupido che lanciava le sue frecce verso delle piante tropicali in un paesaggio di foresta lussureggiante, con sullo sfondo un battello a vapore che naviga in un fiume ai piedi di alte montagne. Il romanzo si presenta come una grande storia d’amore, costruita con la consueta maestria narrativa, piena di personaggi esuberanti e avventure sorprendenti. Gli elementi di continuità con i romanzi e i racconti precedenti, ben evidenziati dalla critica a livello di scrittura e di costruzione narrativa, servono nei confronti del pubblico dei lettori europei per confermare uno spazio letterario ormai conosciuto, per ritrovare quelle sensazioni già provate e gradite anni addietro. Il paesaggio di L’amore ai tempi del colera è infatti ormai un luogo familiare nel suo dichiarato esotismo: i pappagalli di Fermina Daza, la città coloniale dove si svolge la storia, il viaggio di Fermina con il padre nel secondo capitolo, il fiume su cui si muove il battello alla fine del libro sono tutti spazi preparati perché il lettore europeo li riconosca come lontani ma conosciuti, già visitati nella sua memoria culturale e, per una minoranza che inizia a crescere di numero, anche per frequentazione reale, grazie all’imporsi dell’America Latina, e in particolare dei Caraibi, come meta del turismo globale. La descrizione di quei luoghi dell’immaginario appare in effetti pericolosamente vicina a una cartolina turistica, e qui la traduzione segue il testo abbastanza da vicino, cadendo solo su alcuni “falsi amici”, privilegiando traduzioni troppo letterali. Se infatti Cicogna peccava per un inutile eccesso di orpelli barocchi, il traduttore di L’amore ai tempi del colera, Claudio Valentinetti, sembra soffrire di un eccesso opposto, quello di banalizzare un po’ tutto, con un’esagerata tendenza al letteralismo.
Ma in realtà anche la lingua di García Márquez si è andata semplificando, dopo lo sperimentalismo del Patriarca. La preoccupazione per il pubblico europeo diventa palpabile. Probabilmente nei libri precedenti i frutales dell’orto avrebbero avuto un nome preciso, e non quella definizione generica, come d’altronde avviene con gli animali che Fermina Daza porta in casa nei primi anni di matrimonio. Non ci sono più i guacamayos della foresta intorno a Macondo, ma dei più noti pájaros, loros, aves del paraíso. I personaggi presentano anch’essi numerosi segni di parentela con i loro predecessori di Cent’anni di solitudine e di L’autunno del patriarca, ma con leggeri e significativi mutamenti. Florentino Ariza è sì l’erede della fedeltà di Pietro Crespi e della sfrenata sessualità dei fratelli Buendía, ma lo è in forma giocosa, senza più quelle note di drammaticità che avevano segnato gli altri. Lo stesso avviene per Fermina Daza, sintesi delle molte donne dei romanzi di García Márquez, o per il dottor Urbina, assai simile ad Apolinar Moscote, ma con tratti sottilmente più ridicoli. La natura ossimorica dei protagonisti di L’amore ai tempi del colera viene da lontano, da una lunga frequentazione di personaggi estremi, ma qui rasenta la maniera, il riutilizzo di elementi ormai ben sperimentati. L’eccesso deve peraltro bilanciare qui la tematica, volutamente di carattere universale, legata a una problematica dei sentimenti che non era mai stata così esclusiva. Il romanzo non vuole più raggiungere l’affresco globale di tutto un continente, quanto piuttosto proporre una storia sui temi universali dell’amore, della fedeltà, delle relazioni tra le persone. Le tematiche politiche vengono messe sullo sfondo, fino a scomparire, e tutto si risolve in una generica solidarietà umana, ben lontana dalle problematiche situazioni della famiglia Buendía o del Patriarca immortale. Si potrebbe pensare che una tale attenuazione del discorso politico riesca a liberare i testi di García Márquez da una eccessiva carica “sudamericana” per proiettarli su una dimensione planetaria, ma in realtà quello che si raggiunge è una marcata semplificazione delle tematiche in una dimensione spaziale che diventa sfondo lussureggiante per evasioni tropicali.
La capacità di García Márquez di lavorare sulle immagini rimane peraltro intatta, e molti passaggi dei suoi nuovi romanzi rimangono straordinari, così come gran parte delle soluzioni narrative, ma il sospetto che inizia a serpeggiare è che proprio quell’insistere sulla forza delle immagini e il tentativo di coinvolgimento di lettori lontani riveli un compromesso ormai raggiunto tra le proprie radici e le richieste di un pubblico fondamentalmente estraneo a esse, a tutto vantaggio di quest’ultimo.
I primi lettori italiani del colombiano hanno infatti ormai superato abbondantemente la trentina ma non hanno dimenticato il fascino della terra di Macondo, e se pure non la vedono più come spazio per una rivoluzione possibile, rimane sempre un gran bel posto per proiettarvi i propri desideri di fuga. Gli scrittori ispanoamericani, e soprattutto i loro agenti, comprenderanno ben presto una tale possibilità e vi risponderanno con astuta maestria, creando una sorta di vera e propria letteratura per l’esportazione. Molti decenni prima – il saggio su L’opinione pubblica è del 1922 – Walter Lippmann aveva descritto con arguzia la formazione di questo tipo di pubblico:
Ma i grossi pubblici non digeriscono una tale severità. Essi provano interesse per se stessi più che per qualsiasi altra cosa al mondo. I se stessi per cui provano interesse sono quelli che sono stati rivelati dalle scuole e dalla tradizione. Essi insistono che un’opera d’arte deve essere un veicolo con un predellino che consenta loro di salire a bordo, e su cui possano andare non seguendo la conformazione di un terreno, ma alla volta di un paese dove per un’ora non vi siano cartellini da timbrare né piatti da lavare (Lippmann 1995, 183).
I lettori italiani cercheranno dunque nei romanzi di García Márquez, e nei molti imitatori che lo seguiranno, un valore di verosimiglianza, non con la realtà concreta del continente, in tumultuoso cambiamento, ma con l’idea che di quel mondo si sono costruiti, e quando la ritrovano saranno pronti a decretare il successo dei libri che gliela confermano. Quello spazio noto dovrà allora anche provocare reazioni di tipo emozionale legate alla memoria culturale e ideologica e permettere un doppio processo di identificazione: quello con i personaggi descritti e le loro avventure, e quello con i giovani lettori che si era stati qualche anno prima. Florentino Ariza e Fermina Daza sono capaci di risvegliare quelle emozioni: la fedeltà di Florentino non è allora solo rivolta all’irraggiungibile Fermina, ma diventa la cifra di una capacità di resistere nonostante i mutamenti dei tempi e i casi della vita, e di rimanere in qualche modo fedeli a sé stessi e ai propri sogni. Naturalmente questi romanzi devono perpetuare schemi e strutture già note, non potranno concedersi troppe libertà. Per evitare il rischio di perdere in riconoscibilità, il marchio di fabbrica dovrà essere ben evidente, e infatti d’ora in avanti il nome di García Márquez diventa una specie di segno di riconoscimento, da applicare non solo a suoi colleghi latinoamericani, ma anche a scrittori totalmente alieni a quella tradizione: scrivono «come García Márquez» scrittori anglo-indiani e kenioti e quel nome lo si potrà leggere sul frontespizio del romanzo di una scrittrice lettone, come sulla fascetta di un libro di un autore indonesiano.
Il destino che in tale senso attende gli scrittori latinoamericani è però quello di diventare pericolosamente monosemici, di vedersi attribuire un significato solo, e solo quello. Se García Márquez riesce parzialmente a sfuggire a un tale destino grazie alla sua intatta capacità affabulatoria, meno bene va ai suoi cloni, ingabbiati in una visione dell’America Latina che rischia di divenire caricaturale e condannati a ripetere all’infinito storie di rivoluzionari senza speranza, di donne appassionate fino alla follia e di famiglie stravaganti e onnipresenti.
L’industria editoriale si muoverà a partire da questi anni secondo un principio che nel gergo editoriale si chiama dei libri-gemelli: individuato un filone gradito al pubblico, si cercherà di moltiplicare quanto più possibile la produzione di volumi simili a uno di successo già sperimentato, procurando di non saturare il mercato, come era avvenuto durante il boom, ma di mantenerlo sempre vivo, per poterne sfruttare quanto più possibile le potenzialità commerciali. Il filone latinoamericano si basa sull’esempio di García Márquez, di gran lunga l’autore più venduto in tutto il mondo, che diventa pietra di paragone nella ricerca dei suoi “gemelli”. Tutto quello che potrà essere collegato a quell’universo immaginario sarà bene accetto, per gli altri non resterà che sperare nelle avventure editoriali di piccoli editori, spesso condannate al fallimento. In questo senso, la disavventura raccontata da Alberto Fuguet e Sergio Gómez, curatori dell’antologia di giovani narratori ispanoamericani ludicamente intitolata McOndo (1997), in cui un editore statunitense rifiuta i loro lavori in quanto poco “sudamericani” rispetto ai canoni del pubblico USA, si potrebbe applicare a gran parte della grande editoria italiana ed europea, e spiega ampiamente l’assenza delle traduzioni di tutti quegli scrittori giudicati troppo simili ai loro colleghi europei o nordamericani.
Può avvenire, poi, che alcuni di quei “gemelli” ottengano un successo simile a quello dell’originale (Isabel Allende, Luis Sepúlveda, Paco Ignacio Taibo II); e a partire dai loro nomi sarà possibile costruire altre serie di cloni, in un processo apparentemente infinito, come richiesto da un’industria in continua ricerca di prodotti da mandare sul mercato.
Il caso Isabel Allende e le altre scrittrici ispanoamericane
Il primo, e più clamoroso, caso di imitazione del modello García Márquez è appunto quello di una scrittrice, Isabel Allende, che si impone all’attenzione del pubblico con il suo romanzo d’esordio, La casa degli spiriti (Morino e Piloto Di Castro 1983). Il romanzo è costruito con molta sagacia: personaggi convincenti, un’ambientazione esotica senza esagerazioni, una buona dose di impegno politico privo di eccessi ideologici, e soprattutto la centralità dei ruoli femminili sembrano studiati su misura per il pubblico europeo, e anche i numerosi richiami a Cent’anni di solitudine funzionano come legame con una memoria culturale ben definita. La miscela di una scrittura scorrevole e non troppo impegnativa, di una storia accattivante, di una autrice donna con un cognome famoso rappresentava un insieme di fattori che non potevano che portare al successo; ma i tempi erano cambiati, e l’industria editoriale non poteva accontentarsi di uno scrittore che produce un romanzo ogni sei-sette anni, e infatti dopo La casa degli spiriti, ogni due anni arriva sul mercato una nuova proposta di Isabel Allende, con la serialità del prodotto industriale ben confezionato, e con lo sguardo attento all’evoluzione e al cambiamento delle mode: Afrodita segue la dilagante mania culinaria, La figlia della fortuna e Ritratto in seppia si collegano al romanzo storico, di grande successo nel mondo anglosassone, mentre la trilogia aperta da La città delle bestie è una specie di risposta sudamericana a Harry Potter. Una tale evoluzione segue ovviamente quella della macchina editoriale, tesa ad assecondare i processi di cambiamento del pubblico assicurando una sostanziale continuità nel ciclo produzione-consumo, con l’obiettivo di diminuire al minimo i rischi imprenditoriali: il pubblico può dunque avventurarsi in territori solo apparentemente nuovi, con la tranquillità di essere guidato da mani conosciute e di cui si fida. È inevitabile sottolineare come questi romanzi siano in primis dei prodotti industriali, costruiti con una ben precisa strategia di marketing studiata scientificamente, e che tale aspetto non possa essere taciuto o sottovalutato nel momento in cui si elabora un giudizio valutativo, che nel caso di Isabel Allende non può negarle una indubbia capacità nel saper costruire le storie e nel mantenere vivo l’interesse del lettore. In questo campo rimangono sempre valide le considerazioni di Vittorio Spinazzola sul romanzo di consumo:
Di fronte a casi di largo coinvolgimento dei lettori di base non si può non chiedersi quali ne siano gli aspetti di volgarismo degenerativo e quali invece rappresentino la percezione di esigenze disattese dagli scrittori di maggior ricchezza artistica. Ciò vuol poi dire distinguere tra le operazioni tese a immobilizzare o far regredire il patrimonio di consapevolezza estetica più diffuso e altre volte a farlo progredire, immettendovi i sintomi di una sensibilità incondita ma nuova (Spinazzola 1984, 37).
Uno degli elementi innovativi della scrittura della Allende coincide con il ruolo della donna, ormai divenuto centrale. E’ infatti il pubblico femminile, in rapida espansione in tutto il mondo, a rispondere per primo in maniera favorevole a quella proposta editoriale. Le donne che popolano quelle storie sono d’altronde dei veri modelli, che nella loro insolita accumulazione di elementi positivi, diventano facilmente la proiezione di un desiderio, di un voler essere che assai raramente corrisponde alla realtà: se poi tutto ciò si svolge fra i tropici e l’Equatore, il cerchio dell’esotismo si può effettivamente considerare chiuso. I lettori si trovano così di fronte eroine femminili/femministe, che si muovono in uno spazio esotico riconoscibile e desiderabile. Tutti gli elementi necessari a una versione aggiornata del “bestseller di qualità” sono qui convocati al massimo grado, in omaggio alle leggi del mercato editoriale e alle decisioni degli strateghi del marketing.
Le caratteristiche necessarie a questo particolare genere sono tutte lì, proprio dove ce le aspettiamo. Nulla nei romanzi della scrittrice cilena è lasciato al caso, o alla sperimentazione: il meccanismo appare perfetto, una infallibile macchina per suscitare emozioni giocando su immagini e situazioni già assorbite nell’orizzonte d’attesa dei lettori europei, compreso il frequente lieto fine.
Si ripropone qui lo stesso procedimento che aveva definitivamente consacrato lo stereotipo latinoamericano. Nella ormai stabilita nozione di reale meraviglioso i due termini non stanno più in relazione ossimorica, ma come aggettivi semplicemente consecutivi, giacché la meraviglia è solo lo sfondo necessario in cui si svolgono eventi ormai non così straordinari.
Una volta individuato infatti il pubblico di riferimento, in questo caso quello delle lettrici, si costruisce un prodotto dalle caratteristiche ben definite: una storia coinvolgente di facile leggibilità, con personaggi in cui riconoscersi che si muovono in uno spazio noto ma non quotidianamente banale. Sono tali caratteristiche a decretare il successo presso quel tipo di pubblico, e le storie di Isabel Allende rientrano totalmente in quella categoria, con il valore aggiunto di dare l’illusione della letteratura “alta”, grazie alle tecniche di scrittura imparate dai maestri della generazione precedente. Gli elementi che differenziano però i romanzi di Isabel Allende (e di altre autrici che seguiranno, secondo il principio dei libri-gemelli) dal romanzo rosa “classico” stanno nell’ambientazione e nel substrato ideologico dei personaggi. Della caratterizzazione degli spazi già si è detto, e si potrà solo aggiungere che nei romanzi successivi questa diverrà sempre più generica, anche perché il primo mercato di riferimento diventerà quello statunitense, meno legato all’immaginario latinoamericano di tipo europeo. Quale ruolo hanno invece le motivazioni ideologiche che muovono le azioni delle protagoniste dei romanzi della Allende e che la stessa autrice considera così importanti? Un femminismo light, un certo spirito ribelle, una dichiarata volontà di indipendenza che non scarta però appassionate storie d’amore, funzionano in questi testi come ingredienti che aumentano il grado di coinvolgimento del pubblico. Le storie di La casa degli spiriti, di Eva Luna o di Il piano infinito tendono infatti a un coinvolgimento dei lettori più sul piano del referente per avvicinare i personaggi ai sentimenti del pubblico di riferimento.
Lo stereotipo femminile/femminista latinoamericano funziona allora esattamente nella direzione indicata: il lettore/lettrice viene preso nella rete degli eventi, crede al racconto e proietta su di esso dei giudizi di tipo referenziale, morale ed emozionale, senza domandarsi se esso è il prodotto di un’operazione commerciale e ideologica. A tale proposito la coppia donna/latinoamericana funziona come un potente punto di attrazione, in quanto duplica la nozione di dipendenza e moltiplica il valore delle affermazioni sulla volontà di liberazione, in un quadro ideologico in cui la realtà di riferimento è ancora percepita come spazio dipendente neocoloniale.
Rimane comunque il fatto che il fenomeno Allende spalanca le porte del mercato italiano alle scrittrici ispanoamericane, d’ora in poi stabilmente presenti nelle proposte editoriali, anche in forma massiccia in alcune collane specificatamente dedicate alla scrittura delle donne. La stessa Feltrinelli a partire dal 1988 pubblica molte voci femminili, proponendo tra le altre Ángeles Mastretta, Mayra Montero o Marcela Serrano: le presentazioni rassomigliano però molto a quelle della Allende, con l’intenzione di mantenere viva l’attenzione dei lettori su una precisa idea di letteratura e di scrittura. Si cercano dunque storie appassionanti, con protagoniste femminili a tutto tondo, e che contengano preferibilmente un sottofondo sociale, anche solo accennato.
La questione che anche qui si apre riguarda però se tale versante della scrittura femminile rappresenti la totalità del continente, o se invece ne sia solo un aspetto, particolarmente apprezzato in Europa, ma non maggioritario nei rispettivi paesi di provenienza. Una prima risposta viene da un progetto, parallelo nel tempo ma diverso nella concezione, sostenuto dalla Giunti e concretizzatosi nella collana «Astrea», ricca di numerosi titoli tutti di autrici donne, provenienti da tutto il mondo e con scritture anche di genere molto diverso. In questa collana lo spazio dell’Ispanoamerica non è particolarmente vasto, ma le scelte appaiono di altissima qualità: la colombiana Marvel Moreno, le messicane Rosario Castellanos ed Elena Poniatowska, la portoricana Julia Álvarez, nomi ai quali si dovrà aggiungere quello di Rigoberta Menchú, vero bestseller della collana, che la Giunti pubblica con largo anticipo rispetto alla fama raggiunta poi dal futuro Premio Nobel per la pace. Qui l’accento è evidentemente posto sulla condizione femminile, ma senza mai dimenticare la qualità della scrittura e la molteplicità dei riferimenti culturali. Si intuisce dunque che al di là di un certo tipo di scelte editoriali esiste un mondo più ricco e vivace, che meriterebbe uno sguardo più attento.
Si viene dunque a creare una serie editoriale riconoscibile e con un pubblico affezionato la cui fedeltà è testimoniata dal successo crescente di alcune autrici, ma che in una certa misura sono ingabbiate in una griglia predefinita da cui risulta impossibile liberarsi. Esse vanno a costituire una sorta di sottogenere, quello della letteratura ispanoamericana delle donne, che nel corso degli anni si è affermata come l’unica possibile, dopo che il progetto «Astrea» ha perso di forza (in concomitanza con lo scemare dell’impegno femminista militante) e che le ragioni commerciali hanno prevalso su quelle più strettamente culturali.
Felici ritorni e nuovi autori di successo
Il successo consolidato nel tempo di García Márquez e Isabel Allende contribuisce in maniera decisiva al definitivo affermarsi del campo letterario ispanoamericano, destinato a crescere, a partire dagli anni novanta, in forme quantitativamente mai prima conosciute. Il panorama generale è dunque ormai profondamente mutato: l’America di lingua spagnola è a questo punto uno spazio riconosciuto dai lettori italiani, e dopo la crisi della seconda metà degli anni settanta la fiducia degli editori si è andata via via rafforzando, anche grazie al ruolo svolto dalla Spagna come filtro mediatore tra un continente che rimane dispersivo e complesso e un mercato che ha invece sempre più bisogno di certezze. Non è più necessario allacciare difficili contatti oltreoceano, quando gli agenti letterari e le fiere internazionali del libro propongono a piene mani prodotti già selezionati per il pubblico europeo. Possiamo dunque affermare che si forma in questi anni un ambito di lettori interessati agli autori ispanoamericani, che in parte ricalca quello dei romanzi di Isabel Allende: di età fra i trenta e i quarantacinque anni, appartengono a una borghesia medio-alta, spesso hanno avuto un primo contatto con quella letteratura in età giovanile, negli anni sessanta, e mantengono una posizione politica vicina alla sinistra, pur con tutti i distinguo che in questi anni si vanno moltiplicando. È un pubblico che vanta anche una certa capacità di spesa culturale e che si interessa negli stessi anni anche ad altri prodotti, come la musica e il cinema, cui l’America Latina contribuisce in varie forme.
Di fronte a una tale situazione l’editoria italiana reagisce in maniere differenziate. La prima direzione è quella delle ristampe, che iniziano ad arrivare dopo la metà degli anni ottanta e poco a poco si indirizzano verso la selezione e la riproposta di quegli autori tradotti negli anni del boom e poi caduti nel dimenticatoio. Esemplari in tale campo sono i casi di Mario Vargas Llosa e di Carlos Fuentes. Lo scrittore peruviano torna definitivamente in casa Einaudi e qui, anche grazie all’attenzione di Ernesto Franco, si imposta un programma di ristampe, di nuove traduzioni, di novità e di collaborazioni editoriali che collocano Vargas Llosa come un intellettuale di riferimento, e non solo per l’area ispanoamericana: le polemiche politiche, le lauree honoris causa, le sue collaborazioni giornalistiche contribuiscono a una consacrazione che culminerà nel Premio Nobel del 2010. Se Vargas Llosa era comunque sempre rimasto presente sulla scena italiana, seppur con fasi alterne, per Fuentes si tratta di un vero e proprio ritorno, dopo un’assenza durata più di vent’anni. Gli si riconosce ormai una posizione di assoluta preminenza nelle lettere ispanoamericane, ma le ragioni di tale fama rimangono però nozione di pochi, e gran parte della sua produzione narrativa rimane ancora poco nota. Fuentes appare da noi come ingabbiato in una notorietà tutta costruita su basi di cui non ci si è resi conto a tempo debito, una figura di cui si è sentito molto parlare, senza leggerne però molte pagine.
Destini simili conoscono scrittori come Soriano, Cortázar, Puig, Cabrera Infante, Carpentier, tutti riemersi da un periodo di oblio più o meno lungo: in tutti questi ripescaggi, alcuni più fortunati (Soriano, in special modo), altri meno, si nota però una sostanziale immobilità nel giudizio critico e nella presentazione per il pubblico italiano. Cortázar rimane scrittore per “felici pochi”, Soriano troverà la fama con gli scritti sul calcio, popolari e ammiccanti, Cabrera Infante rimane l’autore di deliranti fantasie tropicali, e se per Puig e Carpentier le introduzioni e le nuove traduzioni di Angelo Morino cercano di aggiustare il tiro, la reazione del pubblico rimane in pratica indifferente. La ricchezza multiforme del passato prossimo e glorioso viene così ridotta a una limitata galassia di nomi, ripetuta spesso e volentieri come una cantilena mandata a memoria. Articoli, recensioni e reportage mettono in fila i nomi di sempre per evocare letture, segnalare un comune bagaglio di conoscenze, dare l’impressione di sapere di più e meglio di quello che effettivamente si dice.
Una tale operazione di riscoperta assume poi un’altra dimensione nella collana «Continente Desaparecido», iniziata nel 1997 dalla Sperling & Kupfer e diretta da Gianni Minà, una delle poche collane dedicate esclusivamente all’America Latina. La collana viene strutturata intorno a una proposta culturale ben precisa, quella di far riemergere un «continente scomparso», grazie alle voci dei suoi interpreti più impegnati: il risultato che viene raggiunto non risponde però pienamente a quei nobili propositi, in quanto appare sbilanciato verso nomi e anni troppo connotati per poter essere davvero rappresentativo. La posizione di preminenza di un autore come Eduardo Galeano lo dimostra abbastanza ampiamente. Lo scrittore uruguayano aveva raggiunto la fama internazionale con Las venas abiertas de América Latina (1971; Lapasini 1976), travolto dalla fase di declino dell’interesse nostrano. Nel 1997 quel libro viene ripubblicato, numero 2 della collana, con il titolo Le vene aperte dell’America Latina, con qualche correzione ma sostanzialmente immutato. Le nuove vesti editoriali e la costante presenza di Galeano sui media italiani non hanno cambiato le sue posizioni politiche e ideologiche, tutte centrate sulla teoria della dipendenza, sull’opposizione agli Stati Uniti e, in anni più recenti, alla globalizzazione rampante. Non si tratta di discutere qui la linearità di quelle posizioni, peraltro difese con indubbia coerenza nel corso degli anni, ma di riflettere su quanto esse esprimano la complessa e variegata realtà di un continente in rapida trasformazione, e su quanto la collana nel suo insieme sia riuscita in questo scopo. Ci si accorge allora che tutto il percorso appare nello stesso tempo volto verso il passato – i libri di politica sono in realtà libri di storia, visto che si occupano quasi tutti degli anni settanta – e limitato a coordinate spazio-temporali molto ridotte: il Guatemala, Che Guevara, il Brasile di Frei Betto e Leonardo Boff, e naturalmente Cuba. Ci troviamo di fronte allora a un fenomeno assai significativo: la visione che si propone vuole imporsi con la forza dell’evidenza, ma si trasforma in una sorta di “pensiero unico”, elaborato da un gruppo ristretto e destinato esclusivamente al pubblico italiano, senza quelle radici che invece avevano caratterizzato la stessa proposta degli anni sessanta e settanta.
Si continua peraltro a usare una dimensione continentale, che dal punto di vista geopolitico ed economico nella seconda metà degli anni novanta ha perso ormai gran parte della sua ragion d’essere. Le differenze delle situazioni si fanno sempre più marcate e le ragioni di crolli improvvisi, come di inattese rinascite, non potranno più essere addebitate a una causa unica (se mai ciò era stato possibile), ma dovranno essere inquadrate in una complessa catena di concause, interne ed esterne, non sempre facili da discernere per un osservatore esterno. L’immagine che viene proposta dalla serie curata da Gianni Minà è invece quella di un quadro a tinte fosche, nello stesso tempo impreciso e manicheo, in cui tutto è stato già spiegato, e si tratta solo di ribadirlo con quanta più forza possibile.
L’altra collana dedicata all’America Latina in questi anni ha invece un taglio esclusivamente narrativo, ed è «La frontiera scomparsa» di Guanda, curata da Luis Sepúlveda, che accoglie una serie di autori legati tra loro da rapporti personali di amicizia e di complicità, la cui selezione riflette però linee di sviluppo assai simili. Vi si trovano narrazioni di viaggio, romanzi gialli con coloriture politiche, libri ambientati in luoghi sperduti e lontani, in un quadro generale abbastanza ripetitivo, come emerge dalle presentazioni dei volumi della collana, tutte giocate su una insistita tendenza all’amplificazione.
La traiettoria dello scrittore cileno in Italia era iniziata con la pubblicazione di Il vecchio che leggeva romanzi d’amore (Carmignani 1993), un breve romanzo che aveva incontrato un immediato successo di pubblico, confermato a ogni uscita di un suo nuovo titolo, soprattutto qui da noi, dove Sepúlveda raggiunge cifre di vendita assolutamente straordinarie. La sua bibliografia spazia dal romanzo breve al racconto, dal libro di viaggio alla narrativa poliziesca, dal libro per bambini all’intervista e alla memorialistica. Non tutti i suoi titoli hanno raggiunto la diffusione del primo, o di La gabbianella e il gatto che le insegnò a volare, da cui è stato anche tratto un fortunato film d’animazione, ma in generale il suo pubblico è andato aumentando negli anni, tanto da essere considerato in Italia come lo scrittore di riferimento della nuova letteratura sudamericana, ruolo peraltro testimoniato dalle numerosissime interviste, dagli interventi sui quotidiani riguardo gli argomenti più disparati e dalla collana di romanzi da lui diretta. Sepúlveda ha incarnato perfettamente la figura dello scrittore di successo, e gestisce la sua immagine con raffinata perizia, riuscendo, anche nella scelta dei temi e dei generi della scrittura, a cogliere prontamente i gusti del pubblico europeo, e italiano in particolare.
Le ragioni della sua ascesa sono comunque già contenute nel primo romanzo, un vero concentrato di tutti quegli elementi destinati a colpire inevitabilmente il lettore abituato al mondo americano. L’ambientazione nella selva lussureggiante, un personaggio che vive sulla frontiera tra più realtà, la passione come motivazione principale delle azioni, l’opposizione natura-civiltà, una certa dose di trasgressione: il prodotto non può che essere destinato a un successo di massa, aiutato dalla copertina naïf, dalla semplicità del linguaggio, da una certa sagacia nel portare avanti la narrazione. Sepúlveda rappresenta così il frutto più maturo, la sintesi compiuta di un’operazione culturale che abbiamo visto disegnarsi in queste pagine. Nonostante le sue reiterate affermazioni contrarie, l’insieme dei suoi libri disegna un continente ingabbiato in una visione tutta costruita a uso esclusivo del pubblico europeo, straripante di stereotipi e centrata su spazi periferici in cui ambientare avventure esotiche (la Patagonia, la foresta amazzonica, il deserto di Atacama), giacché quello che si cerca è uno “spazio vergine”, in cui le contraddizioni del tempo presente esistono solo come affermazioni di principio, belle frasi da inserire qua e là nel racconto. La sua è una perfetta letteratura per l’esportazione, che risponde in maniera assolutamente coerente allo spazio che la macchina globale dell’editoria internazionale assegna all’America Latina: potremmo allora qui davvero parlare di un continente scomparso, di un enorme spazio di idee, progetti, scritture ridotto a una galleria di pochi nomi.
Sullo stesso piano, anche se per strade diverse, si muove un genere che ha conosciuto negli ultimi anni una grande fortuna di pubblico, quello del romanzo poliziesco, nelle sue varianti di giallo classico, di romanzo di spionaggio o di thriller di azione. La proliferazione di un tale tipo di narrativa non è una caratteristica unica dell’America Latina, ma assume caratteri globali: mai come negli ultimi anni si sono pubblicati tanti romanzi iscrivibili nella categoria del romanzo giallo, e sembra che ormai non si possa scrivere nulla che non abbia un sottofondo da intrigo poliziesco. In America un tale genere aveva avuto pochi, seppure notevoli, precedenti: il gioco intellettuale di Borges e Bioy Casares, il giallo di inchiesta di Rodolfo Walsh, l’imitazione-omaggio di Chandler di Osvaldo Soriano, ma si trattava comunque di tracce disperse, quasi di curiosità per appassionati.
Arriveranno invece da Cuba e dal Messico alcuni degli autori di maggiore successo del genere, come Leonardo Padura Fuentes, pubblicato in italiano dalla casa editrice Tropea, la stessa che impone all’attenzione del pubblico il nome di Paco Ignacio Taibo II, uno dei più seguiti autori ispanoamericani degli ultimi anni, spesso in visita nel nostro paese, impegnato in interviste e promozioni dei suoi libri. Lo scrittore messicano è proposto senza successo fin dal 1989, ma è dal 1996 che il suo nome inizia a circolare con maggiore insistenza, dopo la pubblicazione dei primi romanzi gialli tradotti in italiano in cui appaiono i detective protagonisti delle due serie di Taibo II, Olga Lavandares (detta Olguita) ed Héctor Belascoarán Shayne, entrambi immersi nell’atmosfera dell’immenso Distrito Federal di Città del Messico.
Taibo II dichiara a più riprese nelle sue interviste di voler utilizzare la struttura del romanzo poliziesco per raccontare le tensioni sociali urbane, in quanto lo considera il genere erede del classico romanzo d’avventura e dunque essenzialmente uno strumento da usare per altri scopi. Personaggi e ambiente valgono perciò nei romanzi di Taibo più della trama, ma la necessità di rispettare comunque alcune regole di serialità e di riconoscibilità costringono quelle storie a ripetere elementi che non tardano a trasformarsi in nuovi facili stereotipi. La sostanziale linearità dei romanzi di Taibo ne assicura però il successo presso il pubblico italiano, in quanto lo conferma in idee e considerazioni ampiamente consolidate. L’America è di per sé un continente pericoloso, ma anche terra di grandi passioni, in cui eroi solitari combattono battaglie ormai transnazionali, come il tipo di narrativa che Taibo persegue. Si viene a creare un esotismo nuovo, ma comunque sempre segnato dal senso della lontananza, non più solo geografica, ma anche sociale e “di situazione”: non si desidera più solamente raggiungere lo spazio altro, in questo caso non propriamente affascinante, ma vivere delle avventure ai limiti del proibito, in uno spazio incerto al di qua e al di là della legge.
Il romanzo giallo diventa dunque uno dei veicoli preferiti per far circolare un’immagine dell’America Latina (e in particolare del Messico, della Colombia e di Cuba) come un territorio sospeso tra una legalità incerta (o comunque non garantita dalle autorità tradizionali, presentate quasi sempre come corrotte e impresentabili) e la insopprimibile voglia di lottare contro le ingiustizie, in qualsiasi forma si presentino. A questo punto, però, quello spazio è diventato anche raggiungibile nella realtà, come avviene nei romanzi di Pino Cacucci o in qualche film a lui ispirato, ma il viaggiatore formato sui romanzi di Taibo vedrà solo quello che si aspetta di vedere, ripetendo il gesto che milioni di europei hanno ripetuto dopo Colombo: per loro l’America è solo lo spazio delle loro proiezioni, magari piene di buone intenzioni, un Puerto Escondido dove fuggire, come se l’America esistesse solo per accogliere europei stanchi della civiltà occidentale.
Alla ricerca della qualità
Accanto a questi progetti, che si pretendono alternativi ma che invece sono legati a filo doppio con le strategie commerciali dei grandi gruppi editoriali, se ne rintracciano altri, con un ben diverso spessore culturale. Sellerio, ad esempio, apre ben presto le sue collane alla letteratura ispanoamericana, soprattutto grazie alla consulenza del compianto Angelo Morino, che traduce, introduce e recupera sia autori ormai divenuti “classici” (Puig, Carpentier, Monterroso), sia vere e proprie riscoperte, sulla scia del romanzo giallo “di qualità” (Denevi, Ibargüengoitia, Walsh) per proporre infine autori nuovi, tra i quali spicca il nome del cileno Roberto Bolaño, di cui si dovrà riparlare. I risultati di vendita non sono sempre eclatanti, ma la casa editrice palermitana continua nel suo progetto, peraltro ribadito anche per le altre letterature, così come per la narrativa italiana, e senza una tale fedeltà il pubblico italiano non avrebbe la possibilità di conoscere un gran numero di autori che altrimenti non sarebbero mai stati tradotti.
Altri progetti sono stati travolti da diverse e ripetute crisi editoriali, e di essi non rimane oggi praticamente nulla, come è avvenuto per la casa editrice Zanzibar, le cui coloratissime copertine avevano accompagnato le prime traduzioni italiane di Arreola, Marechal, Feinmann e di altri a cavallo tra gli anni ottanta e i novanta, o per la narrativa della Giunti, in cui si potevano trovare Moyano, Saer o Senel Paz. O come un progetto editoriale come quello della casa editrice Gorée che tra gli anni novanta e l’inizio del nuovo secolo, grazie soprattutto alla consulenza di Antonio Melis, propose una serie di nuovi autori di alcune delle tendenze più significative di quegli anni, tra le quali quella dell’emergere di voci che scrivono nelle lingue autoctone americane: solo alcuni di questi progetti verranno poi recuperati da altre case editrici, ormai dopo il 2010. Ha resistito, anche per la dedizione di Martha Canfield, il progetto della casa editrice fiorentina Le Lettere, che coniuga nuove voci poetiche – il guatemalteco Ak’abal, il chicano Tino Villanueva, il peruviano Eielson – ad affascinanti testi narrativi, come i racconti di Mario Benedetti o i romanzi di Antonio Dal Masetto, Alejandro Rossi o Carmen Boullosa.
Una caratteristica che accomuna però tutto questo mondo editoriale è una consolidata qualità delle traduzioni, che a partire dagli anni novanta raggiunge un livello che non solo appare assai superiore a quello degli anni precedenti, ma che si va configurando come una vera e propria “scuola” – soprattutto di traduttrici – che permettono ai lettori italiani di poter finalmente leggere gli autori ispanoamericani in testi assai vicini agli originali e in alcuni casi i risultati sono forse addirittura superiori a libri che in spagnolo suonano davvero assai banali. La lista sarebbe davvero assai lunga, e forte il timore di lasciare colpevolmente fuori qualche nome, ma non si possono tacere, in una rivista dedicata alla traduzione, i nomi (in ordine rigorosamente alfabetico) di Barbara Bertoni, Ilide Carmignani, Francesca Lazzarato, Elena Liverani, Gina Maneri, Eleonora Mogavero, Maria Nicola, Maria Cristina Seccia, cui si aggiungono quelli maschili di Francesco Fava e Raul Schenardi.
La nota comune che si può poi rintracciare in tutte queste ricerche è proprio quella di seguire la qualità letteraria prima che l’aderenza a un’idea precostituita, di privilegiare la varietà invece che l’uniformità, nel tentativo di restituirci l’immensa ricchezza di un continente che risulta ormai impossibile rinchiudere in formule univoche.
Conclusioni: gli anni duemila e le ultime tendenze
L’immagine complessiva dell’America di lingua spagnola in Italia appare dunque alla fine del Novecento fortemente deformata, tanto da sembrare in certi casi quasi una caricatura, ma tale deformazione risponde a strategie editoriali e commerciali e dunque quelle ragioni economiche fanno sì che si diffonda quella che Juan Villoro (2000) ha chiamato l’utopia dell’arretratezza, secondo la quale l’America Latina sarebbe l’ultima riserva dell’utopia:
Esta lejanía hace que en el campo cultural satisfaga una curiosa necesidad del imaginario europeo: la utopía del atraso. Nada más sugerente en un mundo globalizado que una reservación donde se preservan costumbres remotas. […]Uno de los negocios más seguros del momento sería la construcción de una Disneylandia del rezago latino donde los visitantes conocieran dictadores, guerrilleros, narcotraficantes, militantes del único partido que duró setenta y un años en el poder, mujeres que se infartan al hacer el amor y resucitan con el aroma del sándalo, toreros que comen vidrio, niños que duermen en alcantarillas, adivinas que entran en trance para descubrir las cuentas suizas del presidente. Estamos ante un colonialismo de nuevo cuño, que no depende del dominio del espacio sino del tiempo. En el parque de atracciones latinoamericano, el pasado no es un componente histórico sino una determinación del presente. Anclados, fijos en su identidad, nuestros países surten de antiguallas a un continente que se reserva para sí los usos de la modernidad y del futuro.
Questa stessa distanza fa sì che in campo culturale essa soddisfi una curiosa necessità dell’immaginario europeo: l’utopia dell’arretratezza. In un mondo globalizzato, niente di più suggestivo di una riserva in cui sopravvivano remoti costumi. […] Un investimento assolutamente sicuro sarebbe oggi la costruzione di una Disneyland dell’arretratezza latina in cui i visitatori potessero incontrare dittatori, guerriglieri, narcotrafficanti, militanti del partito unico al potere da settant’anni, donne cui scoppia il cuore quando fanno l’amore e che resuscitano col profumo del sandalo, toreri mangiatori di vetro, bambini che dormono nelle fogne, indovine che vanno in trance per scoprire i conti svizzeri del Presidente. Ci troviamo di fronte a un colonialismo di nuovo conio, che non dipende dal dominio dello spazio ma da quello del tempo. Nel luna-park latino-americano il passato non è una componente storica ma una determinazione del presente. Ancorati e fissi nella loro identità i nostri paesi escono dal loro anticume per entrare in un mondo che riserva soltanto per sé gli usi della modernità e del futuro (Esposito 2000).
In questi primi quindici anni del nuovo secolo, tuttavia, il panorama è cambiato, anche se alcune tendenze possono solo essere sommariamente descritte, dato che sono talmente recenti da non poterne ancora misurare l’impatto effettivo. È possibile, comunque, segnalare tre fenomeni editoriali di un certo interesse. Il primo riguarda l’offuscarsi progressivo di alcune figure che avevano fortemente caratterizzato il periodo precedente. Se infatti Isabel Allende ancora produce un romanzo con cadenza più o meno biennale, e i suoi titoli precedenti vengono costantemente ristampati nelle collane economiche della Feltrinelli, nel caso di Luis Sepúlveda e Paco Ignacio Taibo II la loro vena creativa sembra indirizzarsi verso altri generi e tipi di scrittura, assai meno coinvolgenti per il pubblico. Lo scrittore cileno non pubblica più un vero romanzo ormai da molti anni e Taibo si è dedicato negli ultimi tempi a ponderose biografie, più o meno romanzate, di personaggi della storia messicana e latinoamericana. Non sono peraltro emerse figure simili, anche perché la nuova generazione di scrittori del continente si è decisamente allontanata da quei modelli.
Quella stessa generazione, oggi validamente rappresentata in traduzione italiana, ha individuato invece in Roberto Bolaño, scrittore cileno di nazionalità ma transnazionale per vocazione e destino, il proprio “padre” intellettuale, e proprio la diffusione delle opere di Bolaño è il secondo fenomeno da segnalare. I suoi romanzi erano apparsi in italiano fin dalla metà degli anni novanta, editi da Sellerio e grazie ad Angelo Morino, che per primo aveva proposto Bolaño in traduzione (in effetti quelle traduzioni sono le prime anche rispetto ad altre lingue), ma la ricezione era stata scarsa, se non addirittura quasi inesistente. Per una serie di drammatiche coincidenze, nel 2003 lo scrittore cileno scompare prematuramente e viene pubblicato il suo romanzo allora più ambizioso, I detective selvaggi (Nicola 2003) e nello stesso tempo inizia a costruirsi una sorta di leggenda bolañiana che lo descrive come uno scrittore maledetto e geniale, che troverà ampia eco soprattutto negli Stati Uniti. L’esplosione di un vero e proprio caso letterario in ambiente angloamericano rimbalzerà anche in Italia, e quando nel 2007 Adelphi acquisterà i diritti per l’opera di Bolaño inizierà quella diffusione come “scrittore di culto” che lo consacra come l’autore ispanoamericano più significativo degli ultimi anni, forse anche al di là dei suoi effettivi meriti letterari, che restano comunque di notevole spessore.
L’ultimo fenomeno che mi pare giusto sottolineare è invece assai recente, e forse già in fase di trasformazione: da circa dieci anni è attiva La Nuova frontiera di Roma, che, come recita la presentazione sul sito,
è infatti la sola casa editrice a dedicarsi esclusivamente alle pubblicazioni di autori classici (nella collana il Basilisco) e contemporanei (nella collana Liberamente) delle letterature di lingua castigliana, catalana e portoghese. La scelta di questo criterio linguistico e culturale non ha limitato la ricerca alla penisola iberica, ma ha attraversato gli Oceani fino ad arrivare nello sconfinato continente americano e nei paesi dell’Africa lusofona.
A questo progetto si è poi affiancato dal 2011 quello della casa editrice SUR, che a partire da mirate operazioni di recupero di autori e testi scomparsi da tempo dalle librerie italiane (Onetti, Arlt, Pacheco e altri), ha proposto anche libri mai tradotti qui da noi. Questi due progetti editoriali (a cui sembra se ne vadano aggiungendo altri più giovani), i primi finora dedicati in forma esclusiva all’America Latina, stanno cercando di costruire un paesaggio innovativo e variegato di un continente letterario che in questo modo sembra poter uscire da quella gabbia di stereotipi in cui era stato costretto e che si è cercato di descrivere in queste pagine.
Bibliografia
Bellini 1960: Pablo Neruda, Poesie, Milano, Nuova Accademia (traduzione di Giuseppe Bellini da una scelta antologica)
Borges 1944: Jorge Luis Borges, Ficciones, Buenos Aires, Sur
Calvino 1968: Italo Calvino, Per una letteratura che chieda di più (Vittorini e il Sessantotto), in «Il Ponte», 31 agosto 1968, ora in Una pietra sopra, Torino, Einaudi, 1980, pp. 234-235
Carmignani 1993: Luis Sepúlveda, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore, Guanda, Parma (traduzione di Ilide Carmignani di Un viejo que leía novelas de amor, Barcelona, Tusquets, 1989)
Cicogna 1974: Bryce Echenique, Un mondo per Julius, Milano, Feltrinelli(traduzione di Enrico Cicogna da Un mundo para Julius, Lima, Seix Barral Peisa, 1970)
Cicogna 1975: Gabriel García Márquez, L’autunno del patriarca, Milano, Feltrinelli (traduzione di Enrico Cicogna di El otoño del patriarca, Barcelona-Buenos Aires, Plaza & Janés-Sudamericana, 1975)
Cintioli 1963: Juan Rulfo, La morte al Messico, Milano, Mondadori (traduzione di Giuseppe Cintioli di El llano en llamas, México, Fondo de Cultura Económica, 1953; le nuove edizioni del 1990 – traduzione di Francisca Perujo – e del 2012 – traduzione di Maria Nicola – prenderanno il titolo di La pianura in fiamme, Torino, Einaudi)
Cintioli 1962: Ciro Alegría, I peruviani, Milano, Mondadori (traduzione di Giuseppe Cintioli da El mundo es ancho y ajeno, Santiago de Chile, Ercilla, 1941; dall’edizione del 1978 prenderà il titolo di Il mondo è grande e alieno)
Di Michele 1966: Carlos Fuentes, La morte di Artemio Cruz, Milano, Feltrinelli (traduzione di Carmine Di Michele da La muerte de Artemio Cruz, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1962)
Di Michele e Calidon 1967: Carlos Fuentes, Cambio di pelle, Milano, Feltrinelli (traduzione di Carmine Di Michele e Atalanta Calidon da Cambio de piel, Guaymas, Joaquin Mortiz, 1967)
Eco 2001: Umberto Eco, Sulla letteratura, Milano, Bompiani,
Esposito 2000: Juan Villoro, L’America Latina come utopia dell’arretratezza, in «Lo Straniero», III, n. 10, pp. 152-162 (traduzione di Saverio Esposito di Iguanas y dinosaurios. América Latina como utopía del atraso, in Efectos personales, México, Era, 2000, pp. 87-93)
Ferré 1990: Rosario Ferré, El Coloquio de las perras, Puerto Rico, Editorial Cultural
García Márquez 1968: Gabriel García Márquez, Cent’anni di solitudine, Milano, Feltrinelli (traduzione di Enrico Cicogna di Cien años de soledad, Buenos Aires, Sudamericana, 1967)
González-Palacios 1964: Severo Sarduy, La bomba dell’Avana, Milano, Feltrinelli (traduzione di Alvar González-Palacios di Gestos, Barcelona, Seix Barral, 1963)
Lapasini 1976: Eduardo Galeano, Il saccheggio dell’America Latina, Einaudi, Torino (traduzione di Gabriella Lapasini di Las venas abiertas de América Latina, La Habana, Casa de las Américas, 1971; ristampato col titolo Le vene aperte dell’America Latina, Sperling & Kupfer, Milano, 1997)
Lippmann 1995: Walter Lippmann, L’opinione pubblica, Roma, Donzelli (traduzione di Cesare Mannucci di Public Opinion, New York, Harcourt, Brace and company, 1922),
Lucentini 1955: Jorge Luis Borges, La biblioteca di Babele, Torino, Einaudi, traduzione di Franco Lucentini; dall’edizione del 1961 il libro prenderà il titolo di Finzioni: la biblioteca di Babele e dal 1985 il titolo Finzioni; nuova traduzione di Antonio Melis con il titolo Finzioni, Milano, Adelphi, 2003
Lucentini 1998: Franco Lucentini, Borges e l’enigma di Babele, in «La Stampa», 4 maggio 1998, ora in Fruttero & Lucentini, I nottambuli, Cava de’ Tirreni, Avagliano, 2001, pp. 120-126
Mancuso 1958: Miguel Ángel Asturias, L’uomo della Provvidenza: il signor Presidente, Milano, Feltrinelli (traduzione di Elena Mancuso di El Señor Presidente, México, Costa-Amic, 1946; dall’edizione del 1967 prenderà il titolo di Il signor Presidente; nuova traduzione di Raul Schenardi, Roma, Fahrenheit 451, 2007)
Morino e Piloto Di Castro 1983: Isabel Allende, La casa degli spiriti, Milano, Feltrinelli (traduzione di Angelo Morino e Sonia Piloto Di Castro di La casa de los espíritus, Barcelona, Plaza & Janés, 1982)
Neruda 1950: Pablo Neruda, Canto general, México, Americana
Nicola 2003: Roberto Bolaño, I detective selvaggi, Palermo, Sellerio (traduzione di Maria Nicola di Los detectives salvajes, Barcelona, Anagrama, 1998; nuova traduzione di Ilide Carmignani, Milano, Adelphi, 2014)
Puccini 1955: Pablo Neruda, Canto generale: la lampada sulla terra, Parma, Guanda (traduzione di Dario Puccini dei primi quattro canti di Canto general; edizione completa: Firenze, Sansoni, 1967)
Puccini 1981: Gabriel García Márquez, Cronaca di una morte annunciata, Milano, Mondadori (traduzione di Dario Puccini di Crónica de una muerte anunciada, Barcelona-Bogotá-Buenos Aires, Bruguera-La oveja negra-Sudamericana, 1981)
Quasimodo 1952: Pablo Neruda, Poesie, Torino, Einaudi (traduzione di Salvatore Quasimodo: questa edizione conoscerà trentuno ristampe, fino al 2010)
Spinazzola 1984: Vittorio Spinazzola, La democrazia letteraria, Milano, Edizioni di Comunità
Tentori Montalto 1957: Francesco Tentori Montalto (a cura di), Poesia ispano-americana del Novecento, Parma, Guanda
Tentori Montalto 1960: Francesco Tentori Montalto (a cura di), Narratori ispanoamericani del Novecento, Parma, Guanda
Valentinetti 1986: Gabriel García Márquez, L’amore ai tempi del colera, Milano, Mondadori (traduzione di Claudio M. Valentinetti di El amor en los tiempos del cólera, Barcelona-Bogotá, Bruguera-La oveja negra, 1985)
Varanini 1998: Francesco Varanini, Viaggio letterario in America Latina, Venezia, Marsilio
Villoro 2000: Juan Villoro, Iguanas y dinosaurios. América Latina como utopia del atraso, Barcelona, 2000