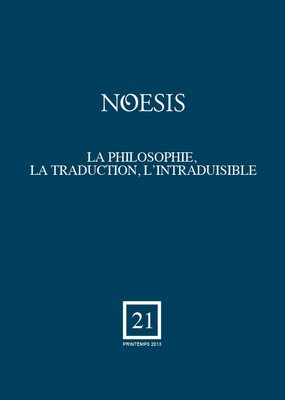 di Elisa Leonzio
di Elisa Leonzio
A proposito di: Michaël Biziou e Geneviève Chevallier (a cura di), La philosophie, la traduction, l’intraduisible. NOESIS, 21, Nice, Centre de recherche d’histoire des idées, 2014, p. 436, € 12
«Noesis», rivista di filosofia edita dal 1995 dal Centro ricerche per la storia delle idee dell’università Sophia Antipolis di Nizza, pubblica numeri monografici su aspetti dell’epistemologia, della logica e dell’ermeneutica, sul pensiero di singoli autori o correnti o sull’interrelazione tra la filosofia e le altre discipline. È questo il caso del numero 21, curato da Michaël Biziou e Geneviève Chevallier, che affronta il proficuo rapporto di reciproca influenza e interdipendenza tra filosofia e traduzione. Che storicamente il legame sia fortissimo e rappresenti il momento fondante della cultura europea moderna è stato ampiamente dimostrato da numerosi studiosi e ottimamente illustrato nella bella rassegna di Emanuele Zimbardi sulla nostra rivista (n. 7, autunno 1914): il patrimonio teorico di cui dispone oggi la cultura europea affonda le proprie radici nell’opera di traduzione e quindi di mediazione compiuta dai latini allo scopo di impadronirsi delle conoscenze teoretico-filosofiche della Grecia antica.
Il volume di «Noesis», pur prendendo in parte le mosse da riflessioni archeologiche (nel senso di una ricerca delle origini) analoghe, abbandona il piano della ricostruzione storica per spostarsi su un livello marcatamente teoretico, dove la filosofia compie un’operazione autoriflessiva per misurare il proprio debito concettuale e metodologico con la traduzione e i traduttori-traduttologi riflettono sul carattere eminentemente filosofico delle loro scelte traduttive, legate a concezioni gnoseologiche, ontologiche ed etiche non sempre perfettamente consce in quanto frutto di un retaggio culturale ormai interiorizzato: all’etica vengono ricondotti aspetti della traduzione quali il rispetto del/fedeltà al testo di partenza e la libertà di discostarsene, a una dimensione metafisica di ispirazione platonica l’idea che il testo originale possieda un senso intellegibile rispetto a cui le traduzioni sarebbero altrettante variazioni (e corruzioni?) sensibili.
La philosophie, la traduction, l’intraduisible, conformemente al suo titolo tripartito, si articola in tre sezioni dedicate rispettivamente alla filosofia della traduzione, alla traduzione di testi filosofici e all’intraducibilità – lo scarto tra le lingue, l’abisso tra l’essere e le sue rielaborazioni concettuali e linguistiche – quale condizione di possibilità della stessa attività del tradurre, così come la finitezza è la condizione di possibilità dell’essere dell’uomo. Dire che qualcosa è intraducibile non significherà affatto voler insinuare che la lingua d’arrivo sia inferiore a quella di partenza e incapace di articolarne la complessità semantica; ma semmai che il compito del traduttore è quello di realizzare ponti ermeneutici che restituiranno il senso da una lingua all’altra al di là della resa parola per parola.
La prima sezione, Filosofia della traduzione, comprende quattro contributi che ripercorrono il confronto teorico con i temi del linguaggio e del senso nel pensiero di autori quali Quine, Frege e Wittgenstein (Bruno Poncharal), Husserl e Saussure (Alain Gallerand), alcuni esponenti del romanticismo tedesco (Guillaume Lejeune), Benjamin e Ortega y Gasset (Gaetano Chiurazzi). Un quinto contributo (Charles Ramond) si sofferma sulla biografia Le maître ignorant, in cui Jacques Rancière ripercorre le vicende del pedagogo Joseph Jacotot, mentre il sesto, di Lawrence Venuti, traduttore e celebre e discusso teorico della traduzione, esamina il rapporto tra traduttologia e cultural studies nel mondo accademico americano a partire da una sua traduzione di un testo di Derrida sulla traduzione. Se si considera che il testo di Venuti è stato originariamente scritto in inglese e poi tradotto in francese, questo intreccio è quasi vertiginoso. Da questo semplice elenco emergono già almeno due elementi interessanti: il primo è che il filo conduttore che dal tardo Settecento arriva all’attualità circoscrive implicitamente il periodo a partire dal quale e nel quale si può parlare di filosofia della traduzione in senso stretto; il secondo è che i filosofi citati appartengono ad ambiti filosofici anche molto diversi tra loro e che spaziano dalla fenomenologia alla filosofia del linguaggio e alla logica, dall’ermeneutica alla filosofia politica. Da questo punto di vista sarebbe quindi stato forse più corretto parlare di filosofie della traduzione, al plurale, tanto più che i contributi del volume fanno tutti del concetto di pluralità uno dei loro punti cardine.
Scendendo più nel dettaglio si trovano dibattuti e declinati secondo i diversi orientamenti alcuni temi, che potremmo raggruppare sotto tre grandi cappelli: il senso, il dialogo e il riconoscimento di sé a partire dall’altro (e non a discapito dell’altro). Il senso non risiede nel singolo vocabolo decontestualizzato, ma nell’uso della lingua. L’uso della lingua dal canto suo va osservato tenendo presenti due elementi: la forma, che è consustanziale al contenuto e non suo mero orpello, e la dialogicità, in quanto il parlare è sempre un rivolgersi a qualcuno. Ciò vale tanto più per il testo filosofico, un testo per sua natura aperto e polifonico. La traduzione dovrà impegnarsi a conservare questi aspetti mettendo in luce la molteplicità delle prospettive, come già era nel programma critico-letterario del romanticismo tedesco e come, con una marcata venatura politica e anti-nazionalistica, ancora auspicava Ortega y Gasset: costruire se stessi facendo esperienza dell’altro e con l’altro. La comunicazione e la traduzione sono d’altra parte rese possibili proprio dalla non totale coincidenza di senso ed espressione nelle diverse lingue, che però viene bilanciata da una idealità logica apriori come teorizzata da Husserl (un esempio: il francese non possiede la forma grammaticale del duale che ha per esempio il greco, ma è comunque in grado di comprenderlo concettualmente e renderlo attraverso altri espedienti espressivi). La tesi di Benjamin della lingua pura, metastorica, ossia dell’affinità tra le lingue al di là delle differenze contingenti, è un altro punto di vista su questo stesso apriori. Per raggiungerla il traduttore dovrà però liberare il testo proprio dal senso e dalla comunicazione. L’apriori delle lingue storiche, da condizione prima della possibilità del tradurre, diviene fine ultimo che il traduttore è chiamato a raggiungere superando la storicità delle singole lingue. Questa scintilla di purezza si mostra peraltro proprio nell’incontro/scontro tra le lingue e dunque nella traduzione.
Questo oscillare tra la comunicazione e la sua negazione, tra dicibilità e indicibilità del senso, costruisce un ponte che collega direttamente la prima alla terza sezione, quella, appunto, sull’intraducibilità. La comprensione dell’altro, che è alla base del dialogo e della traduzione, rischia di fallire di fronte alla constatazione che i segni usati per comunicare non sono univoci e che possono avere significati diversi per persone diverse. Come capirsi, allora? E come tradursi? (Hervé Pasqua). Lo stesso pessimismo ispira il divieto di tradurre il Libro di Esther espresso nel Talmud, che viene discusso nel terzultimo contributo del volume (Laurent Pietra) alla luce delle riflessioni che su di esso ha fatto Lévinas: qui la lingua biblica assume una posizione simile a quella occupata dalla lingua pura di Benjamin, di cui le lingue vernacolari rappresentano altrettante realizzazioni particolari e deficitarie. Il Libro di Esther non dovrà essere tradotto in altra lingua per non fornire ai nemici del popolo ebraico materiale di cui dare interpretazioni errate. Completamente opposto, invece, l’ottimismo dei teorici russi, che nella convinzione che tutto sia traducibile finiscono per negare l’estraneità e la differenza, finendo per fagocitare e annullare invece di ospitare le altre culture (Sergej L. Fokin).
Tra queste due sezioni marcatamente teoriche si colloca quella rivolta a casi specifici di testi di filosofia tradotti in altre lingue, in alcuni casi scritti dagli stessi traduttori che discutono le ragioni delle loro scelte, in altri da studiosi che ripercorrono le vicende di un’opera in traduzione mostrando interessi che sembrano però andare più verso la storia della ricezione e della circolazione delle idee che verso specifici problemi traduttivi. Averroè (Abdennour Benantar), Pascal (Susana Mauduit-Peix), Shaftesbury (Françoise Badelon), Smith (Spiros Tegos e Michaël Biziou), Bergson (Joseph Ciaudo) e Wittgenstein (Jean-Luc Gautero) sono gli autori presi in considerazione. Di particolare interesse, forse anche perché aprono uno sguardo su lingue e culture extra-europee di solito abbastanza trascurate al di fuori dei testi per specialisti, sono il contributo su Averroè, il cui Commento alla Repubblica di Platone è stato ritradotto in arabo sulla base di una traduzione ebraica essendo andato perduto l’originale, e quello sulla traduzione e diffusione del pensiero di Bergson in Cina.
Va detto che, per quanto inseriti nella sezione «pratiche», anche questi contributi hanno un alto valore teorico, non dissimile da quello della prima sezione. E dall’altro lato, nel costante riferirsi alle difficoltà e ai limiti del tradurre, sfiorano di continuo il tema dell’intraducibilità. Se a ciò si aggiunge che, di rimando, i contributi della prima e della terza sezione prendono a loro volta le mosse da casi estremamente specifici, risulta evidente che la tripartizione, seppure forse funzionale a esigenze editoriali, risulta un po’ fragile e arbitraria. È questo, comunque, l’unico difetto di un volume interessantissimo, che proprio nella complessità dell’intreccio di teoria e pratica sembra quasi ridia vita al movimento con cui la lingua pura si concretizza nelle singole lingue storiche e nelle sue traduzioni.