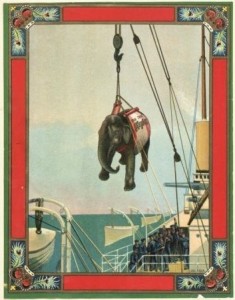Sparse notazioni dal campo di un traduttore di saggistica
di Mario Marchetti
1. Tradurre, una pratica antica
Sul tradurre esiste ormai un’intera biblioteca di Alessandria di testi. Non a caso cito l’antica biblioteca, visto che proprio lì nel III secolo a.C. fu iniziata la versione in greco dell’Antico Testamento: la celebre Bibbia dei Settanta, che si può considerare come la prima grande opera di traduzione consapevole, eseguita da esperti filologi e conoscitori delle due lingue, il greco e l’ebraico (ma anche dell’aramaico). Perché si intraprese questa traduzione?
Le comunità ebraiche del bacino del Mediterraneo di cultura ellenistica andavano grecizzandosi e avevano difficoltà ad accedere ai testi della loro tradizione religiosa. Occorreva salvare un insegnamento, una storia, attraverso un nuovo veicolo, in questo caso il greco. Analogamente operò Girolamo quando alcuni secoli più tardi, in tarda epoca imperiale, tra III e IV secolo d.C. intraprese la traduzione dell’Antico Testamento dall’ebraico in latino e attuò una radicale revisione delle precedenti versioni latine del Nuovo Testamento: in questo caso la lingua veicolare fu il latino, la lingua imperiale romana che si stava affermando come lingua del cristianesimo organizzato in Chiesa. Possiamo aggiungere un esempio temporalmente intermedio, non di area religiosa, bensì filosofica, ma paragonabile ai precedenti per potere seminale, quello di Cicerone, che nel I secolo a.C. travasò la cultura filosofica greca nella lingua latina, creando un linguaggio, laddove non c’era, che si trasmetterà poi a tutta la cultura filosofica, e non solo, occidentale. Tutti costoro fecero opera di passeurs, di traghettatori da una cultura ad un’altra, da un sistema linguistico ad un altro, e lo fecero con la massima acribia e con effetti formidabili sulla cultura e sulla visione del mondo successive. Crearono aperture di pensiero e nuove possibilità nella lingua d’arrivo, permisero di pensare ciò che prima in essa era impensabile, certamente scegliendo una particolare piegatura piuttosto che un’altra, e quindi, inevitabilmente, convogliarono anche il pensiero in una certa direzione piuttosto che in un’altra, fornendo le parole per dirlo e insieme un canone da cui sarà difficile uscire (ad esempio il problematico metànoia greco – un mutamento d’opinione con una forte carica soggettiva – èdiventato, attraverso il passaggio latino, il più imperativo conversione italiano – l’adesione a un sistema di credenze dato).
2. La traduzione saggistica come «arte dell’approdo»
Se secondo Édouard Glissant, il grande teorico della creolizzazione, la traduzione è «un’arte della fuga da una lingua all’altra, senza che la prima si cancelli e senza che la seconda rinunci a presentarsi», per i Settanta, per Cicerone, per Girolamo è piuttosto un’arte dell’approdo, in cui però vale perfettamente la seconda parte dell’asserto di Glissant: la lingua originaria non è persa, ma la nuova afferma i suoi diritti. Ecco, gli esempi riportati sono del massimo livello, e spesso in essi l’elemento definibile in senso lato come saggistico (dove, cioè, l’intenzionalità fondamentale sia quella di trasmettere un pensiero o una conoscenza) si fonde e si confonde con l’elemento puramente letterario, ma mi pare di poter sostenere questa come caratteristica della traduzione saggistica rispetto alla traduzione letteraria: essa è piuttosto un’arte dell’approdo che un’arte della fuga, l’elemento di perdita (rispetto all’originale) è meno rilevante dell’aspetto di acquisto nella lingua di arrivo. Con un balzo nel tempo, pensiamo di quanti nuovi termini le traduzioni marxiane e freudiane hanno arricchito la lingua italiana, e non solo, e quindi la nostra potenzialità di pensiero: espressioni delle quali ci pare oggi impossibile poter fare a meno, da nozioni più forti e definibili come quella di «forza-lavoro», di «capitale», di «capitalismo» a nozioni più impalpabili come quella di «inconscio» o di «perturbante». Si tratta, si badi, di termini che quasi sempre preesistevano, ma che hanno assunto nuove sfumature, o che addirittura sono risorti dall’oblio in cui erano caduti, per esprimere qualcosa di nuovo, qualcosa di pensabile, adesso, e di comunicabile, creando una nuova koinè. Perturbante traduce il tedesco unheimlich: in passato «perturbare» significava qualcosa che turbava gravemente con quel «per» dall’effetto intensificativo, oggi, «il perturbante», dopo la lezione freudiana e l’avvenuta traduzione, ha assunto il più sottile significato di qualcosa che inquieta per la sua non familiarità, con un margine di mistero e di inafferrabile. Gli esempi potrebbero essere molti, ma fermiamoci qui.
3. Adattarsi al contesto
Passiamo all’oggi, con una mossa del cavallo, a due parole recenti della saggistica politica, nell’originale governance e e gouvernamentalité, di significato non troppo dissimile, che ci permettono di sviluppare una serie di considerazioni generali. Come tradurle, che significato hanno? Questo tipo di parole/concetto senz’altro nuove, pur se la loro radice è chiaramente identificabile, col tempo tendono a essere tradotte con un calco (e questa è, o era, possiamo, dire la norma generale). In realtà, la seconda (di matrice foucaultiana) è ormai usualmente tradotta con «governamentalità» (proviene dal francese, lingua ormai in declino!), ma bisogna dire che è anche assai poco usata, se non in ambito specialistico; la prima, la cui origine risale agli anni Cinquanta e all’ambiente degli studiosi di scienza politica degli Stati Uniti, dopo una serie di timidi tentativi traduttivi come «governanza» si è decisamente affermata nell’originale inglese di «governance» (pur con il suo marchio latino) e il suo uso è ormai ad ampio spettro. La parola governance è arrivata a significare l’arte dell’amministrazione dei conflitti in ambito «democratico» allo scopo di creare consenso nei confronti dei decisori. Concetto nuovo, parola nuova. E il traghettatore come deve comportarsi? Cercare un’altra parola, fare il calco, mantenere l’originale? Come si sa, e come si è capito, ormai spesso se il termine è anglosassone si tende a mantenerlo nella sua originarietà, se deriva da altre lingue si può vedere, ma spesso si traduce. Ovviamente, viviamo in un’epoca (di sicuro ancora per un po’) di egemonia dell’inglese e dell’anglo-americano particolarmente in ambito saggistico (la stragrande maggioranza dei testi saggistici tradotti in italiano – ma anche dei testi in generale prodotti – è scritta in inglese, lingua che sempre più spesso viene anche direttamente utilizzata da studiosi di altre madri lingue). In questi casi il compito del traghettatore è semplice, non deve darsi troppo da fare e deve piegarsi a un’egemonia riconosciuta. Il suo compito (soprattutto in Italia) è, insomma, un po’ diverso, e più umile, da quello di Girolamo di Stridone. Il traghettatore deve adattarsi all’humus e ai tempi in cui opera. Francesi e spagnoli forse agirebbero diversamente (computer è diventato, per loro, rispettivamente ordinateur e computadora)… Possiamo però consolarci pensando alla matrice latina del termine. E sicuramente, comunque, il nostro pensiero si è arricchito.
4. La traduzione saggistica come avventura
Prima di entrare in questioni più particolari, vorrei sottolineare i risvolti soggettivi e gratificanti del lavoro di traduttore di saggi. In comune con tutti gli altri individui dediti al lavoro del «voltare» da una lingua all’altra, egli sa per esperienza che «tradurre è il vero modo di leggere un libro», come ha notoriamente e autorevolmente sostenuto in un suo celebre pezzo Italo Calvino. Ogni parola, per lui, assume un peso, ogni giro di frase va attentamente ponderato: nulla è superfluo, tutto è necessario. In tal modo il lettore-traduttore diventa anche un critico.Coglie come dietro quella certa parola o quella certa frase che sembra comparire di passata, si celi uno snodo importante, oppure anche coglie una falla di ragionamento, o una faglia del discorso. Ma soprattutto ogni traduzione si trasforma in una nuova avventura, un viaggio mentale in territori inesplorati, in terre in cui si è forse già viaggiato, ma da turisti frettolosi che vogliono impossessarsi di tutto e subito. Aspetti che prima erano stati solo sfiorati si dispiegano, rivelano anfratti nascosti, si articolano, si approfondiscono. Parti per la Russia otto-novecentesca, come nella Danza di Nataša di Orlando Figes, e quei romanzi che prima avevi letto appassionandoti soprattutto alle psicologie e alle vicende, o le poesie cui ti eri abbeverato preso dal fascino di immagini e sentimenti, si rivelano prismi che moltiplicano lo sguardo aprendo squarci illuminanti su un’intera società e sul suo destino (non mi ci soffermo, ma certo qui non si vuole sostenere che il valore di un testo letterario stia nella sua capacità di rispecchiamento della società, come qualcuno sosteneva un tempo, ma certo come il retroterra illumina il testo, così il testo illumina il retroterra da cui è emerso, e lo fa con i mezzi propri della letteratura). L’episodio della danza di Natascia nella casa di campagna, che forse era sfuggito al lettore avido, si rivela come un’epifania, come la concreta e fulminante rappresentazione del desiderio carsico di molta aristocrazia di sentirsi popolo, di avvicinarsi al popolo, in una sorta di prepolitica ansia di fraternità e di uguaglianza. Le talvolta criptiche poesie dell’acmeista Anna Achmatova rivelano, in filigrana, un profondo attaccamento alla terra russa, tanto che questa poetessa, considerata «intimista», in epoca sovietica non sceglierà l’emigrazione, ma vorrà diventare «la bocca straziata con cui un popolo di cento milioni grida» (Requiem), finendo col diventare una sorta di icona patriottica durante la seconda guerra mondiale, e di qui si possono innescare in noi riflessioni – che ahimè ci riguardano da vicino – del ruolo di una voce non asservita in un’epoca di servitù (nel nostro caso «mediatica»).
Inoltrandoti in Maometto di Tariq Ramadan, quella penisola arabica del VI-VII secolo che immaginavi come un mero deserto culturale e fisico, si rivela, via via, come una realtà pullulante di commerci e di comunità organizzate in parte ancora idolatre, ma in buona misura ebraiche o cristiane, con imprevisti scambi culturali tra di loro. Traducendo Beirut di Samir Kassir (una grande voce ponte tra Occidente e Islam, non a caso liquidata da qualche mano occulta), il sogno della fusione tra cristiani e musulmani, tra le loro civiltà (peraltro ampiamente variegate), che si incarnava nella città di Beirut, si materializza dapprima davanti ai tuoi occhi per poi sgretolarsi miseramente e drammaticamente, tanto che Beirut, come poi Sarajevo, diventerà sinonimo di caos.
Traducendo Il mondo che non fu mai di Alex Butterworth ti si sciorina di fronte l’universo anarchico e nichilista del secondo Ottocento in tutta la sua ampiezza, con i suoi gesti eversivi, dinamitardi, nati da una risentita brama di giustizia, sullo sfondo della cosiddetta «belle époque» e vedi prendere forma quel micidiale intreccio da cui scaturirono i servizi segreti, le polizie politiche e le loro provocazioni fino ai fatidici Protocolli dei savi di Sion (e qui l’Ochrana docet, la limacciosa antecedente della sinistra Ceka). Per sintetizzare, si potrebbe dire: «Intorno agli effetti non voluti del terrorismo», e il nostro pensiero corre all’11 settembre. E penetri nella rappresentazione della mentalità del terrorista grazie al contributo dei tanti romanzieri come Dostoevskij, Conrad e James che furono come medusizzati da questa figura e ne diedero una torbida, demoniaca rappresentazione, acuta ma non disinteressata. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi.
5. Il saggio come metatesto
Ciò che mi preme sottolineare è l’aspetto di viaggio della traduzione, viaggio che si allarga a macchia d’olio, visto, come si intravede dagli esempi riportati, che, di massima e, direi, per essenza, il testo saggistico è un metatesto, un testo su altri testi (che possono essere letterari, filosofici, scientifici… ma possono essere anche semplicemente un documento o un articolo di giornale). E così sei indotto a riprendere in mano I demoni, L’agente segreto, Guerra e pace, Anna Karenina, La principessa Casamassima e a vedere queste opere in una nuova luce, da un taglio particolare. E così dal Maometto sei portato a consultare il Corano e a scoprire le sue varie e diverse traduzioni, a percorrere i Detti e fatti del Profeta di al-Buhari, la Vita di Maometto di al-Tabari… scopri, in questo caso, un mondo che ti era largamente ignoto. Ogni testo si rivela una struttura en abîme. E ciò che sembrava immobile, omogeneo, privo di porosità, unidimensionale si rivela mosso, cangiante, aperto, stratificato. Potrebbe naturalmente essere un viaggio interminabile, quello del traduttore, e solo il principio di realtà pone ad esso un alt, o meglio impone una pausa, una sospensione, per poi essere ripreso con altri testi. La tua mente nel frattempo si è allargata.
6. Scrittura letteraria e scrittura saggistica
Ma si può fare una netta distinzione tra saggistica e letteratura d’invenzione, tra saggistica e narrativa (e quindi anche tra il compito del traduttore di narrativa e quello del traduttore di saggistica)? Evidentemente no. O meglio, non sempre e non esattamente. Ci sono grandi saggisti che sono parimenti grandi letterati e grandi stilisti (Walter Benjamin, Jean Starobinski, Michel Serres, per fare qualche esempio). Ci sono narratori che hanno scritto e scrivono opere saggistiche (nel passato, pensiamo a Dostoevskij e al suo Diario di uno scrittore, per la verità un centone in cui sono anche incastonati racconti; a Thomas Mann e alle sue Considerazioni di un impolitico; pensiamo al Gadda di Eros e Priapo, e non solo) o grandi autori nei quali l’elemento saggistico e quello narrativo sono strettamente intrecciati se non fusi (citiamo Musil per tutti). Ci sono scrittori, soprattutto contemporanei, che dimostrano nelle loro opere come il diaframma tra le «due culture», deprecato e individuato da Charles Snow nel lontano 1959, sia superato o perlomeno sia superabile. Autori come Jonathan Franzen (Come stare soli. Lo scrittore, il lettore e la cultura di massa), Joseph McElroy (Exponential), James Ballard (Fine millennio. Istruzioni per l’uso), ma anche Antonia Byatt nei suoi romanzi, ci parlano di botanica, di zoologia, di neuroscienze, di architettura, di sociologia: ciò
accredita come meglio non si potrebbe la speranza che esista davvero, se non una lingua del buon senso, quanto meno un’accettabile koinè del senso comune, e che tutti i linguaggi e tutti i saperi, anche i più astrusi e formalizzati, siano sostanzialmente traducibili e trapiantabili, al di là delle loro technicalities, in quella fertile provincia della ragione pubblica, dialogica, intersoggettiva, che Bachtin aveva assegnato come perpetuo dominio alla parola romanzesca
come scrive Daniele Giglioli.
7. Il traduttore come Zelig
Quando ci si trova ad affrontare autori di questo genere, anche se di minor calibro, i problemi che si presentano al traduttore di saggi sono analoghi, se non identici, a quelli della traduzione letteraria. Rispetto assoluto del testo, attenzione somma allo stile, individuazione di una “voce” peculiare, la grana di quella voce, quella dell’autore appunto, con in più una competenza che si ha, o che ci si deve conquistare, sui tecnicismi specifici di una certa sfera di conoscenze. Se ho a che fare con Starobinski (Montesquieu), cerco di ricrearne lo stile cristallino, icastico, dove ogni parola è trascelta con cura e precisione suprema; con McElroy (Exponential), debbo adoperarmi per mantenere la complessità avvolgente, spiraliforme dello stile, le frasi senza predicato, la sintassi ricca di anacoluti, la mescolanza di linguaggio quotidiano e linguaggio scientifico, le metafore tecnologiche («il sistema di raffreddamento dei fatti», ad esempio); con Serres (L’ermafrodito), debbo farmi scintillante e risolvere i suoi innumerevoli giochi linguistici (Minuit, milieu). In breve, il traduttore come Zelig.
8. Una puntualizzazione
Le rapide osservazioni successive si riferiranno in particolare alla vastissima area della produzione saggistica cosiddetta umanistica (storica, sociologica, filosofica, di critica letteraria, di storia dell’arte) o anche di riflessione scientifica o di confine – borderline – con specifiche scienze: dalla psicologia alla psicoanalisi, alla fisica, all’evoluzionismo… E le questioni cui accenneremo si vanno facendo sempre più impellenti: infatti se in passato i testi saggistici, con le dovute eccezioni, avevano quasi sempre un taglio ingessatamente accademico (che lasciava poco margine d’intervento al traduttore) o, all’opposto, un semplificato taglio divulgativo (celebre quello alla Reader’s Digest,che ha imperversato per alcuni decenni del secolo scorso) che richiedeva semplicemente doti di scorrevolezza e l’uso di un lessico preciso, ma limitato, oggi, per influenza soprattutto della produzione anglosassone (in particolare in campo storico e scientifico), ma anche francese (in particolare in campo filosofico), il saggista si vuole anche narratore: brillante, coinvolgente, mira a un proprio stile, senza per questo perdere in serietà e rigore. Ovviamente, non ci occuperemo di traduzione tecnico-scientifica o di servizio, per la quale il discorso, ça va sans dire, è diverso, e diventa di mera e specifica competenza.
9. Ribes o uva sultanina?
Dato per scontato che il traduttore di saggistica deve conoscere bene la lingua di partenza come quella di arrivo (e gli si richiede forse maggior competenza nella propria lingua che non in quella da cui traduce), cosa per lui fondamentale è avere nozione del contesto culturale, concettuale, storico e materiale dell’opera che traduce e, ovviamente, dei testi cui essa fa riferimento o sui quali sviluppa il proprio discorso (il saggio è per sua natura, come si è accennato, un metatesto). Il termine inglese currant, ad esempio, significa sia “ribes” che “uva sultanina”, e il significato più ovvio oggi è il primo: se lo incontro citato di passata in un contesto di commerci mediterranei del Seicento, mi deve perlomeno sorgere il dubbio che “ribes” non sia la soluzione corretta (non siamo nelle campagne del Sussex). Consulto il dizionario e scopro il significato, a me prima ignoto, di “uva sultanina”; a questo punto la soluzione non può essere che una, se si ha idea di cosa sia l’uva sultanina e di quanto durassero all’epoca i viaggi di mare. Se incontro les mondains in un contesto sei-settecentesco francese, ad esempio in Starobinski che parla di Montesquieu, non posso che tradurlo come “i mondani”, anche se vorrei rifuggirne, perché così erano definiti, in contrapposizione ai “devoti”, coloro che si occupavano delle vanità del secolo, e non debbo lasciarmi fuorviare dal significato che ha oggi assunto la parola, che ha peraltro mantenuto qualche nesso col significato francese seicentesco; senonché per “vanità del secolo” allora si intendevano anche le professioni, i commerci e gli interessi culturali di tipo non religioso. Peraltro, se traducendo incappo in un riferimento ai governi socialisti italiani di fine Ottocento, debbo sostare un momento e capire la ragione della palese scorrettezza, per emendarla: l’autore intendeva evidentemente riferirsi ai governi della “Sinistra storica”, ma conoscendo poco la storia italiana ha preso un abbaglio. Tra l’altro il suo fraintendimento, se può apparire veniale agli occhi di un lettore anglosassone, diventa capitale agli occhi di un lettore italiano mediamente colto.
Il traduttore, insomma, deve essere fornito di certi strumenti culturali, oppure avere la responsabilità e la dignità di non accettare lavori che non rientrino nei suoi campi di competenza. Certo, ci sono altri fattori in gioco… la necessità di lavorare, per dire, che rende temerari e avventati.
10. Sensum exprimere de sensu
In che misura devo essere fedele all’originale? Come posso essere insieme fedele all’autore e alla lingua italiana? Fino a che punto posso intervenire e spingermi nel rendere «chiaro» il testo di partenza?
È un problema che tutti i traduttori si trovano di fronte. La risposta, mai univoca, perché in questo campo non esistono regole imperative e inderogabili, dipende dal tipo di testi: più specialistici, più letterari, più divulgativi, più «saggistici», in fieri (come talvolta capita nel campo di cui ci occupiamo).
Di fronte al testo letterario di un autore riconosciuto come tale occorrerà comportarsi come Girolamo di fronte alla Sacre Scritture e tradurre (con giudizio) verbum e verbo, parola per parola: non si deve levare, né aggiungere, non si deve cercare di chiarire, soprattutto di chiarire troppo (va mantenuto il margine di ambiguità e di polivalenza cui mirava l’autore), occorre rispettare al massimo il testo d’origine; naturalmente si tratterà di individuare uno stile, un registro, la voce appunto dello scrittore.
Nella traduzione saggistica deve invece tendenzialmente prevalere il sensum exprimere de sensu (sempreché non si tratti di un testo ad alta valenza autoriale): occorre cogliere il senso del testo e renderlo nel modo migliore nella lingua in cui si volge il testo, con un margine di libertà variabile a seconda del valore stilistico del testo di partenza. Naturalmente esistono dei limiti: nella saggistica latamente scientifica o specialistica occorre attenersi, per quanto riguarda i termini specifici di quel certo campo, a un vocabolario da cui è bene non derogare (ci si può avvalere di dizionari specialistici, e, in ogni caso, bisogna stabilirne uno proprio). Delusion in un testo psicologico diventerà “delirio”, drive “impulso” o “pulsione”: non ci si può sbizzarrire troppo. In un testo che fa l’occhiolino all’astronautica come Exponential di McElroy, parking orbit va tradotto “orbita di parcheggio” e non altrimenti. Il problema si pone, comunque, sempre per le parole chiave di un testo, attorno alle quali l’autore costruisce un discorso: occorre trovare una soluzione più semplice o meno semplice, più ovvia o meno ovvia, e poi attenercisi. Se Michel Serres ne L’ermafrodito ha scelto di usare il termine di matrice greca paraschiste per l’evisceratore (lo specialista che preparava i cadaveri per la mummificazione), anche il traduttore dovrà piegarsi a questa scelta e adotterà “paraschista” (termine che nell’originale greco significa una concretissima operazione, ma nel calco che se ne fa in un’altra lingua assume sfumature più astratte e può essere meglio utilizzato metaforicamente); se usa enanthiomorphe il traduttore dovrà adottare “enantiomorfo”, per quanto i vocaboli citati possano apparirgli desueti o astrusi e sia quindi tentato di “chiarirli” o di “scioglierli”. Se James Clifford nel testo antropologico-letterario I frutti puri impazziscono fa perno attorno alla parola/concetto di displacement, uno «spostamento» che è insieme geografico, mentale e culturale, bisognerà per tutto il saggio attenersi alla traduzione “spostamento”, senza ricorrere a pur validi sinonimi. Si tratta, infatti, di parole/concetto o di espressioni che definiscono il campo semantico-discorsivo dell’autore.
Per il resto, come abbiamo già accennato, non esistono regole rigide: la traduzione è infatti una pratica impura, nella quale gioca un numero indefinito di variabili, che vanno di volta in volta individuate, cui di volta in volta si cerca una soluzione (che non è mai unica: provate a far tradurre anche la più semplice delle frasi a n persone e otterrete n diverse traduzioni): il tipo di testo, il suo specifico stile o non stile, il pubblico cui si rivolge, il contesto editoriale in cui è inserito, la sua maggiore o minore contemporaneità. Ci sono poi mille altri problemi particolari (le note, la bibliografia, le note del traduttore, come riportare i titoli citati – nell’originale o no? -, i nomi geografici, le traslitterazioni, l’utilizzazione di parole straniere, i realia…), quelli che si possono definire “i ferri del mestiere”. Ma mi soffermerò soltanto su un ultimo punto.
11. I rischi del politicamente corretto e dell’attualizzazione
Ci sono parole che, anche con ottime ragioni, sono diventate tabù, o meglio che stridono con la sensibilità odierna, come «razza», «imbecillità», «cretinismo» (queste due ultime, ovviamente, in ambito psicologico). E il traduttore, spesso, quando si trova di fronte ai termini corrispettivi in altre lingue, tende a edulcorarli, a renderli meno ostici, a darne una versione più accettabile a orecchie odierne. E così imbecility diventa il più lieve “ritardo mentale”, e race diventa il meno pericoloso “etnia”; ma così facendo si può perdere l’intenzione – quale che sia – dell’autore (se è un nostro contemporaneo) o si può perdere il sapore di un’epoca con il suo linguaggio, se l’autore non è nostro contemporaneo. “Razza” nel primo e secondo Ottocento, ad esempio, non implicava ancora le valenze razziste che il termine cominciò ad assumere a fine Ottocento col tardo positivismo e che diventarono poi dominanti negli anni Trenta. Melancholia, a sua volta, per amore di attualizzazione può diventare facilmente “depressione”, anziché «malinconia», con perdita di sfumature d’epoca, magari, però, con acquisto di comunicabilità. Sono tante allora le domande che il traduttore di saggi deve porsi in casi simili, e le risposte dipendono dal testo d’origine, dalla lingua del testo d’origine (perché lo stesso vocabolo – imbécile, imbecil, imbecille – può suonare più o meno forte nei diversi ambiti linguistici), dal contesto storico-culturale che l’opera affronta, da quello in cui il testo è nato (dove, quando). Tutto ciò comporta complessi problemi di consapevolezza da parte di chi traduce, ma un aiuto si può sempre trovare: bisogna, però, cercarlo. E il traduttore (di saggi) deve essere ardito, ma anche prudente: le sensibilità che può toccare sono tante.
12. La traduzione saggistica è “seminale”
All’inizio ho usato il vocabolo “seminale”. L’avrei usato solo dieci o vent’anni fa? Non penso. Si tratta di un esempio, tra i tanti possibili, di come la traduzione saggistica arricchisca la lingua che scriviamo e che parliamo. E torniamo, per chiudere il cerchio, a un punto già accennato con «governance», con la differenza che qui si tratta non più di una parola/concetto di ambito specialistico che arricchisce il pensiero, ma di una voce generalista che arricchisce la lingua. A lungo i traduttori si sono arrovellati su come tradurre l’aggettivo seminal e qualcuno, pigramente o audacemente, cominciò a usarne il calco italiano (peraltro il vocabolo è di matrice neolatina). All’inizio, nel contesto linguistico italiano, “seminale” pareva incongruo, fastidioso, se non addirittura molesto. Poi, poco a poco si è affermato, e in effetti si è capito come dica qualcosa di più e di diverso da “pioneristico”, o da “fecondo”, le traduzioni in precedenza più accreditate: in effetti, significa entrambe le cose contemporaneamente. Un’opera seminale è, insieme, un’opera innovativa, un’opera che lascia il segno e un’opera che ne genererà o influenzerà molte altre. L’italiano si è arricchito.
In fin dei conti, un merito non da poco, per “seminale” e per la traduzione saggistica.
Nota bibliografica
Questo articolo si fonda su un’esperienza personale, che ha fruttato le seguenti traduzioni di mia mano:
Alex Butterworth, Il mondo che non fu mai, di prossima pubblicazione da Einaudi (edizione originale: The World That Never Was. A True Story of Dreamers, Schemers, Anarchists and Secret Agents, The Bodley Head, London 2010).
James Clifford, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino 1993 (edizione originale: The Predicament of Culture.Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art, Harvard University Press, Cambridge MA 1988).
Orlando Figes, La danza di Nataša. Storia della cultura russa (XVIII-XX secolo), Einaudi, Torino 2004 (edizione originale: Natasha’s Dance. A Cultural History of Russia, Allen Lane, London 2002).
Samir Kassir, Beirut. Storia di una città, Einaudi, Torino 2009 (edizione originale: Histoire de Beyrouth, Fayard, Paris 2003).
Joseph McElroy, Exponential, Bollati Boringhieri, Torino 2003 (raccolta di saggi scelti da McElroy espressamente per l’Italia).
Tariq Ramadan, Maometto, Einaudi, Torino 2007 (edizione originale: In the Footsteps of the Prophet. Lessons from the Life of Muhammad, Oxford University Press, New York 2007).
Michel Serres, L’ermafrodito: Sarrasine scultore, Bollati Boringhieri, Torino 1989 (edizione originale: L’hermaphrodite. Sarrasine sculpteur, Flammarion, Paris 1987).
Jean Starobinski, Montesquieu, Einaudi, Torino 2002 (edizione originale: Montesquieu, edizione riveduta, Éditions du Seuil, Paris 1994; la prima edizione è del 1953).
La citazione di Daniele Giglioli (critico letterario, docente di Letterature comparate presso l’Università di Bergamo) proviene dall’articolo Romanzieri in presa diretta sul reale, pubblicato su «il manifesto» del 29 ottobre 2003.
Quella di Édouard Glissant da Introduction à une poétique du divers, Gallimard, Paris 1996, p. 36 (trad. it. di Francesca Neri, Poetica del diverso, Meltemi, Roma 1998, p. 38).