ALESSANDRO PICCOLOMINI VOLGARIZZATORE RINASCIMENTALE DI ARISTOTELE E LA SUA TEORIA DELLA TRADUZIONE
di Eugenio Refini
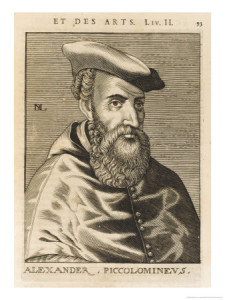 I teorici classici della traduzione – Cicerone e Gerolamo in primis – fanno del rapporto tra “senso” e “parola” il cardine delle proprie riflessioni. La dicotomia canonica fra traduzione letterale (verbum de verbo) e traduzione libera (ad sensum) non rende tuttavia conto della varietà di soluzioni intermedie che, in concreto, hanno caratterizzato la pratica del tradurre. Caso emblematico della molteplicità dei modi della traduzione è la ricezione del filosofo greco Aristotele tra tardo Medioevo e Rinascimento, fenomeno di ampio respiro che, fra teoria e prassi, anticipa e tematizza alcuni dei nodi concettuali tutt’oggi al centro degli studi sulla traduzione. Nei paragrafi che seguono, dopo una sintetica introduzione volta a definire lo stato della questione tra l’età di Dante e l’avvento dell’Umanesimo, ci si soffermerà sul contributo di Alessandro Piccolomini (1508-1579) alla riflessione rinascimentale sulla traduzione come strumento di divulgazione del sapere filosofico-scientifico classico.
I teorici classici della traduzione – Cicerone e Gerolamo in primis – fanno del rapporto tra “senso” e “parola” il cardine delle proprie riflessioni. La dicotomia canonica fra traduzione letterale (verbum de verbo) e traduzione libera (ad sensum) non rende tuttavia conto della varietà di soluzioni intermedie che, in concreto, hanno caratterizzato la pratica del tradurre. Caso emblematico della molteplicità dei modi della traduzione è la ricezione del filosofo greco Aristotele tra tardo Medioevo e Rinascimento, fenomeno di ampio respiro che, fra teoria e prassi, anticipa e tematizza alcuni dei nodi concettuali tutt’oggi al centro degli studi sulla traduzione. Nei paragrafi che seguono, dopo una sintetica introduzione volta a definire lo stato della questione tra l’età di Dante e l’avvento dell’Umanesimo, ci si soffermerà sul contributo di Alessandro Piccolomini (1508-1579) alla riflessione rinascimentale sulla traduzione come strumento di divulgazione del sapere filosofico-scientifico classico.
Aristotele «maestro di color che sanno»
«Tutti lo miran, tutti onor li fanno»: stando alla Commedia di Dante Alighieri (Inferno, IV, 133), il destino ultramondano di Aristotele – per quanto escluso dalla salvazione cristiana – è un destino di ammirazione e onore. La «filosofica famiglia» che, nel Limbo, circonda il «maestro di color che sanno» (ivi, 131-132), raccoglie sapienti di ogni epoca che, vissuti prima della rivelazione, riconoscono in Aristotele una comune fonte di sapere e conoscenza. D’altra parte, il filosofo per antonomasia, maestro in tutti i campi dello scibile, non esercita la propria autorevolezza solo sui sapienti che risiedono nel Limbo. Così come Socrate e Platone onorano Aristotele nello spazio rassicurante del castello degli spiriti magni, Dante stesso riconosce a più riprese il proprio debito nei confronti del magistero aristotelico e, più in generale, della tradizione filosofica che, filtrata attraverso l’interpretazione cristiana, da quel magistero si irradia. In tal senso l’immagine del pellegrino Dante che, accompagnato da Virgilio, reca omaggio ad Aristotele e alla «filosofica famiglia» diventa emblema di un vero e proprio processo di traduzione culturale di cui l’Alighieri si fa interprete consapevole.
La Commedia, frutto ultimo di un percorso epistemologico che include a pieno titolo opere come il Convivio ed il De vulgari eloquentia, può infatti essere letta come uno straordinario esempio di translatio in cui il recupero della tradizione classica – seppure ancora al di qua della dimensione filologica che sarà propria dell’Umanesimo – alimenta la messa a punto di quelle forme del sapere che stanno alla base della civiltà europea tra Medioevo e prima età moderna. Come già suggerito da Dante nel Convivio, il ruolo di Aristotele all’interno di questo processo è centrale: «Sì come dice lo Filosofo nel principio de la Prima Filosofia, tutti li uomini naturalmente desiderano di sapere» (Convivio, I, i, 1). Ma perché ciò sia possibile, Dante aggiunge, occorre che gli uomini posseggano gli strumenti per procedere nell’acquisizione della conoscenza, ovvero di una lingua che sia in grado di comunicare («manifestare conceputa sentenza», ivi,I, x, 9). Ma, nel contesto in cui si muove Dante, l’accesso al sapere è privilegio di chi conosce il latino, giacché quella è – e lo sarà ancora per molti secoli – la lingua della scuola e delle università. La rivoluzione culturale avviata dall’Alighieri mira pertanto a rompere le barriere tra lingua dei letterati (coloro che hanno dimestichezza con il latino) e lingua degli illetterati (coloro che alla cultura latina non hanno accesso), facendo della lingua volgare – la lingua parlata naturalmente da uomini e donne – il veicolo del sapere. Questa è – almeno nelle intenzioni – una delle scommesse del Convivio, ed è qui che il progetto culturale dantesco viene ad interagire con il tema della traduzione e, più propriamente, del volgarizzamento.
Nel suo illuminante saggio Volgarizzare e tradurre (1991), Gianfranco Folena affrontava – tanto sul piano teorico quanto su quello dell’analisi delle fonti primarie – l’evoluzione del concetto di traduzione tra Medioevo e Rinascimento. Se la pratica del volgarizzamento, sempre più diffusa in Italia a partire dal tardo Duecento, contribuisce sensibilmente alla nascita ed affermazione del volgare come lingua di cultura, è solo con la consapevolezza teorica degli umanisti – principalmente interessati alla versione latina di testi greci – che si può parlare, secondo Folena, di traduzione in senso moderno. Eppure, al di là di distinzioni di comodo, le differenze di statuto tra volgarizzamento e traduzione restano ambigue, soprattutto nella complessa fase di transizione culturale che dall’età di Dante giunge a maturazione nel Cinquecento. Che cosa distingue, infatti, il volgarizzamento dalla traduzione?
Come mostrato da un recente volume di Alison Cornish (2011), tra Duecento e Trecento il volgarizzamento si afferma come vera e propria forma mentis, come prassi legata non tanto all’idea di autorialità della traduzione, quanto al più generale bisogno di appropriarsi, attraverso la riscrittura, di un patrimonio culturale “altro”. Indagando le vie, le forme, e i modi del volgarizzamento in Italia all’epoca di Dante, Cornish individua proprio nel riscrivere per adattare la ragione primaria di un’intensa attività traduttiva rivolta al sempre più ampio pubblico dei lettori illetterati. Si tratta di testi e materiali che, spesso molto diffusi, vengono a costituire il bagaglio culturale delle classi medio-alte, intellettualmente vivaci, ma estranee ai luoghi canonici della cultura latina (università e studia degli ordini religiosi). Un esempio fra tutti: il Tresor di Brunetto Latini, opera enciclopedica che, prevalentemente composta da volgarizzamenti di opere medio-latine, ebbe circolazione ampia, tanto nell’originale francese quanto nella versione italiana. Vero e proprio best seller, la summa brunettiana si configura come il tentativo di offrire alla nuova classe mercantile un vademecum filosofico che copra le principali – e più immediatamente spendibili – aree del sapere: un’infarinatura generale di quella che Brunetto chiama filosofia “teorica” e, soprattutto, un utile compendio di etica, retorica e politica, strumenti imprescindibili per i cittadini dei comuni italiani medievali. Aristotele vi gioca senza dubbio la parte del leone, tanto che la sezione dedicata alla filosofia morale si presenta come un sunto dell’Etica Nicomachea: quella che Brunetto chiama Ethique d’Aristote, infatti, non è altro che la traduzione di un celebre compendio arabo della Nicomachea noto come Summa Alexandrinorum, volto in latino da Ermanno il Tedesco negli anni Quaranta del Duecento, e, pochi anni dopo, tradotto di latino in volgare italiano dal medico fiorentino Taddeo Alderotti, professore universitario a Bologna. A prescindere dal complicato rapporto testuale che lega la versione italiana di Taddeo a quella francese di Brunetto (Gentili 2005, 41-49), ciò che preme qui sottolineare è la centralità dell’auctoritas aristotelica. Mentre i testi aristotelici vengono letti (rigorosamente in latino), interpretati e discussi nelle università e negli studia religiosi, il «maestro di color che sanno» inizia ad essere letto – seppure in versione compendiata – da un pubblico nuovo, più ampio e animato da intenti diversi rispetto a quelli degli studiosi. Un pubblico che, proprio come suggerito dall’opera di Brunetto Latini, trova nella morale di Aristotele e nella retorica di Cicerone (l’altra componente essenziale del Tresor) i fondamenti del vivere civile e comunitario. Questo, come già suggerito dalle pagine lungimiranti di Concetto Marchesi (1904), è il senso profondo del volgarizzamento come esercizio di traduzione culturale nella civiltà italiana del Medioevo.
Resta aperta, d’altra parte, la questione relativa all’evoluzione delle pratiche traduttive e delle teorie sulla traduzione, entrambe fortemente influenzate dal modo in cui la tradizione classica riafferma la propria presenza attraverso la rivoluzione culturale dell’Umanesimo. Le riflessioni di Carlo Dionisotti nel suo Tradizione classica e volgarizzamenti (1967) risultano, a questo proposito, ancora attuali; e l’invito a esplorare le vicende del volgarizzamento nell’età in cui gli Umanisti professano il ritorno filologico ai testi antichi è lungi dall’essere pienamente soddisfatto. In tale quadro, la ricezione di Aristotele si presenta come oggetto d’indagine ideale. Il susseguirsi di atteggiamenti e istanze culturali diverse che la caratterizzano, unitamente ai modi e alle forme della trasmissione del testo, contribuiscono infatti ad un mosaico di testimonianze di notevole interesse per gli studi sulla traduzione.
Com’è noto – e torniamo al Convivio – Dante fu critico nei confronti dei volgarizzatori: i modelli offerti da Taddeo Alderotti e Brunetto Latini, per motivi diversi, vengono rifiutati. In un caso l’uso di un volgare che, troppo ancorato alle forme del discorso latino, non fa leva sulle potenzialità della lingua; nell’altro, il ricorso a un volgare diverso (il francese), pregiudizialmente considerato migliore di quello italiano. La difesa del volgare come lingua del sapere che Dante elabora nel primo trattato del Convivio viene pertanto a offrire una prospettiva nuova rispetto a quella incarnata dalla coeva fortuna dei volgarizzamenti. L’Alighieri pensa alla translatio come un esercizio che va al di là della mera «transmutazione» da una lingua all’altra. Come suggerito da Cornish in un interessante confronto tra le posizioni di Dante e quelle di Walter Benjamin (Cornish 2011, 127-128), l’idea dantesca di translatio dovrà piuttosto essere intesa come rifondazione di un bagaglio culturale “altro” attraverso il potenziamento della lingua, essa stessa – ancor prima dei contenuti – strumento di conoscenza.
Se la posizione di Dante in quella che potremmo definire una querelle des anciens et des modernes ante litteram tende a privilegiare l’idea del mezzo linguistico naturale come strumento di conoscenza, l’apporto dell’Umanesimo alla riflessione su lingua e traduzione guarda in direzione diversa. Laddove opere come il Convivio e la Commedia “traducono” il sapere degli antichi a beneficio dei lettori moderni, la traduzione si conferma per gli umanisti come una pratica che privilegia l’uso del latino quale inequivocabile lingua di cultura. Le nuove traduzioni latine delle opere di Aristotele realizzate da Leonardo Bruni all’inizio del Quattrocento non si oppongono tanto ai volgarizzamenti, quanto alla “barbarie” delle traduzioni latine medievali. La celeberrima disputa con Alfonso de Cartagena sulla versione dell’Etica Nicomachea non si apre infatti al contesto degli illetterati, ma si configura come interna al mondo degli studiosi: da un lato la traduzione come ritorno al valore letterario, stilistico e formale dei classici; dall’altro la difesa della tradizione come banco di prova su cui l’esegesi medievale ha costruito il linguaggio ed il sistema del sapere condiviso dai letterati di professione. La vulgata storiografica ha teso a radicalizzare simili contrapposizioni, solitamente considerate come funzionali a una fase di transizione che vedrebbe il progressivo affermarsi della cultura umanistica su quella scolastica. Uno sguardo più attento alle varie implicazioni in gioco mostra tuttavia come, soprattutto nel corso del Quattrocento, il conflitto trovi nello scambio e nella compresenza una definizione più complessa. All’interno di un quadro che si mostra ben più articolato di quanto le semplificazioni imposte dalla storia degli studi non abbiano rilevato, persino la distinzione tra ambiti linguistici concorrenti – il latino e il volgare – necessita di essere problematizzata. Ed è ancora una volta la storia dell’aristotelismo a fornire spunti di interesse.
Contemporaneamente alla fioritura della letteratura umanistica, con la sua nuova ondata di traduzioni dal greco in latino ed il suo programmatico rifiuto della tradizione scolastica, i lettori volgari iniziano a richiedere traduzioni delle opere di Aristotele che possano guidarli nella costruzione di un nuovo mondo cittadino in cui la cultura filosofica non è più solamente appannaggio delle università. Etica e Retorica, non stupisce, sono i testi più richiesti, e la loro diffusione in volgare segue vie parallele a quelle della diffusione latina: tanto la versione latina medievale dell’Etica Nicomachea quanto la nuova versione di Leonardo Bruni vengono tradotte in volgare intorno alla metà del Quattrocento: prodotti accomunati dal mezzo linguistico, ma chiaramente nati da impostazioni culturali divergenti (Refini 2013). D’altra parte, la distanza “storica” e l’idea di “differenza” che l’Umanesimo consegue nello studio dell’antico, influenzano anche il modo in cui i testi antichi vengono tradotti in volgare: al principio di appropriazione, caratteristico della tradizione dei volgarizzamenti, si sostituisce (o meglio, si sovrappone) quello della restituzione, processo ancora più evidente nel momento in cui i testi originali tornano a essere disponibili grazie alle conquiste della filologia, allo studio del greco e all’avvento della stampa. L’editio princeps delle opere di Aristotele in greco, pubblicata a Venezia da Aldo Manuzio tra 1495 e 1498, segna un momento di straordinaria importanza. Liberato dal Limbo delle versioni latine medievali, Aristotele può finalmente essere affrontato nella sua veste “originale”: è questa la nuova frontiera delle traduzioni volgari del corpus aristotelico nel Cinquecento che, in tal senso, possono effettivamente dirsi “umanistiche”.
Alessandro Piccolomini e la divulgazione del sapere
Fra i vari casi che costellano la riflessione cinquecentesca sulla traduzione spicca senza ombra di dubbio l’opera di Alessandro Piccolomini (1508-1579), filosofo e umanista senese che dedica gran parte della sua carriera di studioso alla divulgazione dei testi di Aristotele. Formatosi a Siena, dove prende attivamente parte alle vicende dell’Accademia degli Intronati, Piccolomini trascorre poi alcuni anni tra Padova e Bologna, luoghi d’eccellenza per lo studio dei testi aristotelici. Il soggiorno padovano, in particolare, segna una svolta di primaria importanza nel percorso educativo del senese: da un lato egli ha modo di entrare in contatto con gli esponenti della scuola aristotelica padovana, fiore all’occhiello dell’università cittadina, nota in tutta Europa per l’impegno profuso nell’interpretazione delle opere di Aristotele; d’altro lato, grazie alla frequentazione della locale Accademia degli Infiammati, Piccolomini può iniziare a confrontarsi con intellettuali del calibro di Benedetto Varchi e Sperone Speroni sul tema della traduzione dei classici. Per il giovane studioso impegnato nell’esegesi universitaria dell’Aristotele latino – quello stesso Aristotele latino che i teologi e i filosofi studiavano ai tempi di Dante – l’esperienza dell’Accademia degli Infiammati, non estranea alle forme e ai modelli di interazione che erano già stati propri dell’Accademia senese degli Intronati, è l’occasione ideale per un ripensamento dei modi della divulgazione del sapere.
L’idea di tradurre – nel senso letterale del verbo latino transferre – la filosofia degli antichi, e in particolare le opere di Aristotele, per un nuovo pubblico di lettori volgari esterni al mondo delle università è infatti alla base delle prime imprese editoriali di ampio respiro che Piccolomini compie negli anni padovani. L’Instituzione di tutta la vita dell’huomo nobile nato in città libera del 1542 si presenta come un vero e proprio compendio di filosofia morale che, esplicitamente basato su Aristotele e Platone (ma è la matrice aristotelica a segnare in modo preponderante il trattato), intende facilitare l’accesso del lettore alle questioni centrali dell’etica, della politica e dell’economica. Chiaramente pensata per un pubblico non addentro alle sottigliezze dell’interpretazione universitaria del corpus aristotelico, l’Instituzione interpreta la translatio come riduzione dei materiali filosofici antichi, riletti e adattati secondo i canoni della cultura cinquecentesca. Un testo di questo tipo, strutturato come un vero e proprio manuale che segue la formazione dell’individuo nelle sue varie fasi, tende – nonostante le ambizioni di esaustività che lo animano – alla semplificazione della materia trattata. Similmente i trattati astronomici sulla Sfera celeste e sulle Stelle fisse (1540), che compendiano in modo efficace fonti tolemaiche e la tradizione medievale de sphaera, mirano a divulgare nozioni e concetti solitamente inaccessibili ai lettori volgari.
Al di là dei temi specifici, la stampa dei due trattati astronomici riveste un’importanza particolare nella storia della divulgazione cinquecentesca in virtù delle dichiarazioni rilasciate dall’autore nell’epistola di dedica. Significativamente rivolta alla nobildonna senese Laudomia Forteguerri, la prefazione insiste sull’opportunità di permettere anche a lettori che non siano studiosi di professione l’accesso alla cultura scientifica e filosofica. Facendo eco al topos dantesco del legame naturale che lega la lingua volgare alle donne, Piccolomini individua proprio nella sua destinataria il lettore ideale dei trattati sulla sfera celeste. Impossibilitata ad avanzare negli studi dai costumi del tempo, Laudomia è tuttavia donna di ampia cultura e, dettaglio ancor più significativo, attenta lettrice di Dante e della Commedia. Proprio per colmare alcune sue lacune che rendono ostica l’interpretazione dei numerosi riferimenti astronomici nel poema dantesco, Piccolomini le offre un agevole manuale, sunto efficace delle voluminose trattazioni d’ambito scolastico. Come è stato debitamente osservato dagli studiosi, la dedica dei trattati sulla sfera e sulle stelle non va letta come un esempio di progressivismo femminista ante litteram, giacché essa sembra rispondere piuttosto alla particolare congiunzione che lega la cultura delle accademie al pubblico femminile in contesti specifici come gli Intronati senesi e gli Infiammati padovani. Resta tuttavia significativo che la dedica a una donna – nobile e colta, ma esclusa dal mondo degli studi – si associ qui non tanto alla celebrazione topica della figura femminile, quanto all’esigenza di tradurre la tradizione filosofico-scientifica classica per un pubblico diverso da quello degli studiosi di professione.
L’esperienza di divulgazione avviata con l’Instituzione e con i libri Della sfera e Delle stelle fisse trova uno sviluppo coerente negli anni successivi al soggiorno padovano-bolognese di Piccolomini. Dopo una permanenza non lunga a Siena, il giovane prelato si trasferisce a Roma dove risiede stabilmente tra la fine degli anni Quaranta e la prima metà degli anni Cinquanta. Legato alla curia pontificia e molto vicino all’ambiente culturale che gravita attorno alla figura del cardinale Giovanni Ciocchi del Monte, poi papa Giulio III, Alessandro avvia proprio a Roma un progetto di divulgazione del corpus aristotelico che si concretizza nella pubblicazione dell’Instrumento della filosofia (1551), della Prima e della Seconda parte della filosofia naturale (1551, 1554). Stampati dall’editore romano Valgrisi, i tre volumi offrono al lettore volgare la possibilità di un primo e ordinato approccio alla filosofia di Aristotele: prima la logica, giustappunto «instrumento» della filosofia, poi la filosofia naturale propriamente detta. Anziché tradurre l’Organon o la Fisica di Aristotele, Piccolomini preferisce “riscriverle” riassumendole e adattandole alle esigenze di un pubblico che, non a proprio agio con le complessità del testo aristotelico, necessita di una panoramica sull’argomento. Seconda una prassi tipica del suo modo di procedere – e giustificare il proprio lavoro – nelle epistole prefatorie dei volumi il senese espone le sue idee sulla necessità di divulgare Aristotele. A quest’altezza cronologica, l’impegno piccolominiano si volge interamente alla riscrittura come modalità traduttiva, metodo che impone selezione dei materiali, omissioni, riformulazioni. La scelta di Piccolomini, come già nel caso dell’Instituzione e dei compendi astronomici, si rivela vincente: il numero delle ristampe e riedizioni di queste opere conferma infatti un successo che può essere valutato anzitutto in termini quantitativi.
La «copiosa parafrasi»
Se il progetto di divulgazione dell’opera aristotelica trova inizialmente nell’adattamento e nel compendio la sua forma privilegiata, è d’altra parte di notevole interesse registrare un significativo cambiamento di rotta nel metodo piccolominiano all’indomani del suo ritiro senese. Nominato arcivescovo di Patrasso e coadiutore del vescovo di Siena, Piccolomini dedica gli ultimi anni della sua vita allo studio della Retorica e della Poetica aristoteliche, pubblicando tra 1565 e 1575 alcuni dei contributi più significativi nell’ambito dell’interpretazione dei due testi che, a partire dalla metà del secolo, erano al centro di dibattiti e discussioni animate tra editori, traduttori ed esegeti (a tal proposito resta indispensabile, anche se in gran parte da ridiscutere, la panoramica offerta da Weinberg 1961).
La Poetica, in particolare, quasi completamente ignota al Medioevo e letteralmente riscoperta nella seconda metà del Quattrocento, è protagonista di una ricezione complessa e non priva di controversie. Il testo, di per sé difficile, non pone solo problemi di interpretazione, ma anche di adattabilità alla teoria e alla prassi poetico-letterarie del Rinascimento. Disponibile in greco a partire dall’editio princeps aldina degli opera omnia di Aristotele, la Poetica viene tradotta in latino e, a partire dalla fine degli anni Quaranta del Cinquecento, in volgare. Sulla lettura della Poetica si giocano la codificazione dei generi letterari cinquecenteschi – basti pensare alle vicende del poema epico tra un Ariosto ancora estraneo alla questione e un Tasso fin troppo cosciente dei problemi suscitati dall’esegesi aristotelica – e la collocazione della letteratura rispetto alle altre forme del sapere. I grandi commenti latini al testo di Aristotele – Francesco Robortello, Vincenzo Maggi, Piero Vettori, per citare i più importanti – si arrovellano sugli aspetti filologici della Poetica e dibattono su temi cruciali della teoria letteraria del tempo, dal diletto al giovamento, dal verisimile al falso e al meraviglioso. È tuttavia con i primi tentativi di tradurre in volgare la Poetica e la Retorica che l’interpretazione dei due trattati viene a influire prepotentemente sulla cultura letteraria del tempo. Bernardo Segni, fiorentino, nell’ambito di un pionieristico progetto di ampio respiro, che include le traduzioni di Etica e Politica, pubblica le prime versioni volgari di Poetica e Retorica nel 1549.
Quando Piccolomini, un decennio più tardi, decide di confrontarsi in modo sistematico con i due testi, può contare su una bibliografia già ricca e, in particolare, sui dettagliati commenti latini. Data la difficoltà dei trattati aristotelici, quello che serve – a suo avviso – non è tanto una traduzione, quanto un’illustrazione del testo. Riproporre, in volgare, le asperità dell’originale aristotelico, infatti, non aiuterebbe la comprensione. Da qui la scelta piccolominiana di affidarsi ad un genere traduttivo diverso, quello della parafrasi che, sul modello del lavoro condotto da Temistio sul De anima, si configura come la forma ideale per rendere effettivamente accessibile un testo antico al lettore moderno. I tre libri della Retorica vedono così la luce tra 1562 e 1569 in forma di «copiosa parafrase», una via di mezzo tra la traduzione propriamente detta ed il commento che – in virtù della possibilità di «allargare» laddove necessario – consente all’interprete una certa flessibilità nel rapporto con la fonte e con la tradizione esegetica precedente. Proprio in questa relazione dinamica con il testo da tradurre risiede la novità metodologica del contributo di Piccolomini alla diffusione in volgare della Retorica. La parafrasi è intesa non solo come occasione per tradurre il testo, ma anche – e soprattutto – per interpretarlo. Solo in seguito, infatti, Piccolomini deciderà di ripubblicare la Retorica in traduzione, rivelando come il suo progetto di divulgazione aristotelica sia basato su un principio di progressivo avvicinamento al testo.
Il senese avrebbe probabilmente utilizzato lo stesso metodo per la Poetica se non fosse stato per la pubblicazione dell’esposizione volgare del trattato aristotelico stampata a Vienna da Ludovico Castelvetro nel 1570, operazione editoriale destinata a suscitare reazioni contrastanti da parte di letterati e studiosi. In disaccordo con molti aspetti della lettura castelvetrina, Piccolomini risponde alla Poetica vulgarizzata et sposta dell’intellettuale modenese in due tempi: nel 1572, contravvenendo alle sue precedenti dichiarazioni, pubblica una traduzione della Poetica, seguita nel 1575 da un commento, le Annotationi, che discute puntualmente ogni singola particella del testo aristotelico. Pur non facendo mai il nome di Castelvetro, Piccolomini lo individua chiaramente come bersaglio critico per eccellenza, alludendo frequentemente a lui come uno degli «spositori in lingua nostra» della Poetica. Se le divergenze dall’interpretazione castelvetrina si misurano soprattutto sul piano dei contenuti – basti, fra tutti, l’esempio del diletto poetico che, considerato da Castelvetro come il fine essenziale della poesia, è inconcepibile, secondo Piccolomini, senza il «giovamento» – quello che preme osservare in questa sede è l’approdo della riflessione piccolominiana sul tema della traduzione in occasione dei suoi più maturi contributi aristotelici.
La traduzione della Poetica è, nell’edizione del 1572, preceduta da una lunga epistola prefatoria ai lettori che si configura, in realtà, come un vero e proprio trattatello sull’arte del tradurre. Dopo aver ricordato l’importanza di scegliere «guide» eccellenti nello studio delle varie discipline – ed è esplicito il riferimento ad Aristotele, maestro incomparabile «nella filosofia naturale et nella morale, et nella dialettica parimente, et nella retorica et nella poetica» (Piccolomini 1572b, [+4]r) – lo studioso spiega che la lettura degli auctores può originare varie forme di scrittura, dalla traduzione al commento, dalle annotazioni alla parafrasi al compendio. Si tratta, chiaramente, di generi che il senese ha variamente frequentato nel corso della sua carriera di studioso, dai compendi degli anni padovani ai manuali di logica e filosofia naturale degli anni romani (Refini 2009, 33-48). Per quanto riguarda, nello specifico, il genere della traduzione, il senese non nasconde le proprie riserve: nonostante alcuni esperimenti giovanili – l’Economico di Senofonte volgarizzato (1540) e la traduzione latina della parafrasi greca di Alessandro di Afrodisia ai Libri meteorologici di Aristotele (1545) – l’esercizio del tradurre resta, agli occhi di Piccolomini, ostico e rischioso, soprattutto nel caso in cui i testi da tradurre siano filosofici o scientifici. La pubblicazione, in tarda età, delle traduzioni della Retorica e della Poetica aristoteliche costituiscono pertanto un’eccezione e necessitano di una giustificazione.
Le difficoltà principali del tradurre
Piccolomini, secondo l’argomentare ordinato e rigoroso che gli è proprio, inizia spiegando quali siano le difficoltà principali proprie dell’attività di tradurre. La prima consiste nella necessità, per chi traduce, di obbligarsi «al mantenimento et al salvamento non solo delle opinioni altrui, ma delle parole ancora» (Piccolomini 1572b, [+4]v), prescrizione che richiama – e cerca di conciliare – i termini tradizionali delle teorie antiche sulla traduzione, il verbum de verbo e l’ad sensum. La seconda difficoltà insita nella traduzione riguarda le competenze linguistiche di chi traduce, al quale non può bastare una conoscenza approfondita della lingua da cui traduce, giacché egli deve essere anche profondo conoscitore della lingua in cui traduce. Quella che sembra a prima vista un’ovvietà viene illustrata da Piccolomini a mezzo di un argomento quasi paradossale: al parafraste e al commentatore – purché abbiano una buona conoscenza della lingua dei testi che commentano (conoscenza che permette loro di capirli) – non è richiesta una particolare dimestichezza nella lingua in cui scrivono, che è invece prerequisito essenziale per il traduttore. Mentre parafrasi e commento, in quanto scritture “nuove” e in un certo senso autonome, rispondono semplicemente alle capacità linguistiche dei rispettivi autori, il traduttore deve avere una conoscenza della lingua d’arrivo tale da poter maneggiare le strutture linguistiche in modo che esse possano rispecchiare opinioni e parole proprie dell’originale. La lingua in cui si traduce deve quindi essere come la cera: deve – in virtù delle capacità di chi la usa – adeguarsi alle esigenze proprie del testo che viene tradotto:
ci fa di mestieri d’esser così minutamente instrutti nella lingua nella qual traduciamo et d’esserne così padroni che, nella guisa che tenendo alquanta di cera in mano, potiamo con le dita maneggiandola trasmutarla, hor’in quadrata, hor’in rotonda, et hor’in piramidal figura, et in qual si voglia altra che più ci aggrada; così parimente sappiamo così ben maneggiare et trattare la detta lingua (Piccolomini 1572b, [+4]v)
La terza difficoltà del tradurre individuata da Piccolomini è il rischio di falsificare il pensiero dell’autore. Ancora una volta è il confronto con il lavoro del commentatore e del parafraste a offrire al senese un paradigma illustrativo: mentre essi parlano in prima persona, ovvero si prendono la responsabilità delle proprie affermazioni – anche quando vi sia un disaccordo rispetto al testo che stanno interpretando – il traduttore non può permettersi di divergere dalla «sententia» dell’autore che sta traducendo. Se lo facesse, il traduttore diverrebbe propriamente un traditore, o – come dice Piccolomini – un «falsario». Un’ultima considerazione che ha lungamente distolto il senese dalla pratica del tradurre è la constatazione che ben pochi tra coloro che hanno tentato di «portar d’una lingua ad una altra materie scientifiche et dottrinali» (Piccolomini 1572b, [+4]v) hanno prodotto risultati degni di nota.
Muovendo da tali premesse, Piccolomini si sofferma su quelle che, a suo avviso, sono le leggi essenziali della traduzione. In primo luogo, e coerentemente con quanto affermato in precedenza, il buon traduttore deve mirare a rendere armoniosamente tanto la «sententia» dell’autore, quanto le sue «parole», il che significa cercare di riproporre nella lingua in cui si traduce la «locutione», le «ligature» e i «modi» propri della lingua da cui si traduce. Le diverse lingue, tuttavia, hanno differenti strutture; ed è proprio al livello delle strutture formali che il traduttore deve saper adattare la lingua d’arrivo ai modi della lingua di partenza. A una parola del testo originale possono dover corrispondere due o più parole nella traduzione; la «testura» deve talvolta essere alterata «con divider i periodi o i membri d’essi, o con unir i divisi, o con qualsivoglia altra maniera d’alteratione o di nuovo intessimento et ordine»: ciò che conta – e la dichiarazione è di notevole interesse – è che l’alterazione della struttura linguistica originale sia esclusivamente determinata dalla «necessità», ovvero dalla «sola proprietà delle lingue» (Piccolomini 1572b, ++[1]r). Chi si è cimentato nella traduzione di cose «a facultà scientifiche appartenenti», afferma Piccolomini, è principalmente incappato in due tipi di errore. Da un lato, coloro che hanno preteso di guardare più alla sentenza che alle parole dell’originale si sono comportati da «spositori o parafrizatori» piuttosto che da veri traduttori (Piccolomini 1572b, ++[1]r). Dall’altro lato, quelli che – non tenendo «la sententia et il sentimento» del testo in giusto peso – sono andati «di parola in parola, et di minima particella in particella cercando di recarne a punto tante quante ve ne truovano» (Piccolomini 1572b, ++[1]v). Così facendo, essi hanno prodotto una «locutione confusa» e «insipida», ovvero un testo inintelligibile. L’eccesso di fedeltà alla lettera dell’originale, causato dall’inconsapevolezza della diversità delle strutture che caratterizza le lingue, unitamente alla volontà di non introdurre «mutation alcuna», genera «barbarismi» (adattamenti forzati di parole straniere) ed «equivocatione» (parole utilizzate con significati diversi da quello corrente). Più in generale, «volendosi far forza alle strutture et ai modi di dire con torgli dalla lingua a cui son proprii et dargli a quella che non gli ha per suoi, si rende la locutione oscura, intrigata et spesse volte falsa» (Piccolomini 1572b, ++[1]v).
Traduzione ed esegesi
Il motivo per cui, individuate tali difficoltà, Piccolomini si è risolto a tradurre la Retorica prima e la Poetica poi è di natura squisitamente contestuale: avendo da molto tempo deciso di dedicare le proprie attenzioni di studioso ai due trattati aristotelici, il filosofo ha rimandato l’impresa in virtù dei numerosi e importanti contributi che altri intellettuali hanno prodotto prima di lui – fra tutti i commenti latini di Vincenzo Maggi e Piero Vettori, pubblicati rispettivamente nel 1550 e nel 1564. Il declino della grande stagione medio-cinquecentesca delle interpretazioni aristoteliche, unitamente all’avanzare degli anni, spingono tuttavia il senese a dare il proprio contributo, almeno per quelle parti del testo che, a suo avviso, restano di difficile comprensione. Proprio per evitare di ripetere ciò che era stato compiuto dai predecessori, Piccolomini pensa alla possibilità di un commento per annotazioni, metodo ideale laddove il commentatore voglia inserirsi nel dialogo già avviato dai precedenti esegeti. Il lavoro sulla Poetica implica tuttavia costanti riferimenti al testo e, dal momento che le annotazioni sono in volgare, i riferimenti al testo non possono che essere essi stessi in volgare – e da qui nasce l’esigenza di tradurre il trattato.
Se è vero che la traduzione piccolominiana nasce come funzionale al commento, è opportuno sottolineare come l’esigenza della traduzione sia anche dovuta alla mancanza di versioni volgari del testo realizzate secondo le regole esposte da Piccolomini. Il riferimento polemico all’opera di Castelvetro, per quanto non esplicito, è facilmente riconoscibile: alcuni traduttori, «allargando o sponendo, o del proprio loro aggiugnendo, fedelissimi non sono stati»; altri, «mentre che le stesse parole ad una ad una et lo stesso ordine et lo stesso connettimento hanno puntualmente mantener voluto», hanno prodotto un testo incomprensibile. Riprendendo le fila di quanto esposto sopra, e distanziandosi dai due estremi appena stigmatizzati, Piccolomini illustra brevemente il metodo seguito nella sua traduzione.
L’indicazione di massima per cui una traduzione deve idealmente conservare tanto la «sententia» quanto la «locutione» del testo originale trova una giustificazione teorica che, ispirata alla teoria linguistica aristotelica e, in particolare, al De interpretatione, affronta la questione spinosa del rapporto tra concetti e parole: i «sentimenti et concetti», spiega Piccolomini, «in tutte le lingue i medesimi intieramente trovare et salvar si possono, et in essi consiste la sostantia degli scritti» (Piccolomini 1572b, ++2v): l’affermazione tocca uno dei temi più dibattuti dai teorici del Rinascimento, ovvero l’idea di un rapporto gerarchico tra le lingue. Secondo Piccolomini, vicino in questo alle affermazioni del collega padovano Sperone Speroni, tutte le lingue hanno la possibilità di esprimere i medesimi concetti: diversamente da quanto sostenuto dai campioni dell’umanesimo latino, e prima ancora dai teorici del volgarizzamento medievale, il senese disconosce l’idea di una priorità della lingua di Cicerone sulle lingue volgari. Così come per bocca dell’aristotelico Pietro Pomponazzi nel Dialogo delle lingue (1542) Sperone Speroni afferma la parità dei mezzi linguistici, Piccolomini condivide l’idea della lingua come strumento convenzionale principalmente volto all’espressione e alla comunicazione dei concetti. Le «parole» sono «trovate […] per li sentimenti, et non questi per quelle»: è questa una presa di posizione che, ben lontana dall’idea platonica di una connessione naturale tra parole e cose, mira a salvaguardare le potenzialità comunicativa di ogni lingua.
Ciò che, tuttavia, distingue il pensiero linguistico di Piccolomini dalle posizioni invero radicali espresse dal Pomponazzi di Sperone Speroni è l’attenzione per l’altra faccia della medaglia: se è vero che i concetti sono la «sostanzia» di un testo, è anche vero che i concetti trovano espressione attraverso la «locutione» che, pertanto, necessita di essere coltivata e curata nel dettaglio. All’idea pomponazziana di una perentoria priorità del contenuto sulla forma (idea che implica una svalutazione degli ideali retorici classicisti), Piccolomini contrappone non tanto la difesa ideologica dell’eloquenza fine a se stessa, quanto l’uso dell’eloquenza come strumento di comunicazione e divulgazione di contenuti filosofico-scientifici. Riprendendo anche in questo caso spunti dalle osservazioni proposte nella prima parte della prefatoria, Piccolomini si sofferma sui vari aspetti della «locutione»: non solo parole, struttura e «legature», ma anche significati, poiché non tutte le lingue hanno «per le medesime significationi parole appropriate» (Piccolomini 1572b, ++2v). Dopo aver ribadito che l’unica regola valida da seguire nell’adattare le strutture di una lingua a quelle di un’altra è la «necessità», ovvero il rispetto della specificità delle proprietà di un determinato idioma, il traduttore si concentra su due esempi emblematici: la mancanza di parole nella lingua in cui si traduce e la differenza nel modo di “legare” le parole stesse.
quando noi non potiamo nella lingua in cui traduciamo trovar parole che a quelle della lingua da cui si traduce rispondino nei significati, non solo una ad una, ma né due o più al significato d’una. O ver quando non potiamo nel tessere, ordinare, et legar le parole insieme, trovar un ordine et una testura tale che possa ben mostrare et scoprir il sentimento (Piccolomini 1572b, ++2v).
Nel primo caso è ammesso intervenire aggiungendo elementi che permettano di illuminare il significato del testo. Le aggiunte, tuttavia, sono ammissibili solamente quando la «sententia» del passo sia indubitabilmente comprensibile in virtù del contesto: se questo non fosse il caso, infatti, gli interventi per aggiunta sarebbero rischiosamente simili a quelli di un parafraste. Coerentemente con un’idea di traduzione che tende a limitare gli interventi del traduttore, Piccolomini spiega anche che le aggiunte – per quanto giustificate dalla «necessità» di rendere il testo intelligibile – devono essere segnalate. A tal fine vengono introdotti i «rampini», ovvero parentesi quadre che le distinguono dalle «stesse parole dello scrittore» (Piccolomini 1572b, ++3r). Quanto alle modifiche che interessano la «testura», ovvero l’ordine del discorso e la struttura dei periodi, il traduttore può intervenire sul testo purché «cosa di nuovo significata non vi si aggiunga»: così facendo, afferma Piccolomini – fiducioso nelle potenzialità espressive delle varie lingue – sarà possibile «aprire in una lingua quello stesso legittimo sentimento che nell’altra si contiene» (Piccolomini 1572b, ++3r).
Come mostrato da una rapida lettura della prefazione alla traduzione della Poetica, l’esperienza di Alessandro Piccolomini, autore di compendi, parafrasi e commenti alle opere di Aristotele, ma anche traduttore e teorico, permette di comprendere meglio il ruolo che, nel pieno Rinascimento, la traduzione assume nel più ampio contesto della ricezione dell’antico. Uno degli strumenti possibili di lettura e appropriazione dei testi classici, la traduzione si configura nella riflessione piccolominiana come esercizio critico di notevole difficoltà, primariamente giocato sulle responsabilità etiche del traduttore: da un lato il rispetto dell’autore, garantito solo dalla corretta comprensione del testo originale; dall’altro il servizio reso al lettore del testo tradotto, un servizio che individua nella figura del traduttore la funzione di vero e proprio mediatore.
Bibliografia
Castelvetro 1570: Ludovico Castelvetro, Poetica d’Aristotele vulgarizzata, et sposta, Vienna, Caspar Staihofer
Cornish 2011: Alison Cornish, Vernacular Translation in Dante’s Italy: Illiterate Literature, Cambridge, Cambridge University Press
Dionisotti 1967: Carlo Dionisotti, Tradizione classica e volgarizzamenti, in Id., Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 103-144
Folena 1991: Gianfranco Folena, Volgarizzare e tradurre, Torino, Einaudi
Gentili 2005: Sonia Gentili, L’uomo aristotelico alle origini della letteratura italiana, Roma, Carocci
Marchesi 1904: Concetto Marchesi, L’Etica Nicomachea nella tradizione latina medievale, Messina, Trimarchi
Piccolomini 1540: Alessandro Piccolomini, Della sfera… Delle stelle fisse, Venezia, Andrea Arrivabene
Piccolomini 1542: Alessandro Piccolomini,De la institutione di tutta la vita de l’huomo nato nobile e in città libera libri X in lingua toscana. Dove e peripateticamente e platonicamente, intorno a le cose de l’ethica, iconomica e parte de la politica, è raccolta la somma di quanto principalmente può concorrere a la perfetta e felice vita di quello, Venezia, Girolamo Scoto
Piccolomini 1551a: Alessandro Piccolomini, L’instrumento de la filosofia, Roma, Vincenzo Valgrisi
Piccolomini 1551b: Alessandro Piccolomini, La prima parte della filosofia naturale, Roma, Vincenzo Valgrisi
Piccolomini 1554: Alessandro Piccolomini, La seconda parte de la filosofia naturale, Venezia, Vincenzo Valgrisi
Piccolomini 1565: Alessandro Piccolomini, Copiosissima parafrase: nel primo libro della Retorica d’Aristotele, Venezia, Giovanni Guarisco
Piccolomini 1569: Alessandro Piccolomini, Piena et larga parafrase: nel secondo libro della Retorica d’Aristotele a Theodette,Venezia, Giovan Francesco Camozio
Piccolomini 1571: Alessandro Piccolomini, I tre libri della Retorica d’Aristotele a Theodette tradotti in lingua volgare, Venezia, Francesco de’ Franceschi
Piccolomini 1572a: Alessandro Piccolomini, Piena et larga parafrase nel terzo libro della Retorica d’Aristotele a Theodette, Venezia, Giovanni Guarisco
Piccolomini 1572b: Alessandro Piccolomini, Il libro della Poetica. Tradotto di greca lingua in volgare, Siena, Luca Bonetti
Piccolomini 1575: Alessandro Piccolomini, Annotationi nel libro della Poetica; con la traduttione del medesimo libro, in lingua volgare, Venezia, Giovanni Guarisco
Refini 2009: Eugenio Refini, Per via d’annotationi: le glosse inedite di Alessandro Piccolomini all’Ars poetica di Orazio, Lucca, Pacini Fazzi
Refini 2013: Eugenio Refini, Aristotile in parlare materno: Vernacular readings of the Ethics in the Quattrocento, in «I Tatti Studies», 16, 1/2, 311-341.
Segni 1549: Bernardo Segni, Rettorica, et poetica d’Aristotile tradotte di greco in lingua vulgare fiorentina, Firenze, Lorenzo Torrentino
Weinberg 1961: Bernard Weinberg, A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance, Chicago, Chicago University Press