di Daniele Petruccioli
A proposito di: Enrico Terrinoni, Oltre abita il silenzio. Tradurre la letteratura, Milano, Il Saggiatore, 2019, pp. 220, € 24,00
La poesia non è di chi la scrive, è di chi gli serve
Massimo Troisi in Il postino, 1994
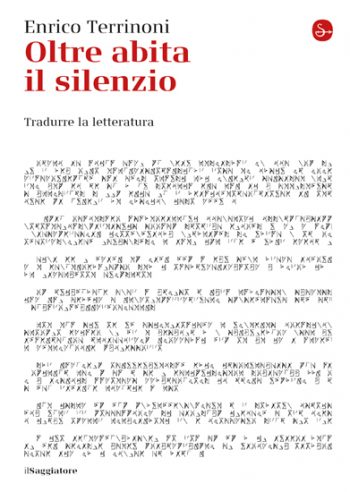 La frase in esergo, tratta dal film di Michael Radford con Troisi e Philippe Noiret, si legge a pagina 127 di questo libro, all’inizio di un ragionamento sulla tensione fra autore e lettore, che partendo dalla teoria della ricezione di Wolfgang Iser e dal pragmatismo americano torna poi su un argomento già dibattuto in precedenza, e su cui torneremo anche in queste righe: quello della sopravvivenza (in senso benjaminiano) delle opere nel tempo.
La frase in esergo, tratta dal film di Michael Radford con Troisi e Philippe Noiret, si legge a pagina 127 di questo libro, all’inizio di un ragionamento sulla tensione fra autore e lettore, che partendo dalla teoria della ricezione di Wolfgang Iser e dal pragmatismo americano torna poi su un argomento già dibattuto in precedenza, e su cui torneremo anche in queste righe: quello della sopravvivenza (in senso benjaminiano) delle opere nel tempo.
Vorrei partire da qui per due motivi. Il primo è che il saggio di Terrinoni si pone completamente (e coraggiosamente) fuori da ogni schema di saggistica espositiva ed esegetica. Il suo è un saggio ondulato, oscillatorio, di andate e ritorni e soprattutto di continue antitesi (torneremo anche su questo): un libro hegeliano nel senso alto del termine, ma che si sottrae, almeno in apparenza, a qualunque sintesi, che viene coerentemente lasciata nelle mani del lettore. Per questo motivo, è il testo stesso a legittimare chi lo legge (e di conseguenza anche questo recensore) a partire da dove vuole lui. Il secondo motivo per cui ho voluto cominciare dalla battuta di Troisi è che, a mio avviso, in questo saggio il concetto di interpretazione, oltre a essere centrale – il che ovviamente non stupisce –, non si riesce a scindere dal concetto di esistenza del testo e dell’individuo, dell’autore e del lettore (e a maggior ragione del traduttore, inutile dirlo), e dunque informa di sé innanzitutto l’azione di uomini e opere (di uomini come opere?) nel tempo.
E dunque, partiamo dalla poesia. Ovverosia dalla forma. Il libro di Terrinoni non è un manuale anche se è un libro coltissimo, che non prescinde da nessun pensiero sulla traduzione, non solo contemporaneo ma anche, come dire, rinascimentale. Non è un libro a tesi anche se una tesi ce l’ha, e molto chiaramente (d)enunciata, ma tale da coinvolgere il nostro stesso esistere, anzi la nostra stessa genetica, come specie. Non è nemmeno un libro evocativo, poetico o rimembrante, anche se è pieno di evocazioni ed esperienze personali, scaturite da un personalissimo concetto di poesia – perché ogni sua riga è strutturata seguendo le regole del ragionamento dialettico.
Che cos’è, allora, Oltre abita il silenzio? È innanzitutto una sfida, un pungolo al lettore perché, pur partendo ovviamente dalle premesse dell’autore, scopra le sue verità, o meglio dia luce ai propri dubbi e ambivalenze. Si tratta di un libro fiume, un saggio antisistematico, cannibale nel senso che il modernista brasiliano Oswald de Andrade dava a questo termine nel suo Manifesto antropófago del 1928, in cui rivendicava il diritto postcoloniale all’appropriazione di ogni fatto culturale anche lontano, per trapiantarlo in un contesto ibrido, in un contesto nuovo. E questo, nel libro di Terrinoni, è manifesto perfino nella bibliografia, che oltre a saggi e romanzi vede inclusi film, canzoni, opere teatrali, e addirittura la tomba di John Keats al cimitero acattolico di Roma.
Certo, questo comporta un rischio evidente: quello che il lettore – stanco di perdersi in tutti questi anda e rianda, stufo di vedersi continuamente spinto dall’autore a metterci del suo, a colmare spazi concettuali volutamente lasciati in bianco, esasperato dal continuo interrompere i ragionamenti proprio sul più bello per riprenderli poi quando si stava (apparentemente) parlando di tutt’altro – che il lettore, dunque, stanco, stufo ed esasperato dalla presunta pigrizia di questo autore che lo vuole far lavorare così tanto, si senta semplicemente preso in giro e chiuda il libro sbuffando. Ma anche la possibilità di una reazione del genere fa parte (integrante, vorrei dire programmatica) di questo libro. Un libro che conta proprio sulla nostra capacità di seguirlo, di riempirlo, di perpetuarne il discorso, un discorso che senza di noi non si dà. O meglio non si vuole dare.
È un libro, questo, che partendo da sé ma portando (solo apparentemente in modo paradossale) alle estreme conseguenze la volontà di eludere ogni pericolo di autoreferenzialità, sa correre il pericolo di non esistere senza il suo lettore. E dunque il lettore lo incita, lo provoca, gli toglie il terreno sotto i piedi.
Siamo dunque di fronte, per così dire, a un saggio shapesphereiano, che non ha paura della sua cangianza, e perciò stesso dà shape alla sphere della nostra fear di non essere all’altezza. A pensarci bene, questa potrebbe anche rivelarsi una buona definizione di traduzione. Ma questo sarà forse uno dei punti di arrivo. Per adesso limitiamoci a cogliere la domanda che questa forma della nostra paura di non essere all’altezza ci pone. Paura di non essere all’altezza di che cosa? È proprio questo il punto.
Le premesse sono, l’abbiamo detto, rinascimentali, da John Florio (l’umanista angloitaliano, o italobritannico, amico di Giordano Bruno e autore del dizionario italiano A World of Words, nonché traduttore di Montaigne in inglese) a Bruno, appunto (non a caso due numi tutelari anche per James Joyce, che sappiamo bene quanta parte abbia nella formazione e nella pratica traduttiva di Terrinoni), dunque da caos e inventio per antonomasia. Caos e inventio: è da qui che si parte, o meglio è di questo che si permea tutto il libro. Ma si tratta di «draghetti» (p. 165), volti a “draghettarci”, seguendone il filo d’Arianna, verso qualcos’altro.
Un qualcos’altro che sembra paradossalmente allontanarsi ancora di più dal terreno della concretezza, perché da subito (p. 16) l’autore si pone il problema della nostra trascendenza (di noi come del testo: «la libertà del letterario è la libertà di uscire dalla cornice per farsi cercare oltre e per cercare oltre», p.30). O meglio della nostra “sopravvivenza”, per usare la parola in cui Renato Solmi, nella sua traduzione del Compito del traduttore di Walter Benjamin per l’edizione Einaudi di Angelus Novus (Torino 1962), comprende sia l’Überleben sia il Fortleben dell’originale. Ma appunto, stiamo parlando di Benjamin, dunque ogni sopravvivenza non può che essere immanente, anzi, più precisamente, storica.
Terrinoni però si spinge anche più in là, fino ad affermare che la nostra immanenza nel mondo dipende dalle storie che sanno raccontare gli altri a partire da noi (p. 96). Anche la critica non è che narrazione, e dunque non può, non deve avere pretese e nemmeno «speranze di verificabilità» (p.55). Il che si può anche dire (e lui lo fa), sempre seguendo Benjamin, che il perdurare di un’opera nell’immanenza del mondo dipende dalla sua capacità di essere interpretata, e dunque tradotta, il più ampiamente possibile. A noi la scelta su quale sia il modo più elegante, più bello di dirlo (nel senso dell’eleganza di una teoria sull’universo, o della maggior bellezza di una delle possibili soluzioni di un’equazione rispetto alle altre, per quanto corrette).
Se questo è vero, allora bisogna anche affrontare la vertigine della pericolosità del dire, del dirsi, cioè l’irruzione, nell’interpretazione, dell’immaginario personale del traduttore. Ovverosia, la vertigine della liceità e dei limiti dell’interpretazione, a cui viene dedicato l’intero terzo capitolo, ma che serpeggia anch’essa come uno dei leitmotiv di tutto il saggio. Se per Terrinoni «è solo in linea di principio che ogni interpretazione giustificabile può esser ritenuta valida» (p. 93), un’analisi stilistica basata semplicemente sui caratteri linguistici e retorici (al limite: sui morfemi, p. 157) si rivela arida e «irritante» (p. 158) quando non tenga conto dello stile come della corrente veramente vitale di ogni testo, al pari del sistema cardiovascolare in un organismo (p. 164). Allora, anche qui, l’andamento, ancora una volta duplice, deve per forza basarsi su una sorta di fondamentale buonsenso («Una semplice regola di buona convivenza vorrebbe che non bisogna fare agli altri quel che non vorremmo fosse fatto a noi», p. 93). Di nuovo, non ci sono ricette né regole precostituite a cui potersi rifare. Resta soltanto il solito filo di Arianna, che in questo caso pretende si parta dal testo, anziché da noi, ma senza impedire al testo di attraversarci, uscendone così, in qualche modo, trasmutato. Del resto, quando cambiamo la lingua di qualcosa (quindi quando traduciamo; ma è così anche quando ne cambiamo il linguaggio, ovverosia quando ripensiamo, quando ridiciamo un concetto altrui), non cambiamo forse i mattoni, la struttura di quello stesso qualcosa?
Questo pendulum dell’interpretazione, questo andare e tornare fra il testo e noi stessi (perché traducendo il testo possiamo dargli in qualche modo il potere di tradurci), richiama naturalmente il vichiano eterno ritorno. Seguendo quest’ulteriore filo d’Arianna, l’interpretazione sarebbe una riscrittura «con la fantasia dell’ingegno, che coincide con il ricordare» (p. 108). Ciò non vuol dire affatto ripudiare scienze testuali come la filologia o l’ermeneutica (che restano comunque scienze dialogiche), ma senza ancorarsi troppo a un «fantomatico rimescolio di proponimenti che ha presumibilmente avuto luogo nella testa dell’autore, soprattutto perché è virtualmente impossibile ricomporne il mosaico» e riconoscendo che, «con la testualità letteraria, che fa dell’ambiguità la sua ragion d’essere, bisogna accettare il semplice assunto secondo cui l’unico arbitro affidabile sarà colui che si dimostrerà convincente nell’argomentazione», pur con l’orientamento costante della bussola per cui «è dall’esistenza stessa di quel mosaico […] che si deve partire». «L’importante è sempre partire dal testo» (p. 142).
E allora, cosa rimane? Rimane, e qui si torna a Bruno, la consapevolezza dell’infinito, che certo può aprire la vertigine del vuoto, ma senza il quale si rischia di essere condannati a ridursi a una filologia arida ed enumerativa; ma rimane anche, e qui rispunta Florio, la consapevolezza che ogni vuoto è lì per essere riempito, con l’inventio che è la nostra fantasia non sfrenata, ma ben ancorata ai «draghetti» della poesia (o, se si preferisce, dello stile) del testo, pur con tutti i limiti della nostra capacità di lettura. Con grande fiducia nel seguente auspicio:
Se la traduzione è questo, se realmente consente di potenziare la nostra capacità percettiva attraverso l’associazione per logica o l’affinità tra idee distanti, allora siamo al cospetto di un potere enorme: quello di ricreare, extra-dicendolo, il mondo. E dunque di non concentrarci sempre e solo sulla meravigliosa caducità del fiore reciso, per guardare invece alla radice della nuova pianta, che, se in fiore, porterà probabilmente a nuovi frutti (p. 149).
E con l’ammonimento implicito che, se questo rischio – il rischio della possibilità della fantasia – non lo si accetta, allora meglio avere l’onestà di abdicare a favore di Google Translate: dal punto di vista della memoria terminologica, sta sicuramente messo meglio lui.