GLI ATTI DI UN CONVEGNO SU GIULIO EINAUDI E L’EDITORIA DI CULTURA
di Gianfranco Petrillo
A proposito di: Giulio Einaudi nell’editoria di cultura del Novecento italiano, a cura di Paolo Soddu, Fondazione Luigi Einaudi – Studi 52, Leo S. Olschki editore, Firenze 2015.
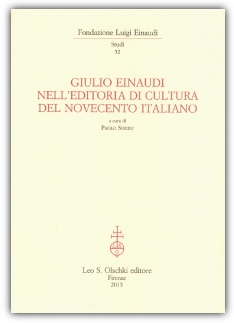 Non ci si aspetti da questa raccolta di atti del convegno torinese dell’ottobre 2012 una gran luce che illumini la persona di Giulio Einaudi. La quale fondamentalmente enigmatica e sfuggente era e tale rimane, pur dopo la biografia dettatane successivamente da Gian Carlo Ferretti per il Dizionario biografico degli italiani. Forse il ritratto più umano e credibile resta quello che emerge dalle pagine di I migliori anni della nostra vita di Ernesto Ferrero. Ma convegno e volume mantengono pienamente la promessa del titolo. Un’idea abbastanza chiara di che cosa è (stata) “l’editoria di cultura” in Italia e di come Einaudi l’abbia interpretata ce la si fa, leggendo con la dovuta attenzione (e forse un po’ di malizia) i numerosi interventi: l’editoria di cultura è quella che non bada ai conti. O per lo meno – per essere meno bruschi – che non bada all’esposizione debitoria (ovvero, come non si stancava di ripetere papà Luigi, al giusto rapporto tra esposizione e mezzi propri). E che implicitamente pretende che non ci badino nemmeno i collaboratori.
Non ci si aspetti da questa raccolta di atti del convegno torinese dell’ottobre 2012 una gran luce che illumini la persona di Giulio Einaudi. La quale fondamentalmente enigmatica e sfuggente era e tale rimane, pur dopo la biografia dettatane successivamente da Gian Carlo Ferretti per il Dizionario biografico degli italiani. Forse il ritratto più umano e credibile resta quello che emerge dalle pagine di I migliori anni della nostra vita di Ernesto Ferrero. Ma convegno e volume mantengono pienamente la promessa del titolo. Un’idea abbastanza chiara di che cosa è (stata) “l’editoria di cultura” in Italia e di come Einaudi l’abbia interpretata ce la si fa, leggendo con la dovuta attenzione (e forse un po’ di malizia) i numerosi interventi: l’editoria di cultura è quella che non bada ai conti. O per lo meno – per essere meno bruschi – che non bada all’esposizione debitoria (ovvero, come non si stancava di ripetere papà Luigi, al giusto rapporto tra esposizione e mezzi propri). E che implicitamente pretende che non ci badino nemmeno i collaboratori.
La casa editrice Einaudi è sempre stata sommersa dai debiti, ma è riuscita sempre a cavarsela, soprattutto grazie a tempestivi aiuti esterni, ma anche allo sfruttamento del meraviglioso catalogo. Illuminanti su ciò sono i due bei saggi di Francesca Gaido e Francesca Pino (Il sostegno ininterrotto di Raffaele Mattioli alla casa editrice Einaudi, pp. 189-218) e di Vittore Armanni (L’accordo commerciale Einaudi-Mondadori: egemonia o mercato?, pp. 247-260). I nodi sono venuti al pettine – osserviamo noi – solo quando è scomparsa definitivamente la generazione dei Luigi Einaudi e dei Raffaele Mattioli, i quali – esperti di finanza – intendevano la casa editrice proprio come la definisce Gian Carlo Ferretti (L’editoria libraria tra sperimentazione e mercato, pp. 69-76): «azienda produttiva e laboratorio culturale insieme»; e per questo potevano impegnare le proprie risorse e il proprio prestigio a tenere in vita una macchina senza la quale la cultura italiana sarebbe stata infinitamente più povera. Quanto a Giulio, lui, credo che vivere e lavorare costantemente con l’acqua alla gola in fatto di finanze fosse non solo scontato, ma addirittura la condizione indispensabile per essere a posto con la coscienza di uomo libero (e tanto snob). Era così comunemente scontata, questa missione dell’“editore di cultura”, che nel 1954, al momento della trasformazione da ditta individuale in società per azioni (illusoria soluzione suggerita a più riprese da papà e dal mentore di piazza della Scala e durata – come soluzione – l’espace d’un matin), numerosi furono i collaboratori – trattati sempre con grande deferenza e rispetto sul piano intellettuale e sostanzialmente negletti sul piano finanziario – che tramutarono i loro crediti, talvolta anche sostanziosi, in azioni. Che, subito dopo la fine della guerra, l’idea delle vendite rateali porta a porta, in cui si impegnò anche un giovane reduce della guerra partigiana di nome Italo Calvino, costituisse «attestazione di una idea di editoria non sprovvedutamente priva di preoccupazioni economiche», come afferma Vittorio Spinazzola (Il pubblico dell’editoria di cultura, pp. 7-12), temo che sia interpretazione che stravolge il più autentico senso dell’iniziativa, la quale appare piuttosto frutto della missione di un’élite convinta di poter e dover portare la cultura “al popolo”, missione alla quale il conto economico doveva anzi sottostare.
L’impresa di Giulio Einaudi – lo chiarisce perfettamente Paolo Soddu (Introduzione alla vita di Giulio Einaudi, pp. 77-95) – ha «scontato perennemente l’irrisolta questione dei capitali» perché l’editore restò sempre geloso della sua autonomia, con «la piena coscienza di voler aspirare a formare il paese, a imprimergli un segno in accordo coi tempi e con le culture che andavano consolidandosi nell’Italia immersa nell’Europa postbellica». (E qui Soddu, personalmente tutt’altro che sospettabile di nostalgie comuniste, appioppa una sciabolata ai giornalisti faciloni d’oggi: «Erano le condizioni reali dell’Italia che rendevano in quella fase inevitabile un’egemonia, che si dispiegò ed ebbe segno e qualità assai differenti rispetto alla vulgata, divenuta ormai inattaccabile e dogmatico luogo comune, dell’egemonia comunista; egemonia, semmai, dell’antifascismo e del pluralismo». Ma i giornalisti, si sa, libri seri come questo si guardano bene dal leggerli).
In quest’ambito un ruolo decisivo fu l’impegno, nel dopoguerra, alla “sprovincializzazione” della cultura italiana, con una funzione di supplenza rispetto all’arretratezza dell’università (Spinazzola, p. 7; Gabriele Turi, I caratteri originali della casa editrice Einaudi, pp. 99-108). E’ vero che, come puntualizza Irene Piazzoni (Negli anni del regime, pp. 33-68), già Bompiani, nell’ambito della saggistica, aveva tempestivamente indirizzato la sua attenzione «all’attualità internazionale», con puntate feconde come la «Biblioteca di cultura moderna» creata e diretta da Antonio Banfi, nella quale si fece le ossa Remo Cantoni. Ma è innegabile che fin dagli stessi anni trenta Einaudi aveva guardato più alto: non alle ondate di interessi geopolitici contingenti, ma alle grandi correnti di pensiero e di conoscenza che attraversavano l’inquietudine dell’Europa. Questa visione si era fatta nel dopoguerra ancora più ampia: si pensi anche solo alla famosa “collana viola” di Pavese e De Martino. E qui entriamo nel vivo del tema che a noi più preme. La missione einaudiana si nutrì soprattutto di traduzioni. Senza le traduzioni, e quindi senza i traduttori, quella missione non si sarebbe potuta svolgere. Oh sì, lo sanno tutti che in casa Einaudi c’erano fior di traduttori, veri e propri maestri, a cominciare da Leone Ginzburg e Cesare Pavese per giungere a Fernanda Pivano e Natalia Ginzburg e altri soliti noti. Ma qui non stiamo parlando della meravigliosa collana dei «Narratori stranieri tradotti», sulla quale si sofferma Domenico Scarpa (Vigile eleganza: Leone Ginzburg e il progetto di un’editoria democratica, pp. 109-140; ci torneremo). Parliamo dell’ampia produzione saggistica.
Si pensi alla «Biblioteca di cultura scientifica» varata già nel 1938 con due traduzioni. Della grande avventura di percorrere La difficile strada della cultura scientifica in Italia, che partendo da lì culminò nel 1957 nella separazione consensuale da cui nacquero le edizioni di Paolo Boringhieri, parla diffusamente Giulia Boringhieri (pp. 261-272), la quale aveva d’altronde già dato un bel libro in argomento. Mentre Alberto Banfi (Nietzsche, Colli, Foà: l’azzardo di un’edizione critica e di una nuova casa editrice, pp. 273-285) riassume puntualmente la vicenda, nota finora solo agli specialisti, dei rapporti tra Giorgio Colli ed Einaudi riguardo agli scritti di Nietzsche. Quegli scritti furono vittime nel 1958 dell’ostracismo storicista dei consulenti e poi base della fortuna antistoricista della Adelphi, fondata poco dopo dal transfuga Luciano Foà, che accolse subito la proposta di Colli, da lui invano caldeggiata con Einaudi.
Colli grecista e Montinari germanista sono tra i pochissimi traduttori non letterari citati nel libro; ma la vicenda è così clamorosa che anch’essi possono essere annoverati tra i soliti noti, alla stregua dei Ginzburg e dei Pavese. Come lo è Guido Ceronetti, di cui Luca Baranelli, rievocando con passione la meteora Raniero Panzieri (Raniero Panzieri e la casa editrice Einaudi, 1959-1963, pp. 287-298), offre un gustoso cammeo: «nel corso del 1963, prima delle ferie estive, uno sconosciuto cominciò a venire regolarmente nel piccolo ufficio [di Raniero Panzieri e Delia Frigessi]. Costui si comportava come se volesse mantenere l’incognito e la distanza rispetto ai redattori e alle segretarie che lavoravano a quel piano: batteva a macchina in modo instancabile e non s’interrompeva, foss’anche per un cenno di saluto, neppure quando Panzieri compariva. Un giorno Raniero mi chiese se sapevo chi fosse e che cosa facesse. Non seppi rispondergli […] Si trattava di Guido Ceronetti, allora pressoché sconosciuto ai più, il quale stava forse battendo a macchina una delle sue prime traduzioni per Einaudi». Panzieri e Ceronetti nello stesso ufficio: solo un maestro della provocazione come Giulio Einaudi poteva pensare simile accoppiata.
Pochissimi altri sono i traduttori citati, anche a proposito di opere che vengono giustamente indicate come capitali per la «sprovincializzazione» in campo saggistico, come per esempio la storiografia delle «Annales» o molti titoli della «Biblioteca scientifica». Non è il caso di dilungarsi e neppure di cedere alla tentazione di sciorinare le decine di esempi meritevoli di attenzione. La piaga su cui si vuol mettere il dito è la disattenzione di metodo, direi addirittura di principio: si parla della storia di una grande e gloriosa e famosa casa editrice; si richiama più volte l’attenzione sulla sua opera di “sprovincializzazione”, ovviamente frutto di traduzioni; si citano tanti singoli casi, spesso senza fare i nomi; e non ci si pone il dubbio: ma chi ha svolto quest’opera? Come è stata svolta? Qual era la preparazione di queste persone? Come sono state chiamate a raccolta? (Oh si sa, nella maggior parte dei casi si trattava di amici o di amici di amici dei redattori…; ma anche su ciò – ossia su un mondo di relazioni personali che ha letteralmente fatto la cultura italiana – sarebbe il caso di soffermarsi criticamente).
Ovviamente in campo letterario le cose vanno già un po’ meglio. E’ direi obbligata l‘attenzione che Scarpa dedica a Leone Ginzburg nel bel contributo che già abbiamo citato, ma non lo è la cura con cui colloca giustamente le iniziative del cofondatore della casa editrice nel contesto contemporaneo, cioè la consapevolezza, da un lato, di quanto occorresse prendere le distanze da imprese coeve un po’ corrive (benché a loro modo anch’esse meritorie) come quelle di Gian Dàuli e di Giuseppe Antonio Borgese e, dall’altro, dei modelli positivi da tener d’occhio, come le collane fondate e dirette da Franco Antonicelli per Frassinelli e da Alfredo Polledro per la propria Slavia. Quest’ultimo nome consente a Scarpa di aprire una appropriata parentesi circa la straordinaria generazione di slavisti che operò in quegli anni. La digressione colma almeno parzialmente una vistosa lacuna dell’unico (e deludente) contributo al convegno che avesse esplicitamente di mira la traduzione, ossia appunto La slavistica (pp. 343-350), in cui Vittorio Strada, al di là dell’autobiografia, ben poco dice del ruolo fondamentale svolto dalla Einaudi nel settore. Peccato che Scarpa, nell’illustrare i meriti dei «Narratori stranieri tradotti» – aperta nel 1938 dai Dolori del giovane Werther di Alberto Spaini – abbia perso l’occasione di osservare che su quelle meravigliose copertine azzurre compariva, immediatamente sotto il titolo, il nome del traduttore o della traduttrice: un’iniziativa di cui da qualche tempo oggi si fregiano, come di un originale atto di generosità e coraggio, un paio di case editrici “minori” (e che le “maggiori”, compresa l’Einaudi attuale, si guardano bene dal praticare). D’altronde nell’Ottocento, quando si aveva la consapevolezza che la traduzione era altra cosa rispetto all’originale, mettere il nome del traduttore in copertina era prassi normale. E comunque già nel 1931, nell’introdurre La donna di picche per la Slavia, il futuro creatore della collana, Ginzburg, aveva collocato in epigrafe questa stimolante asserzione di Puškin: «I traduttori sono i cavalli di ricambio della cultura».
Completano il volume tre saggi che si raccomandano soprattutto per eleganza e ironia: di Edoardo Esposito su Letteratura e riviste dopo la liberazione (pp. 219-232); di Ernesto Ferrero su L’altro Giulio: Bollati e “lo struzzo” (pp. 299-308), un altro magistrale ritratto; e del compianto Enrico Castelnuovo su La storia dell’arte (pp. 335-342), in cui si ricorda – tra l’altro – che Mondadori aveva già pubblicato nel 1952 Il mondo dell’arte di Ernst Gombrich, ma «anche se era stato tradotto da Maria Luisa Spaziani non credo avesse avuto molto successo». Occorreva che lo ripubblicasse Einaudi nel 1966 (ma con il titolo aderente al’originale e con il nome di Livia Moscone Bargilli affiancato a quello di Spaziani) perché diventasse un vero best seller.
La gloriosa casa editrice Olschki può vantare un’altra perla aggiunta alle sue già numerose, ed è con infinito rammarico che ci corre l’obbligo di denunciare il numero davvero eccessivo di refusi che la macchiano.