IL SUBCONTINENTE INDIANO NELLA STORIA DEL MONDO MODERNO CAMBRIDGE-GARZANTI
di Massimiliano Vaghi
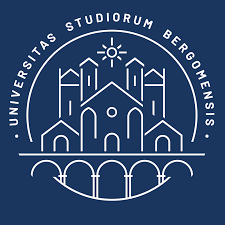 La casa editrice Garzanti è la continuatrice della milanese Fratelli Treves, fondata nel 1879 dai fratelli Emilio e Guido Treves e rilevata nel 1938 dall’industriale forlivese Aldo Garzanti (1888-1961).
La casa editrice Garzanti è la continuatrice della milanese Fratelli Treves, fondata nel 1879 dai fratelli Emilio e Guido Treves e rilevata nel 1938 dall’industriale forlivese Aldo Garzanti (1888-1961).
L’inizio dell’attività editoriale di Aldo Garzanti coincise proprio con l’acquisto della Treves: egli continuò le iniziative della casa editrice milanese, tra le quali la pubblicazione dell’Illustrazione Italiana, fino al 1962, e ne promosse di nuove, come le collane «Vesta», «Il milione», «Classici della letteratura». Nel 1952 si ritirò dalla direzione della sua casa editrice, rimanendone però presidente. Alla sua morte la guida dell’azienda fu assunta in toto dal figlio Livio.
Nella seconda metà del Novecento, Livio Garzanti (1921-2015) fu uno tra i protagonisti dell’editoria italiana: dalla fine degli anni Cinquanta portò la Garzanti a rinnovarsi e a conquistare una posizione di primo piano nella cultura in Italia, con un’attenzione non trascurabile anche per le opere storiche e le traduzioni, sia di letteratura, sia di saggistica.
La fama e la fortuna della Garzanti, dunque, non sono legate soltanto alla letteratura in senso stretto (in proposito si pensi, ad esempio, per ciò che concerne il settore delle «grandi opere», alla Storia della letteratura italiana di Emilio Cecchi e Natalino Sapegno): ci fu una stagione, dalla metà degli anni Sessanta, in cui Livio Garzanti seppe imprimere uno sviluppo crescente anche alle pubblicazioni scolastiche e generaliste, come l’Enciclopedia Garzanti, che alimentò una fiorente rete di vendita porta-a-porta, e le Garzantine, piccole enciclopedie tematiche, volute in prima persona dell’editore. Si ricordi altresì – sempre per quanto concerne le «grandi opere» – la bella Storia del pensiero filosofico di Ludovico Geymonat e, per quello che qui ci riguarda più direttamente, le imponenti e importanti coedizioni con l’università di Cambridge: le tre serie della «Storia del mondo antico», della «Storia del mondo medievale» e della «Storia del mondo moderno».
Garzanti e The New Cambridge Modern History
Tra le grandi opere di sintesi della storia mondiale, apparse per iniziativa delle varie scuole storiografiche europee nella seconda metà del Novecento, la Storia del mondo moderno Cambridge-Garzanti rappresenta certamente uno dei lavori più significativi. Tradotta in dodici volumi fra il 1967 ed il 1972, essa costituisce l’edizione italiana di The New Cambridge Modern History, apparsa per la Cambridge University Press fra il 1957 ed il 1968 (il vol. XIII, Companion, uscito nel 1979, invece, non venne mai tradotto, così come il XIV, Atlas, del 1970).
L’opera – per citare le parole usate nel 1967 dall’editore nella sua premessa italiana – «continua la tradizione», ma, allo stesso tempo, si propone di sostituire e, in qualche modo, superare la precedente ed editorialmente fortunata – ma mai tradotta in italiano – The Cambridge Modern History, pubblicata sotto l’egida di lord Acton fra il 1902 ed il 1912 (in 13 volumi) in piena epoca coloniale: un’opera nella quale è ricostruita, in gran parte a cura di storici inglesi, la storia mondiale nell’ottica dell’espansione del mondo occidentale e dunque in chiave marcatamente eurocentrica.
La storiografia coloniale inglese nasce e si sviluppa a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, in concomitanza con l’apparire dei primi studi di orientalistica, legati ai crescenti interessi britannici in India dopo il successo ottenuto sui rivali politici e commerciali francesi e con la conseguente trasformazione dell’East India Company in potenza territoriale nel subcontinente. Le opere storiografiche di asiatistica pubblicate nel periodo coloniale presentano generalmente le società dell’Asia come statiche e immutabili nel tempo, e l’attenzione è concentrata sull’elemento di novità portato dalla penetrazione europea, ignorando quasi totalmente le tensioni politiche ed i profondi mutamenti socio-economici che, fra Sette e Ottocento, toccarono le popolazioni e le élites asiatiche. La storia dell’Asia meridionale, in particolare, è descritta come una storia di civiltà «senza tempo», in quanto sempre «uguali a se stesse», mentre la modernità è identificata ed associata allo «sviluppo continuo» occidentale, in una proiezione extraeuropea della storia vissuta e scritta nel Vecchio Continente. Nella premessa della vecchia Cambridge Modern History, infatti, i curatori affermano che
by a universal Modern History we mean something distinct from the combined History of all countries – in other words, we mean a narrative which is not a mere string of episodes, but displays a continuous development. It moves in a succession to which the nations are subsidiary. Their stories will accordingly be told here, not for their own sakes, but in reference and subordination to a higher process, and according to the time and the degree in which they influence the common fortunes of mankind (CMH 1902-1912, vol. I, V).
Ossia:
per storia moderna universale intendiamo cosa diversa dalla combinazione della storia di tutti i paesi; intendiamo, cioè, una narrazione che non sia una semplice sfilza di episodi, ma mostri uno sviluppo continuo. Essa si muove in una successione rispetto alla quale le nazioni sono sussidiarie. La storia di ciascuna di esse vi sarà, di conseguenza, narrata non di per sé, ma in riferimento e in subordine a un processo più elevato e secondo i tempi e la misura in cui esse influiscono sulle comuni sorti dell’umanità (traduzione mia).
In questa sede, confrontando la New e la vecchia Cambridge Modern History cercherò di mettere in luce alcuni esempi del rapporto fra la produzione storiografica del secolo scorso e i preconcetti orientalistici – ovvero fortemente eurocentrici e finanche razzisti – sul subcontinente indiano.
Seguendo un’interessante impostazione proposta anni orsono da Giorgio Borsa, e a mio avviso ancora valida nonostante il tempo trascorso (Borsa 1977, 1617-1679), la storiografia dedicata al subcontinente indiano – e, più in generale, tutta quella dedicata a tutta l’Asia – può essere essenzialmente suddivisa in tre filoni principali: una storiografia coloniale (principalmente, ma non esclusivamente, inglese; mi limito qui a citare l’opera «madre» di questa corrente storiografica, l’influente History of British India di James Mill, la cui prima edizione risale al 1817), una storiografia nazionalista – spesso di scuola marxista o, a partire dagli anni novanta del secolo scorso, post-marxista– e, infine, un’idea di storiografia che Borsa chiama «copernicana», caratterizzata cioè dall’assenza sia dei preconcetti di stampo eurocentrico tipici della storiografia coloniale otto-novecentesca, sia di quelli Asia-centrici, fatti propri da molti storici soi-disant nazionalisti, attivi in particolare dopo la raggiunta indipendenza di India e Pakistan, e che oggi possono leggersi in parte dei cosiddetti postcolonial studies, i cui autori spesso provengono da un ripensamento critico del marxismo. Questa storiografia copernicana realizza una sorta di sintesi fra le due prime esperienze, inserendo in una prospettiva più ampia ed interconnessa il ruolo giocato dall’Europa e dall’Asia nella formazione del mondo moderno; in questo senso la Storia del mondo moderno Cambridge-Garzanti è certamente una delle prime opere disponibili al grande pubblico, in italiano, che adotta – pur senza citarlo direttamente – questo nuovo approccio storiografico.
India britannica, resistenze indiane e «orientalismo»
Nella letteratura storica del Novecento, fra le opere fondamentali che possono essere prese come esempi significativi del mutare della percezione del rapporto Europa-India (e più in generale Europa-Asia) durante il secolo, dobbiamo certamente considerare sia The Cambridge Modern History, chiaro esempio della cosiddetta storiografia coloniale, sia The New Cambridge Modern History, portatrice di una visione decisamente più «copernicana» – per usare la categoria concettuale elaborata da Borsa.
Tale visione è fatta propria anche dall’edizione italiana della Garzanti e la piena convergenza d’intenti fra l’editore britannico e quello italiano permette, a mio avviso, di poter utilizzare tranquillamente l’una per l’altra la versione italiana e quella inglese, senza che si generino significativi fraintendimenti rispetto all’interpretazione dei fatti proposta. Si tratta, insomma, di una traduzione che rispetta – e nella sostanza condivide – l’impostazione teorica dei curatori e degli autori di Cambridge. L’editore italiano della New Cambridge sottolinea nella sua premessa che
gli storici britannici hanno cercato il senso profondo dell’evoluzione storica nei vari periodi, nell’apporto dato dai diversi popoli al progredire della civiltà moderna. Protagonisti di questa affascinante trama lungo il corso dei secoli non sono […] gli individui, ma piuttosto le singole comunità, quei nuclei cioè caratterizzati da comuni interessi e comuni tendenze (Garzanti 1967-1972, vol. I, VII).
E proprio grazie all’attenzione data a tutti gli individui – e quindi ai popoli, e non solo ai «grandi uomini» – «nell’evoluzione storica» che, nella nuova Cambridge, si realizza «uno spirito democratico che porta […] a integrare alla storia del mondo occidentale quella delle altre parti del mondo e a considerare senza pregiudizi tutte le manifestazioni di civiltà in quanto ugualmente responsabili di un processo di elevazione della società umana» (Garzanti 1967-1972, vol. I, IX).
Un’attenzione al «globale» ugualmente sottolineata – con un richiamo all’importanza delle dinamiche dell’economia mondiale – da Giampiero Carocci nella sua Presentazione ai lettori italiani del vol. XI (il volume in cui viene trattata l’India britannica nel pieno dell’epoca coloniale): nella nuova Cambridge, dunque, oltre a una doverosa attenzione posta al contesto internazionale anche extraeuropeo, troviamo l’esempio di una storiografia che
ha recepito, a differenza di quella idealistica italiana, gli apporti della storia economica e che sa valutare tutta l’importanza del progresso economico […]. Il criterio della globalità si manifesta con forza nell’introduzione di Hinsley [il curatore del volume XI], che non è solo uno dei migliori saggi del volume ma ne costituisce anche la chiave di volta. Come il lettore vedrà, Hinsley riprende molte delle osservazioni fatte dagli altri collaboratori; ma, lungi dal farne un riassunto descrittivo ed esterno, vi immette una attenzione ferma e costante per i caratteri e i valori dei singoli fenomeni (Garzanti 1967-1972, vol. XI, XII-XIII).
Al contrario, nella vecchia Cambridge Modern History – che dedica anch’essa un certo spazio all’impero indiano nella seconda metà dell’Ottocento, in particolare nei volumi XI e XII – è proposta una visione marcatamente eurocentrica riscontrabile già dalla periodizzazione utilizzata: la modernità, in India, inizia con l’arrivo dei primi europei, i portoghesi, e si perfeziona con le riforme amministrative imposte dal raj (ossia l’impero) britannico nel subcontinente. In proposito Borsa (1977), prendendo spunto da quanto dichiarato nel 1963 da alcuni autori della vecchia Cambridge, sottolinea come essi fossero in tutto e per tutto uomini del loro tempo che agivano secondo le istruzioni del direttore dell’opera, ovvero con l’obiettivo di concentrare l’attenzione su quanto gli inglesi avevano compiuto in India in termini di modernizzazione, documentando nella sostanza i «successi» del colonialismo britannico. Lo scopo, insomma, doveva essere quello di dimostrare che l’East India Company, prima, e il governo britannico, poi, operarono con il preciso scopo di «civilizzare» le leggi e i costumi indiani, e di sostituire la «corrotta» amministrazione mogol, facendosi promotori di politiche socialmente ed economicamente avanzate.
A questo proposito William Lee-Warner (1846-1914), già amministratore coloniale nell’Indian Civil Service e autore del capitolo India and Afghanistan, 1815-69 della vecchia CMH, scrisse che in India
the Government was turning the world upside down, opening the schools to children of all castes, abolishing Sati and slavery, making Brahman and Sudra amenable to the same laws […], with its telegraphs, railways and hospitals […]. The East, which had hitherto bowed low before the West “in patient deep disdain”, now resented the inexorable march of civilisation (CMH, vol. XI, 745).
Cioè:
il governo capovolgeva il mondo: apriva le scuole ai bambini di tutte le caste, aboliva il sati [il sacrificio rituale della vedova sulla pira funebre del marito defunto], rendeva bramani [la prima casta degli indù] e shudra [la quarta e ultima casta nel sistema castale indiano] soggetti alle medesime leggi […] e poi il telegrafo, le ferrovie, gli ospedali […] Ora l’Oriente, che fino ad allora si inchinava all’Occidente «in paziente, profondo disdegno», avvertiva l’inesorabile marcia della civiltà (traduzione mia).
In questa ricostruzione colonialista ed eurocentrica, quindi, l’economia indiana – messa in crisi dall’anarchia regnante nel subcontinente durante il XIX secolo – grazie al saggio intervento inglese beneficiò di una straordinaria crescita, favorendo così l’innalzamento del livello di vita della popolazione in ragione dello sviluppo delle tecniche di irrigazione, dei miglioramenti agricoli, della disponibilità di credito cooperativo e della realizzazione di una moderna rete ferroviaria; elementi che insieme contribuirono a creare un’India nella quale la ricchezza era più diffusa di quanto non fosse stata da molti secoli, e permisero l’avvio di una politica di lotta contro la fame, encomiasticamente presentata come un successo (ma la realtà fu ben diversa e le carestie non diminuirono per nulla).
Lo stesso partito del Congresso indiano (l’Indian National Congress, fondato nel 1885, è il più antico partito politico indiano; vi hanno militato tutti i più importanti leader nazionalisti indiani, come ad esempio Bal Gangadhar Tilak, Gopal Krishna Gokhale, e i celeberrimi Gandhi e Nehru) può, in ultima analisi, essere considerato un frutto della presenza e della «civilizzazione» britannica, dato che le popolazioni dell’Asia meridionale hanno certamente creato «grandi civiltà», ma tradizionalmente la loro organizzazione politica ha raramente superato la comunità «primitiva» del villaggio, un vero e proprio topos della storiografia imperiale e colonialista sull’India.
Del tutto diversa, invece, è la prospettiva di The New Cambridge Modern History. Presenti solo in misura ridotta rispetto al passato le tematiche che si possono definire tipiche della storiografia di epoca coloniale – come l’organizzazione politico-amministrativa dell’India e dell’impero, e le vicende belliche che coinvolsero europei ed indiani nel subcontinente –, essa introduce un nuovo orizzonte interpretativo, allargato sino ad includere aspetti economici, sociali e culturali della storia indiana. Gli europei sono ancora presenti nella storia di questo vasto paese, ma non ne sono più i soli protagonisti, né tantomeno vengono considerati come l’unico elemento foriero di modernizzazione, in contrasto ad un mondo statico e decadente com’era quello illustrato dalla vecchia Cambridge: i principati, i gruppi sociali e le popolazioni dell’India, quindi, assurgono al ruolo di protagonisti e non sono più trattati solo – o prevalentemente – in funzione dell’espansione britannica e del contesto delle relazioni internazionali.
Percival Spear, a cui si devono le pagine sull’India alla metà dell’Ottocento, scrisse allora:
in the twentieth century this perspective radically changed. It was realised not only that India had a great deal to do with her future but that the forces moulding Indian opinion were by no means wholly western. Indian ideas, discounted by all but a few in Victorian times, were as important as western ones […]. The study of the development of Indian opinion and society, virtually “put on ice” at the end of the eighteenth century, was resumed and seen to be as significant as that of British political or administrative measures. Indian history was seen to be Indian once more. Its significance lay not only in what the British did in India but in how the Indians reacted (NCMH 1957-1979, vol. XI, 411).
nel XX secolo […] questa prospettiva [quella della vecchia Cambridge] mutò radicalmente. Si comprese non solo che l’India aveva molte cose da dire circa il suo futuro, ma anche che le forze che plasmavano l’opinione pubblica indiana non erano tutte di estrazione occidentale. La cultura indiana, che nell’età vittoriana era stata salvo rare eccezioni tenuta in scarso conto, aveva un’importanza pari a quella occidentale […]. Lo studio dell’evoluzione del pensiero e della società indiani, virtualmente “congelato” alla fine del XVIII secolo, venne ripreso e considerato altrettanto importante dello studio delle misure politiche o amministrative britanniche. In altre parole, la storia indiana tornò ad essere considerata indiana; quel che in essa contava non era solo ciò che gli inglesi avevano fatto in India ma anche le forme in cui si era manifestata la reazione degli indiani (Garzanti 1957-1979, vol. XI, 510; traduzione di Gian Attilio Trentini).
In questo senso l’impostazione generale totalmente differente delle due opere risulta ben evidente dall’analisi proposta della celebre rivolta dei sepoys – i mercenari indiani al soldo dell’East India Company –, generalmente conosciuta con la denominazione di Great Mutiny (1857-1858).
Le vicende, com’è noto, cominciano il 29 marzo 1857, a Barrackpore, una località nel Bengala occidentale a una ventina di chilometri da Calcutta. Un sepoy rifiutò di partecipare all’esercitazione di tiro con i nuovi fucili Enfield, appena entrati in dotazione, in quanto per caricarli era necessario mordere la cartuccia lubrificata con grasso animale, un gesto che contravveniva i precetti etici e religiosi di indù e musulmani.
Minacciato di severe punizioni, il soldato sparò al tenente britannico che guidava l’esercitazione e uccise un altro ufficiale, scatenando così un tumulto appoggiato da altri sepoys che lo seguirono nella ribellione. L’insurrezione venne subito soffocata dai britannici, i colpevoli severamente puniti e l’intero reggimento sciolto, ma nelle settimane seguenti, il clima di tensione esplose in tutta la regione a ovest di Calcutta. I britannici e i sepoys rimasti fedeli, colti di sorpresa, si rifugiarono dietro fortificazioni improvvisate, assediate e attaccate ripetutamente dai ribelli indiani. L’attesa dei rinforzi si prolungò per mesi e costò molte perdite a entrambe le parti. Per sedare tutti i focolai della rivolta, i britannici e le truppe a loro fedeli impiegarono quasi due anni: una volta ristabilito l’ordine, il governo britannico avocò a sé la gestione politica, amministrativa e militare dei territori indiani, ponendo definitivamente fine al governo dell’East India Company.
Com’è facile immaginare, il problema del lubrificante di grasso animale non fu che il catalizzatore delle tensioni presenti da molto tempo nel Bengala amministrato dall’East India Company e le cause del Great Mutiny affondavano nella dimensione economica e culturale di un colonialismo sempre più prepotente politicamente e, con il passare del tempo, sempre meno rispettoso della cultura e delle tradizioni locali. Si pensi, ad esempio, alla revisione del valore delle rendite fondiarie – di fatto una redistribuzione della proprietà terriera che intaccò l’assetto sociale tradizionale del Bengala – e alla politica di annessione di quegli Stati indiani incapaci, per ragioni dinastiche, di assicurare la successione per discendenza diretta. Di tenore non inferiore fu l’aggressione culturale, in particolare la campagna di evangelizzazione degli indiani, avvertita dalle popolazioni locali come una minaccia alle loro religioni.
Questo tragico evento – allo stesso tempo funesto ed epocale sia per gli indiani, sia per i britannici – viene trattato dagli autori di The Cambridge Modern History quasi esclusivamente dal punto di vista militare, considerandolo alla stregua di un volgare ammutinamento delle truppe indigene, le cui cause vanno ricercate per lo più all’interno della perfettibile struttura militare dell’East India Company e in relazione all’«arretratezza» degli indiani.
In quest’ottica, dunque, quella del 1857 non fu che l’ultima di una lunga serie di rivolte scoppiate a causa dell’innata «superstizione» degli indiani – che già durante le campagne militari in Afghanistan, ad esempio, si erano ammutinati perché costretti a mangiare cibi considerati impuri –, che si rifiutarono di usare le nuove e «moderne» armi messe a loro disposizione:
The Enfield rifle was being substituted for the Brown Bess; and it was reported that the cartridges, smeared with the fat of sacred cows and the lard of polluted pigs, were to be bitten by Hindu and Mohammadan alike. The ferment caused by this rumour spread from Dum Dum to Barrackpur, and so on to Mirat, where the spark burst into a flame (CMH 1902-1912, vol. XI, 745-746).
Vale a dire:
Il fucile Brown Bess veniva sostituito dallo Enfield; e si venne a sapere che sia gli indù sia i maomettani avrebbero dovuto mordere le cartucce, che erano cosparse di grasso di vacche sacre e di lardo di maiale. La notizia suscitò un fermento che si diffuse da Dum Dum a Barrackpore e fino a Meerut, dove la scintilla appiccò il fuoco (traduzione mia).
E così cominciarono le atrocità ad opera dei «brutali» indiani:
Human imagination has never conceived a scene more heartrending in its details than that witnessed at Cawnpore, when news arrived of the mutinies at Mirat and Delhi […]. Women and children captured in the attempt to escape from neighbouring stations, they were butchered and mutilated, their bodies being thrown into a well (CMH 1902-1912, vol. XI, 747).
Mai l’immaginazione umana ha potuto concepire una scena più raccapricciante di quella cui si assistette a Cawnpore quando arrivò la notizie delle sommosse di Mirat e di Delhi. Donne e bambini catturati nel tentativo di fuggire dalle stazioni dei dintorni vennero massacrati e mutilati, e i corpi gettati in un pozzo.
Alle colpe degli indiani si aggiunsero una serie di ingenuità commesse dalla Compagnia: il reclutamento di un numero sempre maggiore di indù di alta casta comportò un allentamento della disciplina nelle truppe, dato che i sepoys di grado superiore ma di bassa casta non erano capaci di farsi rispettare dai loro sottoposti di casta più elevata, a cui parlavano «con deferenza» in luogo di comandare. A ciò si sommò il malcontento dovuto alla paga troppo bassa che, negli indiani, «predisponeva» alla ribellione e negli europei favoriva la fuga verso incarichi civili ed amministrativi molto più redditizi. A comandare, dunque, su un numero sempre maggiore di soldati indiani – e che aumentava di molto la sproporzione fra le truppe europee e quelle indigene – ci furono spesso gli ufficiali meno capaci e meno motivati, quelli che non erano riusciti a trovare un impiego migliore altrove.
In un’ottica eurocentrica come quella di The Cambridge Modern History risulta davvero inspiegabile l’appoggio dato da una parte della popolazione indiana alla rivolta dei sepoys, una popolazione che era stata «liberata» dal malgoverno dei principi indigeni ed aveva iniziato a godere dei benefici dell’estensione della «civiltà occidentale». Paradossalmente, proprio a causa della loro passività e della loro incapacità ad autogovernarsi, divisi per religione e cultura, e dai costumi «tradizionalmente» turbolenti, gli indiani non seppero appoggiare adeguatamente i sepoys ribelli, facilitando la reazione e la completa riconquista britannica. Finalmente, con la liquidazione della Compagnia e con il passaggio dei possedimenti indiani sotto il controllo diretto della Corona, una stagione di progresso poté avere inizio anche in India:
The transfer of government to the Crown […] was therefore an epoch in Indian history. It directed new influences and currents of thought upon the rulers of India, and it has placed them in the difficult position of serving two masters, endeavouring to reconcile the impatience of Englishmen at Westminster with the halting steps of Indian progress (CMH 1902-1912, vol. XI, 753).
Il trasferimento del governo alla Corona […] fu quindi una svolta epocale nella storia indiana. Nuovi influssi e nuove correnti di pensiero ne derivarono per i raja indiani, ponendoli nella difficile posizione di servire due padroni, nello sforzo di conciliare l’impazienza degli inglesi a Westminster con il passo esitante e incerto del progresso indiano (traduzione mia).
Radicalmente differente è il tenore delle considerazioni formulate da The New Cambridge Modern History.
Sulla rivolta dei sepoys del 1857 – e sulla conseguente fine della Compagnia come attore politico nel subcontinente –, la New Cambridge sottolinea le responsabilità del governo dell’East India Company, incapace di garantire contemporaneamente la stabilità finanziaria, la sicurezza militare e la crescita economica dei possedimenti indiani.
La scelta della New Cambridge è di lasciare sullo sfondo la ricostruzione degli aspetti militari della vicenda, per concentrarsi invece sulla complessità degli aspetti socio-economici ad essa legati. Se è vero che il Mutiny fu in ordine di tempo l’ultima di una lunga serie di rivolte anti-inglesi, ne viene riconosciuta la straordinaria ampiezza ed eccezionalità, e non lo si confina, com’era stato fatto in passato, nell’ambito di un semplice ammutinamento militare dovuto all’ingratitudine ed alla superstizione degli indiani; piuttosto lo si inserisce nel quadro di una reazione all’inasprimento fiscale operato dalla Compagnia ed alla redistribuzione della proprietà terriera (Permanent settlement), che intaccò l’assetto sociale tradizionale, lese gli interessi delle élites rurali ed impoverì la popolazione. Nell’interpretazione di Spear, dunque, pur avviata con uno spirito di «rivoluzione sociale», la riforma agraria, a causa «dell’ignoranza» degli ufficiali britannici, finì per compromettere gravemente il tessuto della società tradizionale indiana:
Lo spirito progressista dell’epoca, insinuandosi in tale processo [di riforma], lo modificò profondamente, finendo col compromettere gravemente le sorti dell’antica aristocrazia terriera [bengalese] e col causare la totale estinzione delle comunità di villaggio (Garzanti 1957-1979, vol. XI, 521).
Inoltre, nel mettere in luce le ragioni sociali della rivolta, emerge che il carattere popolare che essa assunse in vaste regioni del subcontinente non deve essere ingiustamente ammantato da un’ideologia nazionalista, anticipatrice – per così dire – delle lotte che condussero il subcontinente all’indipendenza nel secolo successivo, essendo il concetto occidentale di stato-nazione del tutto alieno sia agli insorti, sia ai sovrani loro alleati contro gli inglesi. Secondo l’opinione di Spear, infatti,
The mutiny as a whole was essentially a convulsive effort by Indian conservatism to put the clock back before it was too late. It is noticeable that wherever there was a rebel success, there was a harking back to traditional models […]. The new westernised class, the ancestors of the modern nationalists, were everywhere on the side of the British; to the rebels they were enemies of the old order (NCMH 1957-1979, vol. XI, 423).
nel suo complesso, l’ammutinamento fu essenzialmente uno sforzo convulso: quello del conservatorismo indiano desideroso di arrestare la marcia del tempo prima che fosse troppo tardi. E’ degno di nota il fatto che là dove i rivoltosi conseguivano un successo, si tornava prontamente ai modelli tradizionali di vita […]. I membri della nuova classe occidentalizzata, i precursori dei nazionalisti moderni, erano inevitabilmente a fianco della Gran Bretagna: per gli insorti essi erano i nemici dell’ordine antico (Garzanti 1957-1979, vol. XI, 526; traduzione di Attilio Trentini).
Qualche considerazione conclusiva
L’interpretazione della New Cambridge sui fatti relativi al Great Mutiny del 1857-1858 ci mette in guardia tanto dalle generalizzazioni di una storiografia colonialista e eurocentrica, quella della «naturale» propensione dell’asiatico all’«immobilismo», alla «servitù» ed al «malgoverno», quanto dal suo opposto: ovvero non si dovrebbe commettere l’errore di passare agli eccessi di quella post-colonialista à la Edward Said, non di rado viziata da preconcetti orientalistici tanto quanto la precedente e spesso tendente a considerare ogni rivolta contro il colonizzatore occidentale come un passo inevitabile e «necessario» lungo il cammino che porta alla modernità e verso l’indipendenza le nazioni asiatiche, un tempo «arretrate» e «schiave» delle potenze occidentali.
Amartya Sen 2005) – trattando in generale dell’approccio occidentale allo studio della storia dell’India, ma con un ragionamento estremamente efficace anche per individuare chiaramente le differenze fra la vecchia e la nuova Cambridge –, sostiene che il discorso sull’India caratteristico della storiografia coloniale, qui rappresentata dalla vecchia Cambridge History, si prefigge scientemente di nascondere gli aspetti razionali e scientifici della tradizione culturale indiana, mentre al contrario l’approccio esoticista, che caratterizza numerosi Postcolonial studies, ne mette in luce, in maniera spesso distorta e distorsiva, quasi esclusivamente i caratteri a-razionali e mistici: ne consegue che, in un caso e nell’altro, la cultura viene separata artificiosamente dalla componete razionale del pensiero, e le importanti tradizioni indiane in ambito matematico, scientifico o epistemologico finiscono per essere conosciute solo dagli studiosi di orientalistica, ma risultano di fatto inesistenti per la stragrande maggioranza degli occidentali.
Seguendo questo ragionamento non si può non notare che gli studi eurocentrici e quelli postcoloniali sono talvolta accomunati – pur se con finalità totalmente diverse – nel presentare le società del subcontinente indiano come qualcosa di alieno e di separato rispetto alla modernità ed al «progresso» europeo, mancando invece di sottolineare tutti quegli aspetti essenziali che testimoniano i continui incroci, connessioni e contaminazioni fra i due mondi, aspetti invece presenti e ben trattati nei capitoli della pionieristica New Cambridge e messi a disposizione dei lettori italiani dalla fondamentale traduzione della Garzanti.
Bibliografia
CMH 1902-1912: The Cambridge Modern History, planned by John Emerich Edward Dalberg and edited by George Walter Prothero, Stanley Leathers, Adolphus William Ward, 13 vols, Cambridge, Cambridge University Press: 1. The Renaissance; 2. The Reformation; 3. The Wars of Religion; 4. The Thirty Years’ War; 5. The Age of Louis XIV; 6. The Eighteenth Century; 7. The United States; 8. The French Revolution; 9. Napoleon; 10. The Restoration; 11. The Growth of Nationalities; 12. The Latest Age; 13. Genealogical Tables and Lists and General Index
Borsa 1977: Giorgio Borsa, L’Estremo Oriente: nuovi orientamenti storiografici, in Nuove questioni di storia contemporanea, Milano, Marzorati, vol. II, pp. 1617-1679.
NCMH 1957-1979: The New Cambridge Modern History, 13 voll., Cambridge, Cambridge University Press: 1. The Renaissance, 1493-1520, edited by G.R. Potter; 2. The Reformation, 1520-1559, edited by G.R. Elton; 3. The Counter-Reformation and Price Revolution, 1559-1610, edited by R B. Wernham; 4. The Decline of Spain and the Thirty Years War, 1609-1648/59, edited by J.P. Cooper; 5. The ascendancy of France, 1648-1688, edited by F.L. Carsten; 6. The Rise of Great Britain and Russia, 1688-1715/25, edited by J.S. Bromley; 7. The Old Regime, 1713-63, edited by J.O. Lindsay; 8. The American and French Revolutions, 1763-1793, edited by A. Goodwin; War and Peace in an Age of Upheaval, 1793-1830, edited by C.W. Crawley; 10. The Zenith of European Power, 1830-1870, edited by J.P.T. Bury; 11. Material Progress and World-wide Problems, 1870-1898, edited by F.H. Hinsley; 12. The Era of Violence, 1898-1945, edited by David Thomson; 13. Companion volume, edited by Peter Burke; 14. Atlas, edited by H.C. Darby and Harold Fullard
Garzanti 1967-1972: Storia del mondo moderno, traduttori vari, 12 voll., Milano, Garzanti: 1. Il Rinascimento (1493-1520), a cura di George Richard Potter; 2. La Riforma (1520-1559), a cura di Geoffrey Rudolph Elton; 3. La Controriforma e la rivoluzione dei prezzi (1559-1610), a cura di Richard Bruce Wernham; 4. La decadenza della Spagna e la guerra dei Trent’anni (1610-1648/59), a cura di John Philip Cooper; 5. La supremazia della Francia (1648-1688), a cura di Francis Ludwig Carsten; 6. L’ascesa della Gran Bretagna e della Russia (1688-1713/1725), a cura di John Selwin Bromley; 7. Il vecchio regime (1713-1763), a cura di J.O. Lindsay; 8. Le rivoluzioni d’America e di Francia (1763-1793), a cura di Albert Goodwin; 9. Le guerre napoleoniche e la Restaurazione (1793-1830), a cura di Charles William Crawley; 10. Il culmine della potenza europea (1830-1870), a cura di John Patrick Tuer Bury; 11. L’espansione coloniale e I problemi sociali (1870-1898), a cura di Francis Harry Hinsley; 12. I grandi conflitti mondiali (1898-1945), a cura di Charles Loch Mowat
Sen 2006: Amartya Sen, L’altra India. La tradizione razionalista e scettica alle radici della cultura indiana, Milano, Mondadori (traduzione di Gianni Rigamonti da Amartya Sen, The Argumentative Indian. Writings on Indian History, Culture and Identity, London, Allen Lane, 2005)