di Gianfranco Petrillo
A proposito di: Lirici greci, a cura di Chiara Di Noi, Introduzione di Luigi Enrico Rossi, Appendice a cura di Enrico Cerroni, Roma, Salerno editrice, 2015, pp. 632, s.i.p. [ma € 22,00]
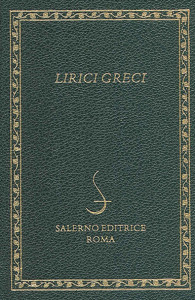 Dunque, la traduzione dei Lirici greci compiuta dal geometra e impiegato del Genio Civile Quasimodo Salvatore, anno 1940, costituisce davvero uno spartiacque. Non sono solo i critici letterari e i cultori di storia e teoria della traduzione in Italia, come da ultimo Angela Albanese e Franco Nasi nella loro antologia L’artefice aggiunto (Ravenna, Longo, 2015), a considerare quel libro – anche grazie all’importante prefazione che per esso scrisse un ancor giovane e poco noto allievo di Antonio Banfi, Luciano Anceschi – una pietra miliare nella consapevolezza critica non solo del tradurre ma del fare poesia. A scriverlo sono anche gli specialisti di letteratura greca classica.
Dunque, la traduzione dei Lirici greci compiuta dal geometra e impiegato del Genio Civile Quasimodo Salvatore, anno 1940, costituisce davvero uno spartiacque. Non sono solo i critici letterari e i cultori di storia e teoria della traduzione in Italia, come da ultimo Angela Albanese e Franco Nasi nella loro antologia L’artefice aggiunto (Ravenna, Longo, 2015), a considerare quel libro – anche grazie all’importante prefazione che per esso scrisse un ancor giovane e poco noto allievo di Antonio Banfi, Luciano Anceschi – una pietra miliare nella consapevolezza critica non solo del tradurre ma del fare poesia. A scriverlo sono anche gli specialisti di letteratura greca classica.
Questo delizioso volumetto (cm 11 x 7,5) della collana «I Diamanti» della Salerno è infatti diviso in due parti. Nella prima, dopo un’Introduzione costituita dalla ripresa del VI capitolo, steso dallo scomparso Luigi Enrico Rossi, del primo volume del manuale di Storia e testi delle letteratura greca costruito da lui con Roberto Nicolai (Firenze, Le Monnier, 2002, pp. 207-16), la curatrice Chiara Di Noi espone in successione cronologica le proprie traduzioni da una scelta di frammenti della lirica arcaica, con testi a fronte e con note introduttive, essenziali ma chiare e filologicamente accurate. I quasi sessant’anni di colpevole oblio lasciati cadere sull’ottimo greco insegnatomi non mi consentono di dire dell’attendibilità della resa dal punto di vista filologico (anche se sono fortemente propenso a concedere ampio credito a Di Noi), ma posso dire sinceramente che si tratta di una resa semplice, metricamente libera e diversificata e ritmicamente godibile: una lettura molto piacevole, non solo senza asperità, ma anche senza impuntature attribuibili a un eccesso di scrupolo linguistico, da cui sorge un mondo poetico e umano molto vivo, ben diverso da quello che si è sedimentato nella nostra mentalità quando si pensa ai poeti greci; lontano non solo dagli atteggiamenti marmorei e paludati degli antichisti pre-Quasimodo (ci torneremo), ma anche dalla necessaria assimilazione a se stesso, alla propria poetica, alla ermetica – diciamo così – “liricità pura”, compiuta dal poeta siciliano.
La seconda parte è occupata da una corposa «appendice dedicata a una selezione di traduzioni italiane dei lirici […] frutto assai spesso di autori noti solo agli specialisti». La rituale liturgia accademica con cui viene presentata questa operazione editoriale nella Premessa di Michele Napolitano, professore associato all’Università di Cassino, dà per scontata, «per molte ragioni» che non vengono nemmeno esposte, la decisione «di limitare l’ambito cronologico della selezione a prima di Quasimodo» (p. XI). È il curatore di questa appendice, Enrico Cerroni, nella sua ottima Nota introduttiva (pp. 367-376), precisa ma priva di ogni rigidità accademica e corredata da una preziosissima Nota bibliografica, a esporre sinteticamente quelle ragioni: «Le traduzioni modernizzanti di Quasimodo, un capolavoro di poesia che si nutre di poesia, avrebbero de facto orientato la lettura della lirica greca arcaica per generazioni, oscurando la più antica immagine di questa esperienza letteraria conservata da poeti, scrittori e filologi». In quei versi lontani nel tempo Quasimodo cercava, era lui stesso a dirlo, le radici di «una storia del cuore umano» (pp. 367-8), e poco gli importava di riprodurre sentimenti e ambienti antichi di più di duemila anni. Ma anche così, è forse riduttivo bollare il riuscito esperimento di Quasimodo quale semplice prova di ermetismo, quasi si trattasse di una chiusura in se stesso e in una corrente letteraria ben datata: era invece la scelta di scendere, armato di una lingua poetica semplice e disadorna ma non vacua, sullo stesso terreno, quello degli autori classici, sul quale si esibiva l’enfasi retorica in auge.
Proprio quel tipo di classicità invece pretendevano di ricreare i traduttori che lo avevano preceduto. Anche chi, come Ettore Romagnoli (1871-1938), avrebbe voluto emanciparsi dalla toga accademica che professionalmente lo rivestiva, non poteva sottrarsi a salire su un ideale podio, impugnando il linguaggio «”aromatico” criticato da Quasimodo (con i paradigmatici opino, pampineo, rigoglio, fulgido, florido), la metrica e l’intera enfasi che avvolgeva il [suo] lavoro» di traduttore. Sì, era quello il segno della «appartenenza del Romagnoli al “mondo di ieri” [mi si lasci rimarcare quest’opportuna ripresa dell’immagine zweighiana], cioè a quella elitaria società italiana (ed europea) che aveva fatto della cultura classica ben più di una materia scolastica o di studi universitari» (pp. 368-9).
Forse non è un caso che quella versione di Quasimodo vedesse la luce nello stesso anno, il 1940, in cui il suo ex cognato Elio Vittorini costruiva l’antologia Americana, che, immediatamente sequestrata alla sua uscita, l’anno dopo, era destinata anch’essa – pubblicata nel 1942 pur con la corriva e riabilitante introduzione di Sua Eccellenza Emilio Cecchi, debitamente infarcita di antiamericanismo – a segnare una rottura storica tra due modi di concepire la letteratura: se in questo caso non si trattava di contribuire a tracciare una «storia del cuore umano», ma di riscoprire «la terra», come affermava da subito Vittorini, in ogni caso era una svolta, la svolta verso la sincerità. Oh batteva sì, un’ora speciale, «nel cielo della nostra patria», come annunciava nel giugno del 1940 Mussolini dal balcone di palazzo Venezia: l’ora in cui da sogni di pepli e toghe, di opliti e legioni, l’Italia doveva cominciare a risvegliarsi nel dolore, nella riflessione e nella riscoperta dell’autenticità dell’uomo. E non sarà neppure un caso che presso Bompiani Vittorini avesse quale collega di consulenza editoriale proprio Antonio Banfi, il Filosofo, il maestro di Anceschi (e non solo).
Riemerge, dalla selezione compiuta da Cerroni e qui presentata, «un mondo perlopiù sommerso: sommerso sia dalla filologia novecentesca, che ha provveduto a nuove traduzioni e a dare un volto sempre più nitido e storicamente collocato dei lirici, sia dalla letteratura contemporanea, che con Quasimodo ha inevitabilmente obliterato molti degli esperimenti di lettura e traduzione precedenti, anche di grandi scrittori» (p. 370).
Ogni versione antologizzata da Cerroni è accompagnata da succinte ma esaurienti note che gettano luce sia sulla figura del traduttore sia sulle caratteristiche linguistiche della traduzione e che, tutte insieme, finiscono per costituire una sorta di preziosa storia della ricezione dei lirici greci in lingua italiana. Tra questi traduttori spiccano, oltre a quello di Romagnoli (il più recente), i nomi di Melchiorre Cesarotti, Ippolito Pindemonte, Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Ippolito Nievo, Giacomo Zanella, Felice Cavallotti, Giovanni Pascoli. Né mancano versi che hanno un loro sapore poetico, riferito a un’aura storicamente determinata, né più né meno di quanto lo fosse l’ermetismo quasimodiano.
Insomma, un panorama efficacissimo della “norma” linguistica letteraria fra tardo Settecento e inizio Novecento. Un libretto molto ben fatto e molto godibile.