IL MOMENTO MAGICO DEGLI ANNI CINQUANTA E DEI SESSANTA
di Mario Marchetti
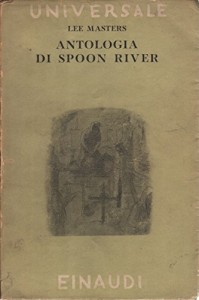 C’è stata un’epoca – i primi decenni dopo la seconda guerra mondiale − in cui la poesia, o meglio alcuni poeti, furono o divennero in Italia una libera lettura di massa. Naturalmente per massa intendiamo qui il ceto medio mediamente colto: studenti, professionisti, insegnanti, ma non solo. Una lettura d’élite ovviamente non è mai mancata. Come non era mai mancata dalla fine dell’Ottocento agli anni trenta del Novecento la lettura più o meno istituzionale dei poeti della nostra triade nazionale, Carducci, Pascoli, D’Annunzio: le loro poesie si leggevano nei salotti, erano riferimenti obbligati nelle conversazioni delle persone appena un po’ coltivate, la scuola ne fece un’ineludibile e fondamentale esperienza formativa, che si prolungò − grazie al conservatorismo culturale del fascismo al potere, prima, e del centrismo cattolico poi − almeno fino al termine degli anni cinquanta, quando cominciò ad affiancarsele, piuttosto timidamente, la triade Ungaretti, Montale, Quasimodo (con l’appendice di Umberto Saba). Certo, anche nella scuola cominciavano a insinuarsi altre suggestioni, di cui peraltro erano già portatori i primi tre poeti citati, sommariamente battezzati come ermetici, nonché qualche superstite testo futurista, in particolare di Palazzeschi, per non dire degli encomiabili tentativi, perlopiù destinati a rimanere sul piano dei desideri, di certi insegnanti di far conoscere agli allievi i grandi poeti stranieri della modernità. A livello scolastico una grande scossa attualizzante e globalizzante, anche nei testi poetici proposti, fu data poi dalla nascita della media unica. Ma questa è un’altra storia o, meglio, una storia ai fianchi della nostra…
C’è stata un’epoca – i primi decenni dopo la seconda guerra mondiale − in cui la poesia, o meglio alcuni poeti, furono o divennero in Italia una libera lettura di massa. Naturalmente per massa intendiamo qui il ceto medio mediamente colto: studenti, professionisti, insegnanti, ma non solo. Una lettura d’élite ovviamente non è mai mancata. Come non era mai mancata dalla fine dell’Ottocento agli anni trenta del Novecento la lettura più o meno istituzionale dei poeti della nostra triade nazionale, Carducci, Pascoli, D’Annunzio: le loro poesie si leggevano nei salotti, erano riferimenti obbligati nelle conversazioni delle persone appena un po’ coltivate, la scuola ne fece un’ineludibile e fondamentale esperienza formativa, che si prolungò − grazie al conservatorismo culturale del fascismo al potere, prima, e del centrismo cattolico poi − almeno fino al termine degli anni cinquanta, quando cominciò ad affiancarsele, piuttosto timidamente, la triade Ungaretti, Montale, Quasimodo (con l’appendice di Umberto Saba). Certo, anche nella scuola cominciavano a insinuarsi altre suggestioni, di cui peraltro erano già portatori i primi tre poeti citati, sommariamente battezzati come ermetici, nonché qualche superstite testo futurista, in particolare di Palazzeschi, per non dire degli encomiabili tentativi, perlopiù destinati a rimanere sul piano dei desideri, di certi insegnanti di far conoscere agli allievi i grandi poeti stranieri della modernità. A livello scolastico una grande scossa attualizzante e globalizzante, anche nei testi poetici proposti, fu data poi dalla nascita della media unica. Ma questa è un’altra storia o, meglio, una storia ai fianchi della nostra…
Fuori della scuola agivano, però, potentemente altre forze.
Il ventennio postbellico (con qualche sparsa anticipazione) vide la nascita e l’affermazione delle prime e più importanti (e, purtroppo, ineguagliate) collane di poeti tradotti con testo a fronte, collane che misero a disposizione dei lettori italiani il meglio, o quello che si riteneva tale o si conosceva come tale, della poesia straniera contemporanea. Fu la scoperta di un mondo nuovo, fuori delle pastoie della tradizione poetica patria, particolarmente solida e poco disposta a essere detronizzata. Prima di occuparci di cosa soprattutto si leggeva, faremo un rapido cenno a queste collane, concentrandoci sul periodo 1945-1969 per far cogliere appieno la straordinarietà del lavoro compiuto in quegli anni per mettere a contatto il pubblico italiano con la grande rivoluzione lirica novecentesca avvenuta fuori dei nostri confini (senza con questo voler far torto ai poeti patrii). E finalmente il pubblico italiano ebbe anche la possibilità di avere a disposizione le versioni con gli originali (anche se, a vero dire, non sempre). Non sarebbe però giusto dimenticare, in proposito, forse la primissima − ed eruditissima − collana con testo a fronte, la «Biblioteca sansoniana straniera»,che si occupava però di classici ottocenteschi, preferibilmente romantici o tardo romantici, come Byron, Shelley, Keats, Coleridge, Wagner, e non di autori contemporanei.
Le collane di poesia
La prima collana, anzi “collezione”, a comparire fu «Fenice» di Guanda, che aveva un ampio programma universalizzante, ma soprattutto fece conoscere Lorca, Eliot, Auden, Dylan Thomas, Hart Crane, Esenin, Neruda, Prévert, Jiménez e anche Apollinaire e Walt Whitman… Col suo numero 2 – le Poesie di Lorca tradotte da Carlo Bo − uscito nel 1940, ci fu la scoperta della grande lirica spagnola contemporanea, allora nota solo agli happy few, cui fece seguito nel 1941 un altro caposaldo del modernismo, T.S. Eliot, tradotto da Luigi Berti. Dopo la guerra la collana prese grande abbrivio: i titoli nel 1960 erano già una quarantina e, come si è accennato, coprivano un orizzonte spazio-temporale insofferente di limiti: vi compaiono sia una scelta di canti aztechi tradotti da Ugo Liberatore e Jorge Hernandez-Campos sia il poeta simbolo dell’appena nato Pakistan − dalla sanguinosa partition con l’India −, Muhammad Iqbal, antesignano della rinascita islamico/islamista, presentato in italiano dallo specialista Alessandro Bausani. In parallelo, fondamentalmente negli anni cinquanta, prendeva forma la raffinata ed elitaria (stampava una media di 1500 copie) «Collana Cederna» della fiorentina Vallecchi, che si distingueva per la sobria copertina bianco-dorata velata da un diafano foglio di cellofan e forse per un minor impegno “civile” e un più spiccato interesse per la poesia pura e la prosa rarefatta. La collana ereditava il catalogo delle effimere edizioni Cederna di Milano, che ebbero il merito, grazie soprattutto all’attivissimo Leone Traverso e a Giorgio Zampa, di pubblicare per la prima volta libri interamente dedicati all’espressionista (peraltro parzialmente compromesso col nazismo) Gottfried Benn e al cupamente trasgressivo Georg Trakl, che andavano ad affiancare a un gran numero di testi dell’umbratile Rilke. Rilke era un poeta molto amato e molto noto sin dalla fine degli anni venti per iniziativa di Vincenzo Errante per la Alpes prima e per Sansoni poi. Non mancano però anche qui le incursioni pionieristiche nel mondo anglosassone, con Yeats tradotto da Traverso e le Poesie da un soldo di Joyce nella versione di Alberto Rossi come vi appaiono anche dei Sonetti di Góngora, il poeta barocco tanto amato da Lorca e dalla generazione del ‘27, non ignoto in Italia, ma riscoperto nell’aura dell’avventura ispanista dal poliedrico Traverso. Presso Vallecchi si aggiunsero alle poesie di Rilke tradotte da Traverso e riunite in due volumi tra il 1954 e il 1958 un volume di Prose lorchiane a cura di Carlo Bo (1954 – dove si può trovare l’enigmatico pezzo sul duende, Teoria e gioco del demone – e il saggio su Lo spirito romanzo di Ezra Pound tradotto da Sergio Baldi.
Sempre nello stesso periodo, denso di iniziative squisitamente culturali, esce la collana «Il Melagrano» diretta da Guido Manacorda per le edizioni Fussi (poi assorbita da Sansoni), costituita da più di cento volumetti dall’anodino color mattone e dal formato tascabile, il cui vanto è la preziosità delle scelte. Qui, tra molti testi rari di ogni epoca e di ogni lingua, vedono la luce – oltre all’immancabile, in tutte queste collane, Mallarmé, padre di tutti i modernismi, con la versione dell’Après-midi d’un faune tradotto da Alessandro Parronchi (1946) – la versione dell’eliotiana Terra desolata a cura di Mario Praz (1949), le Poesie di Anna Achmatova tradotte da Dan Danino di Sarra (1951), nonché Animale di fondo di Juan Ramón Jiménez, a cura di Rinaldo Froldi (1954), e ancora il visionario e assai contemporaneo – all’epoca – Robert Lowell, tradotto da Rolando Anzilotti (1955).
Ma la più bella collana di poesia, sicuramente dal punto di vista estetico, sarà «Poeti europei» di Lerici in collaborazione con Scheiwiller. Come chiarisce l’editore, con questo titolo non si voleva dare un’indicazione geografica ma si intendeva alludere al ruolo svolto dagli autori prescelti nella formazione della coscienza europea: non dimentichiamo che sono gli anni delle grandi speranze nell’unione del vecchio continente, speranze non solo di indole economica. Erano volumi di grande eleganza, rilegati in tela rossa e come incastonati in un cofanetto dall’insuperata grafica anni sessanta dovuta a Giulio Confalonieri (al quale va in realtà il merito di tutto il design innovativo delle copertine Lerici). Sul piatto bianco del cofanetto compariva, oltre al titolo e al nome dell’autore in caratteri dattilografici giganti, un facsimile della sua scrittura corsiva; i fogli erano poi di particolare consistenza e grammatura. Tutto ciò, unito alle prodighe spaziature e all’ariosità della pagina (con molto bianco, come si addice a un testo poetico) creava, e crea ancora per chi ha la fortuna di possedere questi volumi, un’irripetibile esperienza di lettura. La collana, iniziata nel 1957, si chiude nel fatidico 1969 col terzo volume delle opere complete dell’immaginifico poeta franco-antillano Saint-John Perse tradotto da Romeo Pugliese. Tra gli altri autori pubblicati, tutti significativi (Pound, Williams, Jouve, Hikmet…), ricordiamo in particolare i classici della poesia di lingua castigliana del Novecento (Machado, Salinas, Cernuda, Felipe, il peruviano Vallejo – quello di España, aparta de mí este cáliz -, il guatemalteco Asturias) e il portoghese Pessoa, a quel tempo (1967) da noi pressoché sconosciuto e oggi celeberrimo e, soprattutto, citatissimo. Insomma un quadro ampio, ricco e innovativo. Davvero uno splendido dono, questi libri, per chi poté avvicinarli.
Nel 1964 nasce poi la «Collezione di poesia» di Einaudi, la blasonata «bianca», una sorta di universale, che stancamente sopravvive ancora oggi. Il primo numero – che esibiva già, secondo una grafica alla Lerici, un blocco di testo poetico sulla lattea copertina − era dedicato all’ottocentesco poeta russo Tjutčev tradotto da Tommaso Landolfi (1964). Per il nostro discorso, che si chiude col 1969 e privilegia i poeti del Novecento e, in particolare, quelli che hanno lasciato traccia sui lettori dell’epoca, vanno ricordati oltre a Eliot (La terra desolata nella ripresa della canonica traduzione di Mario Praz), lo Yeats di Giorgio Melchiori, Blok (I dodici, nella storica traduzione di Renato Poggioli), il Valéry di Mario Tutino, il Rilke di Giaime Pintor (uscito per la prima volta nel 1942), l’Achmatova di Carlo Riccio, il Benn di Ferruccio Masini, Majakovskij (Lenin, tradotto da Ripellino), un scelta di Kavafis curata da Margherita Dalmati e Nelo Risi, Esenin (Pugačëv), ma soprattutto il Libro di devozioni domestiche di Brecht tradotto da Roberto Fertonani, contenente l’esemplare Del povero Bertolt Brecht, e le Poesie di Pablo Neruda nella traduzione di Slavatore Quasimodo risalente al 1952, con le altrettanto esemplari Corpo di donna e Ode per Federico García Lorca. Come si vede, emergono, nel pur ampio ventaglio, una serie di autori russi coinvolti a diverso titolo nel processo rivoluzionario (o che comunque non esularono) oppure altri, come Brecht e Neruda, che furono comunisti o convinti compagni di strada. Di Einaudi andrebbero ancora ricordati taluni «Supercoralli», come quelli dedicati ai poeti surrealisti spagnoli a cura di Vittorio Bodini, alle prose di Dylan Thomas tradotte dalla mitica «gentile signora» Lucia Rodocanachi, a W.C. Williams tradotto da Cristina Campo e Vittorio Sereni, a André Breton tradotto da Giordano Falzoni e allo splendido Chlebnikov, poeta dell’“asiaticità”, curato da Ripellino. Ma sicuramente gli Einaudi di poesia che ebbero maggior impatto o furono più diffusamente letti tra anni cinquanta e sessanta sono stati: Foglie d’erba di Walt Whitman (pubblicato nel 1950 nei «Millenni», a cura di Enzo Giachino), testo seminale di tanta poesia del Novecento, particolarmente amato da Lorca che dedicò all’autore l’Ode a Walt Whitman, già compresa nelle prime edizioni italiane dei versi del poeta andaluso, quelle di Bo pubblicate da Guanda; l’Antologia di Spoon River, a cura di Fernanda Pivano, che ebbe numerosissime ristampe, spesso, soprattutto inizialmente, senza testo a fronte: ne riparleremo; le Liriche cinesi, a cura di Giorgia Valensin, uscite originariamente nel 1943, che videro fino al 1968 ben quattordici edizioni, ovviamente senza testo a fronte; le Poesie e canzoni di Brecht, tradotte da Franco Fortini e Ruth Leiser, che videro una decina di edizioni tra il 1961 e il 1970, tra «Millenni», «Supercoralli» e «Nuova Universale Einaudi»; e, infine, le Poesie di Éluard, tradotte da Fortini nel 1955, tra cui Liberté, simbolo di ogni resistenza, il testo lanciato in migliaia di copie dagli aerei alleati sopra la Francia occupata dai nazisti.
Ricordiamo ancora «Lo Specchio» di Mondadori, collana votata allora fondamentalmente ai poeti italiani, cosa che non le impedì di pubblicare tra la fine degli anni cinquanta e gli anni sessanta un pugno significativo di stranieri: i versi di Joyce tradotti da Alfredo Giuliani, Alberto Rossi, Edoardo Sanguineti e Juan Rodolfo Wilcock; Kavafis e Seferis (la particolare attenzione di questa collana verso i poeti neoellenici va ascritta a Filippo Maria Pontani), lo Hikmet di Joyce Lussu, il Pound di Alfredo Rizzardi, Auden tradotto da Antonio Rinaldi, Rafael Alberti tradotto da Vittorio Bodini e l’ottocentesca Dickinson tradotta da Guido Errante, che, anch’essa, peraltro come i tra loro divergenti Whitman e Mallarmé, aveva aperto nuove strade alla lirica moderna. Non a caso questi autori troviamo sparsamente tradotti nelle varie collane nate in quegli anni. A Emily Dickinson fu legata da una lunga fedeltà Margherita Guidacci che ne pubblicò un’amplissima scelta per Sansoni nel 1961 col titolo Poesie e lettere tra i «Grandi classici stranieri», collana in cui comparvero anche Rilke (tradotto da Vincenzo Errante, più famoso del fratello Guido che gli dedicò la sua fatica dickensoniana), Neruda curato da Dario Puccini e Jorge Guillén tradotto da Oreste Macrì (ma siamo già nel 1972), tutti volumi senza testo a fronte.
Molti dei poeti che abbiamo nominati fin qui furono pubblicati all’epoca anche da Nuova Accademia, nelle collane «Il mosaico dei poeti» prima e «I cristalli» poi, in edizioni più economiche e divulgative, con l’interessante proposta, in più, del poeta della négritude, Sédar Senghor, presentato da Carlo Castellaneta nel 1961. Il sodale martinicano di Senghor, Aimé Césaire, verrà pubblicato dalla «Piccola Fenice» nel 1962 nelle versioni di Anna Vizioli e Franco De Poli. Ma di Nuova Accademia furono soprattutto interessanti i discolibri della collana «Stelle» che negli anni sessanta favorirono il gusto per la poesia e fecero conoscere, rendendoli popolari, alcuni poeti stranieri: Anna Proclemer prestò la propria voce a Anna Achmatova, Giorgio Albertazzi a Éluard e Neruda, Tino Carraro a Valéry, Davide Montemurri a Walt Whitman. La dizione più famosa resta quella incisa nel 1960 in vinile da Arnoldo Foà per la Fonit Cetra del lorchiano Lamento per la morte di Ignacio tradotto da Bo, disco che superò il milione di copie vendute, anche per merito della successiva edizione (1962) che proponeva l’accompagnamento musicale del chitarrista Mario Gangi. Nel 1968 Foà presterà la sua arte di dicitore anche a Neruda per la collana «La voce dei poeti» − sempre marchio Fonit Cetra − diretta da Folco Portinari. E così, a favorire l’accoglienza delle poesie di Brecht sarà il grande successo della Vita di Galileo messa in scena da Giorgio Strehler nella stagione 1962-1963 al Piccolo Teatro di Milano e, più tardi, nella stagione 1967-68, il recital Io, Bertolt Brecht portato a Milano, Roma e Trieste da Strehler e Milva, che negli anni settanta diventerà la più nota interprete italiana delle canzoni brechtiane.
L’abbagliante scoperta dei poeti di Spagna (più Neruda)
 Insomma un quadro culturale molto fervido, che offriva, a diversi livelli di fruizione, tutti gli strumenti per avvicinare la grande poesia straniera contemporanea. Fu una sorta di esplosione, tardiva, però, rispetto al boom traduttorio vissuto dall’analoga narrativa tra la fine degli anni venti e gli anni trenta. Certo, tradurre poesia è più complesso (secondo Jakobson, addirittura la poesia sarebbe intraducibile per definizione): occorreva disporre di strumenti affinati, non solo filologici quali senza dubbio possedevano i curatori della «Biblioteca sansoniana straniera» degli anni venti. Sicuramente tutto il lavorio delle riviste letterarie novecentesche ebbe il suo peso, come lo ebbero le innovative esperienze dell’ermetismo e della prosa d’arte. Occorreva superare la tradizione retorica che tanto peso aveva in Italia, ampiamente riscontrabile nelle traduzioni della lirica e della tragedia classiche che circolarono in Italia fin oltre la metà del Novecento. Occorreva mettere al centro la parola nella sua nudità. Genericamente, si può notare che spesso ancora a lungo il lessico della poesia tradotta rimase di registro più elevato rispetto all’originale. Ma occorrerebbe esaminare caso per caso.
Insomma un quadro culturale molto fervido, che offriva, a diversi livelli di fruizione, tutti gli strumenti per avvicinare la grande poesia straniera contemporanea. Fu una sorta di esplosione, tardiva, però, rispetto al boom traduttorio vissuto dall’analoga narrativa tra la fine degli anni venti e gli anni trenta. Certo, tradurre poesia è più complesso (secondo Jakobson, addirittura la poesia sarebbe intraducibile per definizione): occorreva disporre di strumenti affinati, non solo filologici quali senza dubbio possedevano i curatori della «Biblioteca sansoniana straniera» degli anni venti. Sicuramente tutto il lavorio delle riviste letterarie novecentesche ebbe il suo peso, come lo ebbero le innovative esperienze dell’ermetismo e della prosa d’arte. Occorreva superare la tradizione retorica che tanto peso aveva in Italia, ampiamente riscontrabile nelle traduzioni della lirica e della tragedia classiche che circolarono in Italia fin oltre la metà del Novecento. Occorreva mettere al centro la parola nella sua nudità. Genericamente, si può notare che spesso ancora a lungo il lessico della poesia tradotta rimase di registro più elevato rispetto all’originale. Ma occorrerebbe esaminare caso per caso.
La grande scoperta di quegli anni fu, in Italia, quella della poesia in lingua castigliana sia ispanica che sudamericana. Fu qualcosa di abbagliante. Come poteva scrivere il filologo romanzo Hugo Friedrich nel suo ancor oggi miliare saggio del 1956 sulla lirica moderna: «L’opera di Machado, Jiménez, García Lorca, Alberti, Diego e altri, è il tesoro forse più prezioso che possegga la lirica contemporanea». Friedrich si riferisce sostanzialmente ai poeti della seconda età dell’oro della letteratura spagnola – com’è stata battezzata −, ma il discorso può essere tranquillamente allargato ai poeti ispano-americani, visti gli stretti legami che li univano. Di loro ammaliava il linguaggio simbolico che evoca più che nominare. Aspetto, peraltro, che vale ugualmente per gli altri grandi filoni, tedeschi, francesi, anglosassoni e anche italiani, della lirica novecentesca. La magia delle parole, l’oscurità del senso disorientavano e affascinavano insieme. E tale allusività la si ritrovava spesso anche negli autori più accessibili come Neruda.
L’amore per Lorca fu dunque inevitabile per i nostri pregiatori della lirica pura. Ma ci fu un altro importantissimo elemento che rese Lorca (come anche altri poeti spagnoli e, diciamo pure, la Spagna) tanto popolare, e non solo tra gli uomini di cultura, ma anche nel più ampio pubblico, e cioè il mito – e la realtà − della guerra di Spagna (così si diceva allora). Come sappiamo da tante testimonianze, in particolare di Elio Vittorini («Ora sentivamo che nell’offeso mondo si poteva essere fuori della servitù e in armi contro di essa, con trombe contro di essa», scriveva sul «Politecnico» n. 1, a fine settembre 1945, sotto il titolo Il popolo spagnolo attende la liberazione), ma anche di Sciascia (in Antimonio, uno dei quattro racconti che costituiscono Gli zii di Sicilia), la guerra civile spagnola risvegliò la coscienza di molti giovani e meno giovani italiani resa ottusa dall’isolazionismo e dalla propaganda di regime. La natura di classe dello scontro era palese, come era palese da che parte stessero Mussolini e Hitler. Le gesta dei repubblicani e delle brigate internazionali trapelavano anche in Italia in una luce eroica, come non si potevano chiudere gli occhi di fronte alle decine di migliaia di spagnoli che dovettero esulare in Francia. Dopo la guerra, a lungo, l’antifranchismo fu un essenziale e simbolico collante della sinistra italiana, coinvolgendo gran parte della società civile, ben al di là dei militanti e votanti socialisti e comunisti. Certamente il partito comunista democratizzato e democratico, a suo modo, del dopoguerra cavalcò ampiamente questo sentimento, dimentico del ruolo giocato da Stalin in Spagna, ma erano cose di cui allora poco si diceva…
Lorca in questo quadro cadeva a pennello. Le circostanze della sua morte non erano chiare, ma si sapeva del suo favore per la repubblica (non diversamente dalla maggior parte degli altri grandi poeti spagnoli della sua generazione) ed era sicuramente stato vittima di una vendetta falangista. Lo splendore dei suoi versi, con un’inimitabile mescolanza di tratti popolari e di tratti oscuri, unito alla sua morte dalla parte giusta ne fecero il poeta più popolare dell’epoca in Italia (e lo dimostrano le citate letture in vinile di Foà): poteva piacere ai raffinati e poteva piacere a un pubblico genericamente colto o politicizzato (come era quello ruotante nell’orbita dell’ esteso sistema culturale del Pci). Se leggiamo la prefazione scritta nel 1939 da Carlo Bo per la prima edizione (1940) delle poesie di Lorca (le Poesie curate da Bo per Guanda videro ben otto edizioni fino al 1961, e poi, dal 1962, cominciò la success story dell’edizione completa in due volumi) non troviamo, com’era inevitabile, alcun cenno alla guerra civile, ma un apprezzamento non privo di riserve formulato in una prosa elusiva: «In una poesia così evidente e di solito addirittura violenta […] si riesce a riconoscere l’idea della forza ma né a calcolarla né a precisarne il disegno». La prefazione del 1945 comincia, invece, così: «Oggi che ci allontaniamo sempre di più dal rumore degli avvenimenti che gli hanno dato una seconda fama […] al contrario di quello che si potrebbe pensare a prima vista, questa poesia tende a radicare sempre più profondamente dentro di noi la sua forza e i caratteri della sua necessità». Bo, che probabilmente riteneva Lorca meno raffinato di un Jiménez, si era in parte ricreduto. Ma proprio quell’estrema evidenza dei colori, quella forza dei suoni, quella libertà di fantasia che lo lasciavano un po’ perplesso devono invece aver affascinato i lettori di quegli anni, che pur non coglievano appieno, né potevano ben cogliere, la complessa trama dei testi poetici di Lorca. E così in una delle poesie più diffuse di Lorca (e incisa da Foà), Romanza sonnambula, troviamo versi non certo trasparenti, come «Con l’ombra nella cintura, / essa sogna al suo balcone / verde carne, capelli verdi / gli occhi di argento verde» (Con la sombra en la cintura / ella sueña en su baranda, / verde carne, pelo verdo, / con ojos de fría plata). Questo verde, una potenza magica che getta i suoi riflessi sulla poesia, che senso ha? Il lettore/ascoltatore resta (o restava?) spaesato, ma qualcosa intuisce (o intuiva?)… Evidentemente Lorca possedeva il duende – citazione ormai virale sul web −, quel potere misterioso che tutti sentono e nessun filosofo spiega, come egli scrive – non riguardo a sé, sia chiaro – nel saggio che abbiamo citato. Il duende sale dalla pianta dei piedi, diceva anche, cioè viene dalla terra, dal sangue, è stile vivente: non è un operare, non è un pensare. E anche i lettori, soprattutto i giovani, appresero la tecnica dello spostamento e dell’allusione; e così il ritornante verso, usurato poi dal consumo, a las cinco de la tarde, che adombrava l’appuntamento con la morte di Ignacio Mejías, il torero letterato, amico caro di Lorca, divenne il romantico richiamo a ogni improcrastinabile impegno esistenziale, una deadline prima della quale occorreva gettare il cuore oltre l’ostacolo.
Il fascino politico-ideologico
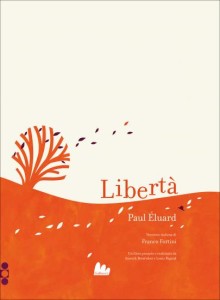 In un’analoga area di pubblico, ma con più ristretta rispondenza, si leggevano, soprattutto nella versione di Franco Fortini, i versi di Éluard, circonfuso della gloria della sua partecipazione alla Resistenza francese (Poésie et vérité raccoglie le poesie ad essa ispirate), comunista di provata fede (ruppe con Breton quando costui si fece trotzkista), dalle originarie istanze surrealiste e dadaiste. Anche i suoi testi ebbero, nel 1962, il privilegio di una lettura d’autore in un disco di Nuova Accademia. Le voci erano quelle di Albertazzi e di Gérard Philipe, il romantico e inquieto interprete del Diable au corps di Claude Autan-Lara, morto pochi anni prima nel suo pieno fulgore artistico. Il primo pezzo era la citata Libertà/Liberté, pervasa da un sincero empito retorico, sottolineato dall’uso anaforico di sur. Ecco una strofa centrale e la sua resa da parte del pur provetto Fortini, a riprova della tendenza nobilitante dei traduttori italiani d’epoca: «Sul decollo della soglia / Su gli oggetti familiari / Su la santa onda del fuoco / Scrivo il tuo nome… Libertà» (Sur le tremplin de ma porte / Sur les objets familiers / Sur le flot du feu béni / J’écris ton nom… Liberté). Altro pezzo forte del disco era la prosastica La dama di quadri (La dame de carreau) col suo immalinconente excipit, che poteva toccare le corde di tutti e di ciascuno: «Le carte han detto che la incontrerò nella vita, ma senza riconoscerla. / Amando l’amore» (Les cartes ont dit que je la rencontrerai dans la vie, mais sans la reconnaître. / Aimant l’amour). Gala, sua moglie e futura musa di Dalí, era stata indubitabilmente una turbolenta dama di quadri. Il linguaggio di Éluard, un parlato in cui gli elementi surrealisti sono tenuti sotto controllo, non era di troppo difficile accesso.
In un’analoga area di pubblico, ma con più ristretta rispondenza, si leggevano, soprattutto nella versione di Franco Fortini, i versi di Éluard, circonfuso della gloria della sua partecipazione alla Resistenza francese (Poésie et vérité raccoglie le poesie ad essa ispirate), comunista di provata fede (ruppe con Breton quando costui si fece trotzkista), dalle originarie istanze surrealiste e dadaiste. Anche i suoi testi ebbero, nel 1962, il privilegio di una lettura d’autore in un disco di Nuova Accademia. Le voci erano quelle di Albertazzi e di Gérard Philipe, il romantico e inquieto interprete del Diable au corps di Claude Autan-Lara, morto pochi anni prima nel suo pieno fulgore artistico. Il primo pezzo era la citata Libertà/Liberté, pervasa da un sincero empito retorico, sottolineato dall’uso anaforico di sur. Ecco una strofa centrale e la sua resa da parte del pur provetto Fortini, a riprova della tendenza nobilitante dei traduttori italiani d’epoca: «Sul decollo della soglia / Su gli oggetti familiari / Su la santa onda del fuoco / Scrivo il tuo nome… Libertà» (Sur le tremplin de ma porte / Sur les objets familiers / Sur le flot du feu béni / J’écris ton nom… Liberté). Altro pezzo forte del disco era la prosastica La dama di quadri (La dame de carreau) col suo immalinconente excipit, che poteva toccare le corde di tutti e di ciascuno: «Le carte han detto che la incontrerò nella vita, ma senza riconoscerla. / Amando l’amore» (Les cartes ont dit que je la rencontrerai dans la vie, mais sans la reconnaître. / Aimant l’amour). Gala, sua moglie e futura musa di Dalí, era stata indubitabilmente una turbolenta dama di quadri. Il linguaggio di Éluard, un parlato in cui gli elementi surrealisti sono tenuti sotto controllo, non era di troppo difficile accesso.
In molte meritorie e modeste biblioteche di sezione del Pci (ora finite tristemente in bancarella, se non in discarica) campeggiavano poi, dal 1958, i quattro volumi delle Opere di Majakovskij con illustrazioni di Renzo Vespignani (o la più breve silloge, Poemi, del 1963), senza testo a fronte, curate dal russista Ignazio Ambrogio, collaboratore e traduttore di fiducia degli Editori Riuniti (Gorkij e Černiševskij, tra gli altri). Soprattutto vi era presente l’intenso, apprezzato anche da Ripellino, Poema di Lenin (Sì, io temo / che processioni e mausolei, / con la regola fissa dell’ammirazione, / offuschino d’aciduli incensi / la semplicità di Lenin; io temo, / come si teme la pupilla degli occhi, / ch’egli venga falsato / dalle soavi bellezze dell’ideale), che, nella traduzione di Mario De Micheli, era uscito, diffuso in migliaia di copie nel 1951 nella anch’essa meritoria «Universale economica» della Colip − la Cooperativa del libro popolare, dal celebre logo del Canguro, fondata nel 1949 dal Pci e poi rilevata nel 1954 da Feltrinelli, che ne fece l’embrione della propria casa editrice. Un primo assaggio di Majakovskij poeta si era già avuto tramite l’antologia Il fiore del verso russo curata da Renato Poggioli per Einaudi nel 1949 e, sempre in un’ottica più letteraria, altri apporti vennero da Ripellino e dalla sua Poesia russa del Novecento (Guanda, 1954). Il volume che più contribuirà alla sua conoscenza tra i lettori comuni sarà forse le Opere scelte, a cura del già citato storico delle avanguardie artistiche del Novecento Mario De Micheli (Feltrinelli, 1967, poi ristampato varie volte, sempre senza l’originale a fronte) con un ventaglio più variegato di testi: comprende anche i satirici, tra cui di grande attualità, a dire il vero, anche nell’Italia postmoderna, l’Inno alla bustarella (1915: «Eccoci qui, umilmente, a cantare le tue lodi, / bustarella amatissima»), La raccomandazione (1926), la Critica dell’autocritica (1928: «Lui stesso / il burocrate sovietico, / si picchia / il petto ministeriale: / I consigli / mi fanno / sempre piacere. / Criticate! / Io non ho boria /[…] / Scrivete / le vostre osservazioni / e inoltratele / per via gerarchica»). Agli occhi dei lettori (di sinistra) di allora Majakovskij godeva del fascino di aver appartenuto alla fase aurorale della rivoluzione e di averne espresso, con grande autonomia passione e originalità, le istanze, e a lui veniva tributato in Urss, e di conseguenza nel Partito comunista italiano, il culto di “massimo poeta della rivoluzione” − obliterando il suo suicidio del 1930 («Per favore non fate pettegolezzi. Il defunto li detestava» lasciò scritto: frase ripresa quasi alla lettera, com’è noto, da Pavese), nonché l’ostilità di cui era stato oggetto con l’affermarsi del regime staliniano e del suo braccio “armato” in campo letterario, la RAPP, l’Associazione degli scrittori proletari. Ma in realtà, per i suoi attacchi allo spirito burocratico presto secreto dal nuovo regime, non godeva certo di affinità elettiva con gli ortodossi, che non apprezzavano neppure troppo la sua stretta connessione con l’avanguardia russa del primo quindicennio del secolo. Insomma Majakovskij era un personaggio ingombrante, odiosamato, o meglio spregiato e pregiato, da critici e lettori, in Urss come in Occidente. A riprova, comunque, della sua − partigiana − popolarità in Italia, anche Majakovskij − insieme a Blok, Esenin, Achmatova, Voznesenskij, Achmadulina e Evtušenko − appare in un disco Cetra del 1966 dedicato alla Poesia russa del ‘900. In particolare, di lui, è presente l’ironica Mania delle riunioni, del 1926, in cui Majakovskij si prende gioco della ben nota patologia da cui furono inesorabilmente afflitti regimi, partiti, sindacati, ma anche movimenti, di sinistra. Dario Fo riprenderà più tardi questo testo, come dal poeta vate e suicida Majakovskij riprenderà il titolo del suo più famoso monologo, Mistero Buffo, e siamo ormai nell’anno di grazia 1969…
E passiamo a Bertolt Brecht, altro nume dell’estinta sinistra. Certo la sua non comune notorietà, come s’è detto, era più legata al teatro (che Einaudi iniziò a pubblicare già nel 1951 nella prima serie dei «Supercoralli») e ai recital poetici e musicali di Milva − con le canzoni basate su partiture di Hanns Eisler o tratte dall’Opera da tre soldi, Ascesa e caduta della città di Mahagonny, Happy End, musicate da Kurt Weill – che non alla produzione poetica, dov’è, in realtà, senza pari più sottile e profondo, schivando la rigidità ideologica e la programmaticità didattica delle pièce. La diffusione della poesia di Brecht in quegli anni fu legata fondamentalmente a due sillogi: quella curata nel 1956 da Roberto Fertonani per la collana «Il Gallo» delle frugali e popolari Edizioni Avanti! (Io, Bertolt Brecht) e quella più vasta, curata nel 1959 da Ruth Leiser e Franco Fortini per gli eleganti e un po’ classisti «Millenni» di Einaudi (Poesie e canzoni), ristampate entrambe numerose volte. Nel 1968, quando la fama di lirico di Brecht si era ormai consolidata, sempre per Einaudi usciranno le traduzioni di Emilio Castellani e Roberto Fertonani delle Poesie 1918-1933 (raccolta completata poi, nel 1977, con Poesie 1933-1956). Che cosa affascinò di Brecht? Quel suo inconfondibile stile anarchico e apparentemente cinico, dalle radici espressionistiche, il suo rifiuto di abbandonarsi all’intimismo e la sua inclinazione, invece, a conferire sempre storicità a sentimenti e situazioni: ma, da tale atteggiamento, ben più forte risaltava, sebbene non esplicito, il senso di rivolta contro tutto ciò che è falso e ingiusto. Ciò non gli impedì di aderire alla Rdt, ma forse sarà opportuno applicare nei suoi confronti l’invito – Gedenkt unsrer / mit Nachsicht:«Pensate a noi / con indulgenza» − che egli rivolge ai lettori in chiusura di Ai posteri/ An die Nachgeborenen, la famosa poesia che inizia con «Veramente io vivo in tempi oscuri! / … / Quale epoca! In essa / Un discorso sugli alberi è quasi un delitto» (Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!/ […] / Was sind das für Zeiten, wo / Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist). Il suo totale rifiuto di ogni trascendenza – «Di queste città resterà: il vento che le attraversa! /… / Sappiamo di essere effimeri / E dopo di noi ci sarà: niente degno di nota (Von diesen Städten wird bleiben: der durch sie Hindurchging, der Wind! / … / Wir wissen, daß wir Vorläufige sind / Und nach uns wird kommen: nichts Nennenswertes) scrive in Del povero B. B. (Vom armen B. B.) – poteva, peraltro, anche suonare disturbante, tanto che nella quarta di copertina di Io, Bertolt Brecht gli editori si sentirono in dovere, sia pure per confutarlo, di riportare il giudizio interrogativo del teologo cattolico Karl Thieme su di lui: «Bertolt Brecht, poeta del diavolo?». E infine non si può non menzionarne la fulminea capacità aforistica, che non risparmiava neppure lui stesso, uomo in mezzo agli uomini: «Ogni mattina, per guadagnarmi il pane, / Vado al mercato dove si smerciano menzogne. / Pieno di speranza, / mi metto in fila in mezzo ai venditori» (Jeden Morgen, mein Brot zu verdienen / Fahre ich zum Markt, wo Lügen gekauft werden. / Hoffnungsvoll / Reihe ich mich ein unter die Verkäufer, Hollywood).
Esule in California, nella Mecca del cinema Bertolt Brecht fu uno dei tanti sceneggiatori comunisti − fossero americani come Dalton Trumbo, o che in America si fossero rifugiati dall’Europa per sfuggire al nazismo − dei quali si prendono amabilmente gioco i fratelli Coen nel loro ultimo e intelligente film, Ave, Cesare! Insomma, di acqua ne è passata tanta sotto i ponti, e colui che voleva sfuggire a ogni illusione era anch’egli forse uno dei tanti illusi. Resta comunque un poeta. E a quei tempi, il suo antiamericanismo non spiaceva nell’area egemonizzata dal Pci, ma non solo in quell’area. Per Brecht gli Usa erano l’emblema del capitalismo dispiegato con le sue leggi feroci, cosa che peraltro − si veda il dramma Nella giungla delle città − stimolava la sua immaginazione. E anche Lorca in Poeta en Nueva York (1929-30) vede nell’America un coacervo di ingiustizie sociali e razziali, ma, soprattutto, di solitudini: «L’aurora di New York geme / sulle immense scale / cercando fra le lische / tuberose di angoscia disegnata. / L’aurora viene e nessuno la riceve in bocca / perché lì non c’è domani né speranza possibile» (La aurora de Nueva York gime / por las inmensas escaleras / buscando entre las aristas / nardos de angustia dibujada. / La aurora llega y nadie la recibe en su boca / porque allí no hay mañana ni esperanza posible). E se Majakovskij nel Ponte di Brooklyn (1925) esaltando il ponte esaltava la modernità dell’America («Lancia, Coolidge, / un grido di gioia! / Per ciò ch’è bello / nemmeno io risparmio le parole»), vi vedeva anche il luogo deputato da cui «i disoccupati / si gettavano/ a capofitto / nello Hudson». L’America era, insomma, per tutti questi poeti, come nell’Italia del dopoguerra, l’ineludibile oggetto di una passione contrastata e contrastante.
L’ampia fascia di pubblico coinvolta da questi poeti era, sì, mossa da suggestioni politiche (la guerra di Spagna, l’antifranchismo, un’idea, vaga, di comunismo, un desiderio di cambiamento) e indirizzata dall’egemonia culturale della sinistra, ma anche era attratta dal fascino di penetrare in territori rimasti a lungo preclusi. Il caso di Lorca è forse il più variegato: sicuramente, qui, oltre alle suggestioni citate e alla potenza del suo verso, agì anche la malia di una riscoperta della Spagna, coi suoi gitani, il suo cante jondo, le sue corride, un fascino esotico arricchito dalla passione civile, un po’ come fu la Grecia per Byron e la sua generazione.
Possiamo, ora, accostarci a un altro poeta, la cui fama cominciò a radicarsi in quegli anni, per diventare col tempo sempre più solida, grazie anche alle successive vicende politiche dell’America Latina e, in particolare del Cile in seguito al famigerato golpe dell’11 settembre 1973. Parliamo di Pablo Neruda, anch’egli divenuto comunista soprattutto sull’onda della guerra civile spagnola che gli ispirò i versi di España en el corazón; ed è davvero interessante notare la profonda influenza spirituale che ebbe questo evento. Di Neruda allora apparvero una scelta di Poesie (Einaudi, 1952 e 1954) tradotte spesso con ottima resa da Quasimodo (ripubblicate poi nel 1965 nella «bianca»); il Canto generale – il poema epico dell’America Latina, che ne ripercorre con passione l’intera storia in un quadro unitario, uscito originariamente nel 1950 −, a cura di Dario Puccini (1955, Guanda); e poi, nel 1963, per Nuova Accademia, Crepuscolario e Venti poesie d’amore e una canzone disperata a cura di Giuseppe Bellini, amico personale di Neruda. Le componenti che favorirono la sua popolarità furono essenzialmente due, quella sensuale/amorosa e quella politica, ma indubbiamente con una prevalenza della prima anche a giudicare dalle registrazioni che ne fecero Albertazzi e Foà. Le scelte caddero in particolare sui Veinte poemas de amor y una canción desesperada pubblicati nel 1924, tra cui il già citato Corpo di donna / Cuerpo de mujer, nella versione di Salvatore Quasimodo: «Corpo di donna, bianche colline, cosce bianche / tu appari al mondo nell’atto dell’offerta. / Il mio corpo contadino selvaggio ti scava…» (Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos / te pareces al mundo en tu actitud de entrega. / Mi cuerpo de labriego salvaje te socava…). In seguito il profilo di Neruda assunse sempre più un tratto civile, senza peraltro farne dimenticare la vena erotica. Sono presaghi i suoi versi del Canto general dedicati al presidente cileno Balmaceda, morto suicida nel 1891, che sembrano anticipare la sorte di Salvador Allende nel 1973: «Ormai è tardi, sente spari / isolati, le grida trionfanti, / le selvagge scorrerie, le urla /dell’“aristocrazia”, ode / l’ultimo suono, il gran silenzio, / e con esso, piegato, entra nella morte» (Es tarde ya, escucha disparos / aislados, los gritos vencedores / el salvaje malón, los aullidos / de la ‘aristocracia’, escucha / el ultimo rumor, el gran silencio, / y entra con él, recostado, a la muerte) e un po’ anche la sua, che morì, stroncato da un infarto, pochi giorni dopo il golpe. Ma per chiudere il quadro, ricollegarci con l’inizio, e ribadire il fascino esercitato da Lorca anche sugli altri poeti, è inevitabile citare qualche verso della sua Oda a Federico García Lorca nella simpatetica versione di Quasimodo: «Quando voli vestito di pesco, / quando ridi con risa di riso preso d’uragano, / quando per cantare scuoti le arterie e i denti, / la gola e le dita, / vorrei morire tanto dolce tu sei» (Cuando vuelas vestido de durazno, / cuando ríes con risa de arroz huracanado / cuando para cantar sacudes las arterias y los dientes, la garganta y los dedos, / me moriría por lo dulce que eres). Detto da un poeta che si autodefiniva melancólico varón varonil («malinconico uomo virile») non può non colpire.
Prévert, i lirici cinesi e l’odiosamata America
Senza dubbio molto letto, negli anni Sessanta − ma ha continuato a esserlo fino a oggi, e tra vaste e trasversali cerchie di lettori come il Neruda d’amore − fu Jacques Prévert. Le sue lievi Poesie uscirono originariamente all’inizio esatto del decennio tra i mostri sacri della «Fenice» di Guanda su proposta di Gian Domenico Giagni, poeta in proprio e soprattutto adattatore e regista radiofonico e televisivo di testi teatrali nonché sceneggiatore cinematografico. Le ristampe furono innumerevoli e si accavallarono convulsamente tra il 1967 e il 1970 (ben nove!). Nel 1965 si aggiunse, poi, a cura di Ivos Margoni, la traduzione per Feltrinelli di Storie e altre storie, tra le sue ultime opere, che vide anch’essa numerose riedizioni. Aggiungiamo che tra il 1992 e il 1996 Prévert verrà accolto – riconoscimento definitivo – nella prestigiosa «Pléiade» di Gallimard. Ma negli anni cinquanta, in Italia, la fama di Prévert era legata soprattutto ai romantici film di cui fu sceneggiatore per Marcel Carné, che venivano continuamente riproposti nelle ultime visioni o nei circoli cinematografici studenteschi, e alle canzoni scritte per la musica di Joseph Kosma, delle quali la più celebre è Les feuilles mortes nell’interpretazione di Yves Montand. Certamente la poesia di Prévert, di spirito pariginamente anarcoide, era una poesia conciliante, nonostante qualche eco surrealista, come, ad esempio, il frequente ricorso all’ipallage (Un vieillard en or avec une montre en deuil: «Un vecchio d’oro con un orologio a lutto», in Cortège / Corteo), e nonostante qualche testo engagé come Ascoltate, gente del Viet-Nam / Entendez-vous, gens du Viet-Nam (1952), dall’incipit in cui riecheggia La Marseillaise:«Ascoltate / Ascoltate gente del Viet-Nam / ascoltate nelle vostre campagne…» (Entendez-vous / Entendez-vous gens du Viet-Nam / entendez-vous dans vos campagnes…), in cui si inneggia a Henri Martin, il militante anticolonialista che fu incarcerato per il suo impegno a fianco della resistenza indocinese contro i francesi. Erano, in effetti, i quadri di vita urbana parigina ad affascinare i lettori, ribadendo il mito di un’eterna Ville Lumière. E d’altronde a Prévert piaceva indugiare ai tavolini dei caffè di boulevard. Un tocco esistenzialista, insomma, e un tocco boulevardier. Non a caso Juliette Gréco, l’eternamente vestita di nero, che godeva tra i giovani e le giovani degli anni cinquanta tanti ammiratori e imitatrici, fu una sua interprete.
Visto che ci occupiamo della lettura della poesia, non possiamo passare sotto silenzio, anche se non si tratta di un testo contemporaneo, il grande successo che ebbe in quegli anni il volume di Liriche cinesi. Tradotto da Giorgia Valensin dalla traduzione inglese di Arthur Waley e pubblicato da Einaudi fin dal 1942, è una sorta di mise en abîme traduttoria. Dove sarà mai l’originale e cosa saranno mai i testi che ci troviamo di fronte? Queste sono le domande sulle quali si soffermava Eugenio Montale nella prefazione. Eppure quelle poesie, frutto di tante mediazioni, possedevano un’aura particolare che assicurò loro un successo paragonabile a quello dell’Antologia di Spoon River. Ne furono vendute migliaia di copie tra le varie successive edizioni nell’«Universale Einaudi» (originariamente era uscito negli «Struzzi») nelle sue proteiformi trasformazioni. Si potrebbe qui riproporre la questione della traducibilità/intraducibilità della poesia, ma la cosa ci porterebbe lontano e, soprattutto, cozzerebbe contro la realtà concreta di quest’opera sino-anglo-italiana. Possiamo semplicemente dire con Jakobson che della poesia è solo possibile una trasposizione creativa. E questo è appunto il caso. Fu probabilmente l’esotismo nello spazio e nel tempo a stimolare curiosità e lettura: si tratta di testi dell’antichissima Cina, un continente culturale allora nuovissimo per l’Italia (malgrado anche noi avessimo avuto tra il 1901 e il 1943 la nostra brava concessione commerciale a Tientsin), che coprono un periodo trimillenario, dal 1753 a.C. al 1273 d.C. Immaginare un successo delle stesse proporzioni oggi in Italia per un testo analogo sconfina nell’ipotesi del terzo tipo. E non solo era letto, se ne parlava pure, magari con un pizzico di civetteria. A questa prima sortita nella Cina tradizionale, Einaudi fece seguire la pubblicazione negli anni cinquanta di alcuni grandi classici della narrativa (Chin P’ing Mei, 1955, a cura di Piero Jahier e Maj-Lis Rissler Stoneman; I briganti, 1956, a cura di Franz Kuhn e traduzione dal tedesco di Clara Bovero; Il sogno della camera rossa, 1958, nella traduzione di Clara Bovero e Carla Pirrone Riccio) risalenti ai secoli XV-XVIII e tutti tradotti da versioni inglesi o tedesche. Sicuramente le composizioni più coinvolgenti sono quelle dei grandi poeti della dinastia T’ang (VII-IX secolo), Li Po , Tu Fu, Po Chu-i. Temi l’amicizia, la ricerca della tranquillità, il vino, la guerra. La domanda inquietante di Montale era: se da sinologi consumati ci trovassimo di fronte agli originali, l’impressione che abbiamo avuto di questi testi nel loro travestimento anglo-italiano potrebbe svanire del tutto? Chissà! Limitiamoci a osservare che il grande poeta modernista Ezra Pound (tradotto anche lui in questi anni seminali) tentò di integrare la sua poesia con ideogrammi lirici cinesi, avvalendosi, in collaborazione col citato Arthur Waley, dei manoscritti dell’orientalista Ernest Fenollosa. Insomma l’incontro con l’Oriente pareva essere nell’orizzonte novecentesco (e anche Yeats ne fu attratto, dal côté giapponese però, e sempre tramite Fenollosa). E, a dire il vero, ci sarà − e a livello di massa −, ma in forme assai meno raffinate culturalmente. Il profeta di Gibran docet.
Ma il successo senza paragone più strepitoso degli anni in cui si leggeva poesia – e che ancora perdura, sebbene in misura più contenuta – è stato incontestabilmente l’Antologia di Spoon River,che uscì dapprima nel 1943, con un’improbabile autorizzazione del Ministero della Cultura Popolare fascista, secondo la testimonianza di Fernanda Pivano che curò la traduzione. Ne furono stampate nelle varie «Universali», senza testo a fronte, ben 22 edizioni già solo fino al 1968: le prime tre (1943, 1945, 1947) dimezzate rispetto all’originale. Nel frattempo Einaudi pubblicò l’Antologia, ma con testo a fronte, anche nei «Millenni» prima (dove si contano dieci edizioni tra il 1947 e il 1963) e poi, a partire dal 1965, nei «Supercoralli». A concepirla fu Edgar Lee Masters, avvocato di Chicago, che la diede alle stampe nel 1915 quando la sua città era subentrata al New England come principale focolaio letterario − prima che lo divenisse, a sua volta, New York. Siamo nel periodo del travolgente sviluppo industriale della città − definita dal whitmaniano Carl Sandburg nei suoi Chicago Poems (parzialmente tradotti nel 1961 da Franco De Poli per le Edizioni Avanti!) «Chicago ventosa, macellaia del mondo» (Hog Butcher for the World / […] / Stormy) − che diverrà poi la capitale, con New York, del famigerato gangsterismo americano dei tempi del proibizionismo. Fu lì che si conobbero Sherwood Anderson, Theodore Dreiser, Edgar Lee Masters e Sandburg. Se a questi aggiungiamo Sinclair Lewis (nato nel Minnesota), abbiamo il nucleo principale di autori che descrissero l’anodina provincia americana e l’uomo medio dell’epoca schiacciato dall’affarismo o suo connivente e mediocre portabandiera: una visione piuttosto desolata e angosciante. Che cosa trovò o poteva trovare in Spoon River il lettore italiano? La stessa Pivano si mostra, nelle prefazioni alle prime edizioni, molto prudente: sembra propendere per una conferma, offerta dall’antologia, della visione negativa, drammatica, della società americana diffusa da noi tra guerra e dopoguerra, per motivi diversi, ma convergenti, dei quali forse lei stessa non era ben consapevole. In seguito incornicerà con maggior precisione l’opera nel suo contesto culturale, mettendone meglio in luce le valenze letterarie. Giustamente, Pivano sottolinea come, del poema, così possiamo tranquillamente chiamarlo, protagonista essenziale fosse, oltre la provincia − con le sue ipocrisie, rimozioni, repressioni, velleità, desideri e vagheggiamenti −, il tempo: e davanti a noi, negli epitaffi, le tante vite descritte si srotolano, in effetti, a partire dal loro punto finale, nel prisma della memoria, narrandoci che siamo fatti di tempo.
Di certo nell’amore per Spoon River non c’erano componenti, sia pur latamente, politiche o civili, come nel caso di gran parte degli altri autori che abbiamo esaminato (e fu proprio questo aspetto a favorirne l’estesa diffusione). C’era, sicuramente, l’attrazione per tutto ciò che veniva d’oltreoceano (attrazione che per l’ambito letterario si era già espressa tramite l’antologia curata da Vittorini nel 1941, Americana). Allora gli italiani, come metterà bene in luce Sciascia negli Zii di Sicilia,fluttuavano, o erano divisi − anche interiormente −, tra due utopie contrapposte, ma che si richiamavano l’un l’altra, all’epoca simboleggiate dalla Russia e dall’America. E il fascino americano aveva trovato potenti mallevadori nel cinema (di cui negli anni della guerra si era dovuto fare malvolentieri a meno) e, per i più raffinati, in due tracimanti opere, il melvilliano Moby Dick, pubblicato già nel 1932 da Frassinelli nella oggi mitica traduzione di Cesare Pavese, e quel Foglie d’erba di Whitman che abbiamo già detto apparsa nel 1950 da Einaudi nella versione di Enzo Giachino (non ne mancava peraltro una precedente versione completa di inizio Novecento a cura di Luigi Gamberale, il quale si era messo all’opera su suggerimento di Giovanni Pascoli). Ma al di là di tutto questo, che cosa si poteva davvero trovare di tanto coinvolgente in Spoon River? Semplicemente la vita vera, concreta e pulsante – pur sotto il velo della malinconia − senza formalismi e senza orpelli, con cui ciascuno poteva confrontarsi. In particolare, Spoon River sgretolava il culto della rispettabilità, la cui potenza pervasiva accomunava l’America provinciale e l’Italia degli anni cinquanta. Lee Masters si era posto come obiettivo di offrire «una rappresentazione epica della vita moderna», con uno stile che era «meno del verso ma più della prosa», e l’aveva centrato. E anche questo suo stile a mezza via (con una lunga tradizione alle spalle), ancorato alle cose, ne rese facile la ricezione: stile, occorre dire, reso con ammirevole semplicità da una Pivano alle prime armi (naturalmente sotto l’egida di Cesare Pavese). Ecco i grandi regali fatti da questo libro come da tanta narrativa americana dell’epoca a un’Italia spesso ancora linguisticamente e letterariamente ingessata o aulica: aderenza alle cose e sobrietà di linguaggio.
Una stagione ormai alle spalle?
Questi, sul filo della memoria e dei riscontri editoriali, erano gli autori e i testi poetici più letti. Qualcosa sicuramente potrà essere sfuggito. Ma il quadro d’insieme tracciato non credo si discosti molto dalla realtà. Che cosa ne emerge? Grandi investimenti di risorse umane ed economiche degli editori nella poesia e, soprattutto, nella conoscenza della grande poesia moderna e contemporanea. Oltre alle traduzioni citate, non si contano nel dopoguerra (talora immediatamente alla fine del conflitto, e quindi si trattava di lavori covati presumibilmente da tempo, negli obbligati ritiri del tempo di guerra) quelle dei padri della lirica moderna, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, autori dei quali esisteva qualche modesta e sparsa versione italiana (in particolare di Baudelaire). Finalmente ci si poteva accostare, senza essere specialisti, a questi fantasticati autori, alle Fleurs du mal, al Bateau ivre, all’Après-midi d’un faune, e sovente col testo a fronte, sia pur in edizioni molto limitate se non addirittura numerate. Così come finalmente, chi voleva, aveva a disposizione l’eliotiana The Waste Land (1922) nella traduzione di Mario Praz (Fussi, 1949) o il sempre eliotiano The Love Song of J. Alfred Prufrock (1917) nella traduzione di Roberto Sanesi (Bompiani, 1963: ma sia l’una che l’altro erano già stati tradotti per Guanda fin dal 1941 da Luigi Berti) o poteva inoltrarsi negli ardui Cantos di Pound − la cui protratta pubblicazione nel tempo era iniziata nel 1917 −, grazie ai Canti pisani editi da Guanda nel 1953, a cura di Alfredo Rizzardi, o grazie al volume edito da Lerici nel 1961, a cura di Mary de Rachewiltz, figlia dell’autore. Accanto e intrecciata alla lettura più diffusa, si sviluppò dunque anche una lettura più consapevole ed esigente. Le due cose andavano di conserva, traendo linfa l’una dall’altra. Tutto ciò fu favorito da una congiuntura politica e culturale particolare che abbiamo sommariamente delineato: l’avidità di aprirsi al mondo dopo l’autarchia di regime e la guerra, il retaggio della guerra di Spagna e della Resistenza, un bisogno di rinnovamento che poteva trarre spunto da un mitizzato comunismo come dalla mitizzata modernità dell’America. E non si dimentichi il ruolo svolto dall’ampio sistema culturale messo in campo dalla sinistra, ivi compresa la casa editrice Einaudi. Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile, lo ribadiamo, senza la fervida attività di tanti editori, traduttori e curatori che in quella particolare atmosfera avevano potuto operare con scelte anche difficili e intransigenti.
Ovviamente si è continuato a pubblicare poesia e a leggerla, ma non si è presumibilmente ripetuta una convergenza di fattori analoga all’esplosione di quegli anni. Nessun poeta, tra gli stranieri (ma neppure tra gli italiani) è diventato altrettanto popolare di un Lorca, né un testo altrettanto pervasivamente presente dell’Antologia di Spoon River, per non citare che i casi più eclatanti. Negli ultimi tempi una poetessa che, per le particolari caratteristiche del suo stile e delle sue tematiche, sembra entrata nel discorso non solo specialistico pare essere Wisława Szymborska, venuta sulla scena in Italia dopo l’ottenimento del Nobel nel 1996. Ma qui occorre fermarsi, magari citando Walter Siti che in un suo recente intervento televisivo a Rai 5 ha parlato di «assenza della poesia», alludendo alla mancanza oggi di voci forti e riconosciute nella poesia, in particolare italiana. Certo, si può supporre che da qualche decennio la voce della poesia, per le nuove generazioni, sia passata e passi soprattutto attraverso i testi musicali. Il fenomeno cominciò, in Italia, negli anni settanta sulla scia dei Sixties americani. Quale testo più eversivo e lancinante di The End di Jim Morrison nel periodo della suggestione psichedelica? Quali versi poi più citati di quelli dei Clash o, se vogliamo fare un nome italiano, di quelli di Fabrizio De André? I nomi qui si farebbero legione e anche qui occorre fermarsi.
Concludiamo accennando ancora a due titoli destinali, comparsi significativamente nella seconda metà degli anni sessanta ormai in dirittura d’arrivo verso i settanta, titoli che godettero, almeno uno dei due, di una straordinaria diffusione: Il Profeta, originariamente uscito nel 1923,del poeta libanese, ma anche anglofono, Khalil Gibran, pubblicato da Guanda nel 1968 , e Jukebox all’idrogeno del poeta beat Allen Ginsberg, pubblicato da Mondadori nel 1965 nella traduzione di Fernanda Pivano, che raccoglie testi usciti negli Usa tra il 1956 e il 1961.
Il Profeta, già tradotto nel 1936 da E. Niosi-Risos per Carabba e poi – nella disattenzione totale dovuta all’invisibilità della casa editrice – nel 1966 da Salvatore Cossu per la Kossu di Roma (in pratica lo stesso traduttore), balzò alla notorietà appena due anni dopo con la traduzione del raffinato poeta Giampiero Bona e la prefazione dell’altrettanto raffinato critico Carlo Bo. Fino al 2002 ha visto ben 21 edizioni nella «Biblioteca della Fenice» (per non parlare delle edizioni SE e Mondadori a cura di Nicola Crocetti, a partire dal 1985). L’eccezionale successo in Italia di questo poema kitsch (che ripeteva i successi libanese e americano) non è davvero passato attraverso le sponsorizzazioni della critica. È un successo che si è fatto da sé, un self-made success, analogo a quello contemporaneo e perdurante, in Italia, del Siddharta di Hermann Hesse tradotto da Massimo Mila fin dal 1945 e poi riproposto in diverse edizioni fino a quella adelphiana oggi corrente. Evidentemente Il profeta rispondeva a un bisogno diffuso, ma represso dalla cultura riconosciuta. Il discorso su questo testo dovrebbe essere più sociologico che non letterario. È certo singolare che il messaggio tanto popolare di Gibran sia passato e passi attraverso una scrittura poetica, certo non complessa, con i suoi dichiarati modelli nell’Antico testamento, in Blake e nello Zarathustra nicciano. Ci si è volutamente avvalsi dell’usurato termine di messaggio, perché si attaglia perfettamente al caso di Gibran, che si era voluto creare, con non poca impostura, una silhouette profetica: lasciando da parte il confuso, ma corroborante, messaggio rivolto agli arabi − ai tempi della loro risentita “miseria” − di una superiorità del misticismo orientale, in tempi di controcultura giovanile piacque (ma continua a piacere ancora adesso, a controcultura estinta) il suo invito alla ricerca spirituale di sé, il suo messaggio sull’amore che si rivela a tutti, ma che non tutti colgono perché «gli occhi e le orecchie della loro anima sono velati dalle illusioni dei sensi e dal rumore della parola», come sintetizza Bona. Indicazioni e ricette semplicistiche per problemi chiaramente molto sentiti. Il successo del guru levantino, come è stato definito da qualcuno, permane, e non possiamo non prenderne atto.
Jukebox all’idrogeno, tradotto da una Pivano convertita alla controcultura americana, comparve dapprima nei «Nuovi scrittori stranieri» di Mondadori, e poi ebbe varie edizioni e ristampe negli «Oscar». Raccoglieva i testi di Howl and other poems (1956) e di Kaddish and other poems (1961), lo struggente omaggio alla madre ebrea morta pazza in una clinica psichiatrica. Non vendette altrettante copie del Profeta, ma l’impatto di Howl (Urlo)– il pezzo più noto della raccolta – sui lettori, e anche sulle nuove forme di poesia, fu di estremo rilievo. Il suo stile si rifà a suggestioni provenienti da Blake, al filone molto americano Whitman-William Carlos Williams, al quale lo univa Paterson: a questa cittadina del New Jersey dove Ginsberg, nato nella vicina Newark, è cresciuto, per coincidenza Williams intitolò il suo capolavoro, un’epopea della medietà uscita in originale tra il 1946 e il 1958 e pubblicata in italiano da Lerici nel 1966 a cura di Alfredo Rizzardi. L’anfetaminico incipit della poesia ce ne fa già intuire il tono generale: «Ho visto le menti migliori della mia generazione / distrutte dalla pazzia, affamate nude isteriche / trascinarsi per strade di negri all’alba in cerca di / droga rabbiosa» (I saw the best minds of my generation destroyed by / madness, starving hysterical naked, / dragging themselves through the negro streets at dawn / looking for an angry fix…). Che cosa c’era di nuovo in questo testo rispetto alla tradizione? Insieme a un’ostentata, ma autentica sincerità, il linguaggio estremamente crudo sul piano sessuale che sdaziava in poesia termini che ne erano stati sistematicamente tenuti fuori in passato, scaraventandoli con violenza contro il lettore o l’ascoltatore (Urlo è un perfetto caso di poesia da performance orale). Era una ricerca estrema di trascendenza attraverso esperienze un tempo considerate basse, o da occultare. Non si risparmia nulla, neanche l’amato Whitman, in A supermarket in California: «Ti ho visto, Walt Whitman, senza figli, vecchio mangione solitario, a frugare fra le carni nel frigorifero e occhieggiare i garzoni del droghiere» (I saw you, Walt Whitman, childless, lonely old grubber, poking among the meats in the refrigerator and eyeing the grocery boys). Cade insomma ogni velo, in una sorta di cupio dissolvi. O, come conclude l’ormai settantenne William C. Williams la sua breve introduzione a Howl (1956): We are going through hell.
Certo, la poesia era cambiata, ed era cambiato anche il suo pubblico. Si aprivano i nuovi scenari degli anni settanta.